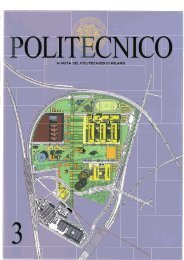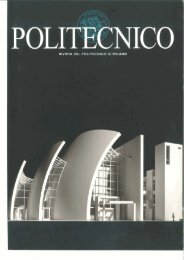POLITECNICO
Scarica il PDF (5174KB) - Rivista Politecnico - Politecnico di Milano
Scarica il PDF (5174KB) - Rivista Politecnico - Politecnico di Milano
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Figura 5 - Mappa numerica di elevazione dell1Etna<br />
ottenuta a partire da 7 coppie d'immagini ERS-I ed<br />
ERS-2.<br />
zione SAR e la successiva, la fase interferometrica<br />
risulta affetta da un rumore casuale. L'entità di questo<br />
rumore viene valutata attraverso le immagii di coeren-<br />
2a cioè della stima del coeffciente di cmss-correlazione<br />
locale delle immagini SAR. In teoria ad ogni pixel delle<br />
immagini è legato un valore di coerenza differente,<br />
ma in pratica, avendo a disposizione solo due immagini<br />
per stimare la coerenza, si suppone che il segnale sia<br />
siazionario in un'area di qualche pixel. La risoluzione<br />
dell'immagine di coerenza è così ridotta rispetto a<br />
quella delle inimagini di partenza. La coerenza è compresa<br />
tra O (retrodiffusori completamente diversi nelle<br />
due immagii come, per esempio, nel caso del mare) e<br />
1 (stessi retrodisori nelle due immagini come, per<br />
esempio, nel caso di rocce esposte). Un esempio di<br />
immagine di coerenza è mostrato in Figura 4.<br />
L'immagine mostra la parte nord orientale della Sicilia<br />
e la coerenza è rappresentata con una scala di grigi che<br />
va dal nero (coerenza nulia) al bianco (coerenza unitaria).<br />
I dati utilizzati sono stati ripresi dai satelliti ERS-<br />
I ed ERS-2 a distanza di un giorno nel settembre del<br />
1995. Si nota come il mare risulti totalmente incoerente,<br />
mentre sull'isola si notano diversi livelli di coerenza,<br />
scarsa nella parte nord più vegetata, elevata<br />
sulllEtna in corrispondenza delle colate di lava che<br />
vengono così chiaramente identificate. La coerenza<br />
varia anche in funzione della situazione climatica. In<br />
generale in aree vegetate la coerenza è più elevata nei<br />
periodi secchi (estivi alle nostre latiiudini) .<br />
Generazione di DEM<br />
Dalla fase interferometrica è possibile risalire alla<br />
mappa di elevazione (relativa) di tutti i pixel. Per ottenere<br />
questo risultato sono necessarie due operazioni:<br />
lo srotolamento della fase interferometrica ("pliase<br />
irriivrappi~ig") la geocodifica del DEM.<br />
La prima operazione si rende necessaria in quanto la<br />
fase interfeminetrica presenta dei salti di 2p che non<br />
sono legati ad un'effetiiva differenza di quota tra pixel,<br />
ma dipendono dalla rappresentazione della fase che è<br />
nota a meno di multipli di 2p. A partire dal 1987, il<br />
gruppo ha sviluppatoz delle tecniche originali di ')/lase<br />
un~~~rappilig" bidimensionali che sfruttano sia<br />
l'informazione di fase sia quella d'ampiezza delle<br />
immagini SAR. Più recentementes il gruppo ha individuato<br />
una tecnica di phase rrriwmpping più affidabile<br />
di quelle %adionali" perchè basata sull'informazione<br />
di fase di più immagini SAR. Inoltre, con più<br />
Figura 6 - Mappa numerica di elevazione dell'Etna<br />
ottenuta a partire da 7 coppie d'immagini ERS- I ed<br />
ERS-2 ascendenti e 3 discendenti.<br />
immagini, si aumenta la percentuale di zone che hanno<br />
alta coerenza nell'una o nell'altra situazione e, conseguentemente,<br />
si riescono ad ottenere DEM di zone più<br />
estese.<br />
Una volta ottenuta una mappa di elevazione in coordinate<br />
SAR, questa deve essere posta in un sistema di<br />
riferimento convenzionale (generalmente UTM) tramite<br />
un'operazione di geocodifica. Un esempio di<br />
DEM della zona dell'Etna generato a partire da 7 cop<br />
pie d'immagini SAR è mostrato in Figura 5.<br />
Owiamente a causa delle deformazioni geometriche<br />
delle immagini SAR, le zone difireslior~eiiirig risultano<br />
essere fortemente interpolate e di scarsa affidabiliti.<br />
Per ovviare a questo inconveniente sono state<br />
combinate mappe di elevazione ottenute con coppie<br />
d'immagini SAR riprese durante passaggi sia ascendenti<br />
(da Sud a Nord) sia discendenti (da Nord a Sud)<br />
dei satelliti ERS-1 ed ERS-2. Le deformazioni geome<br />
triche nei due casi sono quasi complemen!ari (nei passaggi<br />
ascendenti l'antenna è puntata verso Est, in quelli<br />
discendenti verso Ovest) quasi tutta la superficie di<br />
una zona montuosa come quella dell'Etna t rappresentata<br />
con buon dettaglio.<br />
La mappa di elevazione di Figura 6 mostra il risultato<br />
di questa combinazione. Nella stessa figura sono<br />
mostrate un'immagie SAR ascendente e una discendente<br />
per mettere in risalto le differenti deformazioni<br />
geometriche. L'accuratezza di elevazione valutata<br />
indipendentemente dall'ESA è risultata essere di cima<br />
8 metri. Un problema non trascurabile nella generazione<br />
dei DEM con immagini SAR non simultanee (come<br />
nel caso di ERS-1 ed ERS-2) è quello del cambiamento<br />
del contenuto di vapor d'acqua nella troposfera tra<br />
un'osservazione e I'altra e10 tra una zona e l'altra nella<br />
stessa osservazione.<br />
Questi fenomeni causano delle variazioni locali della<br />
lunghezza d'onda del sistema e, conseguentemente,<br />
degli artefatti topografici. Ancora una volta l'uso di<br />
più immagini interferometriche è d'aiuto per ridurre<br />
questi effetti.<br />
Il gruppo ha messo a punto una tecnica basata sull'elaborazione<br />
multi-risoluzione degli interferogrammi<br />
SAR (filiraggio wavelet bidimensionale) per stimare la<br />
potenza degli artefatti atmosferici sulle singole coppie<br />
interferomemche. In base a queste stime è possibile<br />
trovare la miglior combinazione lineare delle siigole<br />
coppie interferometriche per ridurre al minimo gli<br />
effetti atmosf&cis.<br />
Misura di moti crostali<br />
Se la topografia è nota, il suo contributo alla fase interferomeirica<br />
può essere eliminato. Il residuo di fase<br />
interferomeirica può essere messo in relazione a piccoli<br />
sposiamenti relativi della superficie tmtre nella dizione<br />
del satellite. Nel caso dei satelliti ERS-I ed ERS-<br />
2, per esempio, uno spostamento relativo di 2.8 cm<br />
(pari a meta della lunghezza d'onda del sistema) produrrebbe<br />
una variazione di fase interferomeirica di 2p.<br />
Se la coereuza nella zona d'interesse è sufficientemente<br />
elevata, si capisce come questa tecnica sia in grado<br />
di misurare movimenti di pochi millimetri. II gruppo<br />
ha verificato sperimentalmente questa possibilità proponendo<br />
nel 1992 un esperimento controllato sulla'area<br />
di Bonn in collaborazione con I'ESA per la pianificazione<br />
delle accensioni del satellite ERS-I e I'università<br />
di Stoccarda per la preparazione dell'esperimento<br />
a terra.<br />
Nell'espehento di Bonn il gruppo di Stoccarda ha<br />
collocato su un terreno agricolo diciannove riflettori<br />
molto brillanti (comer reflectors) e quindi ben identificabili<br />
sull'immagine SAR. La scena è stata ripresa<br />
dieci volte nel mese di Marzo del 1992 e nel Frattempo<br />
due riflettori sono stati spostati verticalmente di un<br />
centimetro. Dall'elaborazione delle dieci immagini<br />
SAR, il gruppo di Milano ha correttamente identificato<br />
quali riflettori erano stati mossi e di quanto con un<br />
errore di 2 millimetri. La tecnica è stata poi applicata<br />
dal gruppo per rilevare fenomeni naturali come nel<br />
caso delle grossa Frana di St. Etienne de Tinee poco a<br />
nord di Nim. in figura 7 è mostrata la singola immagine<br />
SAR ripresa da ERS-I; la zona interessata dalla<br />
Frana è evidenziata nel riquadro. In Figura 8 è invece<br />
Figura 7 - Immagine SAR ERS- I della zona interessata<br />
dalla frana di St. Etienne de Tinee.<br />
Figura 8 - Fase interferometrica ottenuta da due<br />
immagini SAR ERS-I riprese a distanza di 9 giorni.<br />
Nei riquadro sono ben visibili le frange causate dalla<br />
deformazione superficiale awenuta in seguito al moto<br />
franoso.