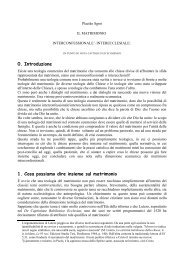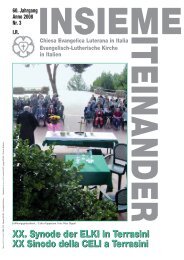Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
Il dialogo ecumenico e interreligioso: quale futuro? - Nemesistemi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
FARE IL PUNTO OGGI: COME IMPOSTARE IL SEGUITO NEL E OLTRE IL DIALOGO ,<br />
FUORI DELLE FRONTIERE STABILITE E DELL APPARTENENZA INIZIALE<br />
Qualche accenno di riflessione ecclesiale può essere proposto anche su questa dimensione<br />
del <strong>dialogo</strong>, il <strong>quale</strong> rinvia urgentemente a ciò che deve seguirlo. La liturgia romana, nel primo anno<br />
(A) della terna liturgica, evoca suggestivamente l avvio della risposta di conversione all iniziativa<br />
di Gesù, dopo il suo Battesimo, e sulle priorità che Egli suggerisce dal Suo modo di portare avanti<br />
la Sua missione. Nella terza domenica del tempo ordinario, le letture ci guidano in una meditazione<br />
su questo avvio o preambolo per la costituzione al seguito del Cristo della originaria comunità che<br />
lo accompagna. <strong>Il</strong> Vangelo comprende quattro chiavi che impostano l avvio dell iniziativa di Dio in<br />
Cristo (Vangelo di quella domenica - Mtt 4, 12-23): Gesù inizia dopo che Giovanni il Battista è<br />
sottratto alla sua missione, egli comincia il suo percorso in Galilea, egli chiama poi i primi seguaci a<br />
seguirlo senza indugio, infine egli passa dalla prassi di pentimento presso il Giordano alla visita<br />
nelle sinagoge predicando la Buona Novella e curando i malanni in seno al popolo. Gesù lascia che<br />
si compia la fase di passaggio di Giovanni il Battista, con quella pazienza che sorge dalla vita<br />
vissuta nelle urgenze che si presentano. Egli sceglie il suo quadro di partenza: Galilea delle genti<br />
e Cafarnao, crocevia delle nazioni (cfr 1° lettura - Is 8, 23b<br />
20<br />
9, 3), l orizzonte esce ormai dal<br />
Tempio e dalle frontiere stabilite per il popolo della Legge. Poi Cristo chiama a seguirLo subito,<br />
senza indugio in ciò che sta per essere ulteriormente portato a termine con i primi seguaci (Andrea-<br />
Pietro, Giovanni-Giacomo) che lasciano le loro cose. Infine Gesù sceglie non di battezzare ma di<br />
dare l indirizzo di partenza nelle sinagoghe, proclamando la Buona Novella. La seconda lettura (I<br />
Cor. 1, 10<br />
13, 17) accenna alle appartenenze battesimali ed avverte intanto di non limitare subito<br />
ciò che si inizia alla sola procedura già compiuta, sorgente di divisioni nel mancato respiro di<br />
lungimiranza: appartengo a Paolo, Apollo, Cefa . Cristo non si limita alla prassi del<br />
battesimo ma prepara ad impegni ben più aperti (I Cor 13, 17), dal crocevia dei popoli (Is 8, 23b).<br />
Dalla domenica del Battesimo di Gesù alla seconda domenica del tempo ordinario la coscienza<br />
ecclesiale, che si esprime nella scelta e nell abbinamento delle letture e del loro insegnamento,<br />
traccia così la promessa ma anche una certa metodologia della via cristiana ecclesiale. Da questo<br />
insegnamento liturgico possiamo trarre gli orientamenti stessi per il <strong>dialogo</strong> di conversione.<br />
III<br />
NEL DIALOGO UN SEGNO DEI TEMPI SVELATO NELLA<br />
PERSONA UMANA: NELLA CONSAPEVOLEZZA DELL ALTERITÀ,<br />
NELLA PRECONDIZIONE DELLA RELAZIONALITÀ, NEL<br />
LINGUAGGIO, NEL DIALOGO PUBBLICO, NEL RELIGARE<br />
RELIGIOSO<br />
In senso prettamente cristiano, si parla di segno dei tempi per indicare quella anticipazione<br />
umana di ciò che potrà essere recepita dall intento cristiano e di cui rimane debitore. Parlando del<br />
cambiamento radicale che il concilio Vaticano II ha introdotto nella praxis e nella coscienza<br />
ecclesiali, ciò che maggiormente risalta nei commenti è la novità di 'metodo' 1 . Questa 'novità' non<br />
1 G. G. Higgins, Commentary on the Pastoral Constitution of the Church in the modern World, in V. A. Yzermans, American Participation in the<br />
Second Vatican Council, New York 1967, pp. 263-264: «Thus to contrast Gaudium et Spes with the Syllabus of Errors as dramatic symbols of their<br />
respective eras in the modern history of the Church, is not to make light of the problems which bedeviled the reign of Pius IX and ultimately<br />
prompted him, with his back to the wall, to fulminate against the world of 1864 in the latter document, nor is it to ignore the providential changes<br />
which made it not only possible, but absolutely necessary for Vatican II to take a much more conciliatory approach in the former document a century<br />
later. Whatever of that, it is fair to say, in the words of Ernesto Balducci, that, with Pope John's opening address at the Council, a whole era of the<br />
history of the Church is solemnly ... declared closed, and that from that moment the Church has achieved a new consciousness of herself. The<br />
Conciliar assembly, receiving such a peremptory warning (against undue severity in its judgment of the contemporary world), far from feeling<br />
dismay, rejoiced to hear itself thus freed from a fear complex, and from perplexities concerning possible schemes for the future... The voice of her<br />
Head ... brought to the light of day her unconscious intuitions and turned the inarticulate depths of her aspirations into an explicit idea. And in this<br />
way there began to take shape, in the most fitting place and manner, a new era of Christianity, which we might call the ecumenical era».