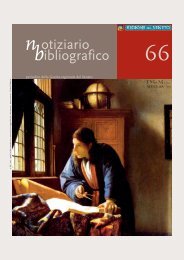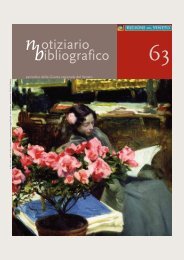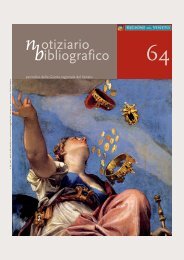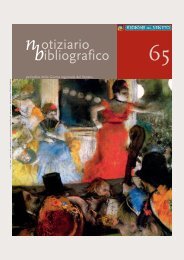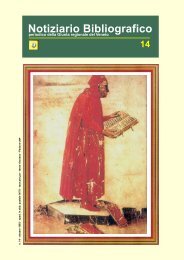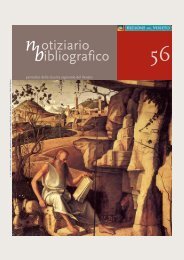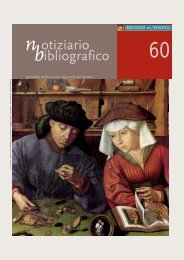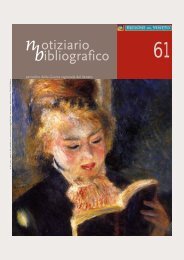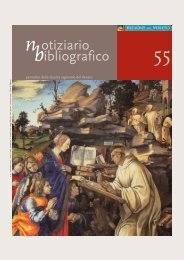nb - Il Poligrafo
nb - Il Poligrafo
nb - Il Poligrafo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
immagini tratte da<br />
La chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Venezia...<br />
La chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Venezia.<br />
Un tempio benedettino “ritrovato” alla<br />
Giudecca. Storia, trasformazioni e conservazione,<br />
a cura di Claudio Spagnol, Venezia, Marsilio,<br />
2008, 4°, pp. 334, ill., DVD all., s.i.p.<br />
Narra un manoscritto secentesco di Pietro<br />
Petrelli, dedicato alla comunità benedettina<br />
osservante dei Santi Cosma e Damiano alla<br />
Giudecca, che il complesso monastico ebbe<br />
un “quasi prodigioso principio”. L’autore<br />
infatti riferisce di tale Lena che, ispirata da<br />
Dio, donò la sua abitazione e un terreno<br />
adiacente alla fondatrice dell’ente, Marina<br />
Celsi, già badessa dei monasteri di San Matteo<br />
a Murano e di Sant’Eufemia a Mazzorbo,<br />
dopo averla vista aggirarsi per l’isola in<br />
cerca di un segnale divino a conferma delle<br />
sue intenzioni.<br />
La storia di Petrelli, spogliata degli elementi<br />
favolistici, trova riscontro nell’atto notarile<br />
datato 30 aprile 1481 e conservato nell’archivio<br />
del monastero, in virtù del quale Elena,<br />
vedova di Giovanni Pietro Del Fradello,<br />
cedette una casa con corte, pozzo e annesso<br />
terreno a Marina Celsi per la costruzione di<br />
un monastero dedicato ai Santi Cosma e<br />
Damiano, con la richiesta che nel nuovo<br />
edificio le fosse riservata una stanza dove<br />
poter vivere.<br />
La bolla pontificia del 17 maggio 1481 sancisce<br />
l’adesione di Sisto IV al progetto della<br />
Celsi, la quale gode anche del sostegno del<br />
doge Giovanni Mocenigo. I lavori di costruzione<br />
iniziano pochi mesi più tardi con la<br />
cerimonia della posa della “prima pietra”<br />
celebrata dal patriarca il 20 luglio. Altri benefattori<br />
contribuiscono negli anni all’incremento<br />
del patrimonio del monastero,<br />
che può in tal modo rispondere alla maggiore<br />
richiesta di monacazioni – dovuta all’aumento<br />
demografico e alla crescita delle<br />
doti matrimoniali verificatisi nella seconda<br />
metà del XV secolo – e dare seguito all’esigenza<br />
di rinnovamento religioso fortemente<br />
sentito dalla comunità. Con l’atto notarile<br />
sottoscritto nel giugno 1487, le stesse monache<br />
donano tutti i loro beni alla Celsi che<br />
li riceve in veste di badessa. Prosegue nei<br />
decenni successivi l’espansione del monastero<br />
con l’acquisto di nuovi terreni. All’inizio<br />
degli anni novanta del Quattrocento risulta<br />
ultimata la prima chiesa, cui seguirà<br />
entro la prima metà del Cinquecento il nuovo<br />
e più grande edificio sorto tra tormentate<br />
vicissitudini in quello stesso luogo che<br />
Marina Celsi aveva indicato nel suo testamento<br />
spirituale del 1508, a quindici anni<br />
dalla morte.<br />
All’“ecclesia pulcherima”, lodata dai contemporanei<br />
per l’essenzialità della sua architettura,<br />
e ai recenti lavori di restauro che<br />
ne hanno reso possibile la restituzione alla<br />
cittadinanza, è dedicato il presente volume<br />
recensioni e segnalazioni<br />
che, con l’ausilio di un ricco apparato iconografico<br />
e di un suggestivo filmato in<br />
DVD, raccoglie nelle tre sezioni in cui è articolato<br />
(Le vicende storiche, Le opere di conservazione,<br />
Apparati) numerosi contributi<br />
scientifici. Essi testimoniano l’affascinante<br />
combinazione di memoria e innovazione<br />
che ha portato l’edificio a nuova vita quale<br />
moderno “incubatore di imprese”, dopo<br />
l’utilizzo improprio del complesso tra Ottocento<br />
e Novecento: fu caserma, ospedale,<br />
fabbrica di sale agrario e opificio tessile.<br />
| Clara Pagnacco |<br />
<br />
MARA GARDIN - EUGENIO MARIN, Boldara e la<br />
chiesetta della Visitazione, Gruaro (VE), Comune<br />
di Gruaro, 2007, 8°, pp. 94, ill., s.i.p.<br />
La pubblicazione raccoglie i contributi di<br />
Eugenio Marin e Mara Gardin dedicati rispettivamente<br />
alla storia dell’Oratorio della<br />
Visitazione di Boldara e al ciclo di affreschi<br />
che ne decora le pareti. Come sottolineano<br />
il Sindaco e l’Assessore alla Cultura del Comune<br />
di Gruaro nella loro presentazione, il<br />
volume potrebbe considerarsi la fase preparatoria<br />
agli auspicati e imminenti lavori di<br />
restauro di cui necessitano l’edificio e in particolare<br />
le sue decorazioni, che versano in<br />
uno stato di conservazione assai precario.<br />
<strong>Il</strong> saggio di Marin è introdotto da un breve<br />
excursus sulle origini della comunità di Boldara,<br />
testimoniata per la prima volta in un<br />
documento risalente al 1182. Nulla è dato<br />
sapere a quella data del numero di abitanti<br />
e nemmeno dell’esistenza di un edificio di<br />
culto. Le prime notizie documentali relative<br />
all’oratorio della Visitazione compaiono<br />
molto più tardi, nel XVII secolo, sebbene sia<br />
ipotizzabile un’origine di gran lunga precedente.<br />
<strong>Il</strong> luogo stesso in cui sorge, sulla<br />
strada che collega Portogruaro e Gruaro,<br />
nei pressi di un incrocio, rafforza tale ipotesi<br />
poiché ha tutte le caratteristiche di una<br />
pratica di sacralizzazione che affonda le<br />
proprie radici in tempi lontani. Con maggiore<br />
sicurezza si può affermare che il sacello<br />
oggi visibile è la ricostruzione di un<br />
precedente edificio, come dimostrano i resti<br />
rinvenuti sotto la pavimentazione attuale.<br />
Un indizio che potrebbe indicare il periodo<br />
di fondazione della chiesetta è rintracciabile<br />
nel titolo cui essa è consacrata: la Visitazione<br />
di Maria a santa Elisabetta, solennità<br />
introdotta nel calendario liturgico da papa<br />
Urbano VI nel 1389.<br />
Databili con certezza sono invece gli affreschi,<br />
cui è dedicata la seconda parte del volume<br />
a cura di Mara Gardin. L’iscrizione su<br />
una delle pareti riporta l’anno 1646 e il<br />
notiziariobibliografico59 31