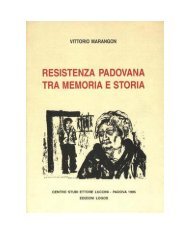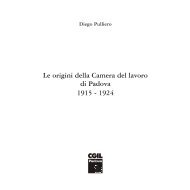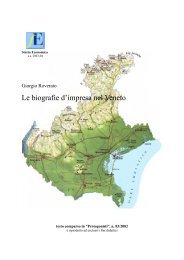La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>La</strong> <strong>didattica</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> <strong>attraverso</strong> <strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong><br />
Essa, infine, è strettamente connessa alla memoria <strong>della</strong> col<strong>le</strong>ttività.<br />
Così, in una ricerca sulla memoria loca<strong>le</strong> è necessario affrontare prob<strong>le</strong>mi<br />
<strong>le</strong>gati al<strong>le</strong> diverse visioni del mondo e all’influenza degli stereotipi<br />
<strong>della</strong> memoria col<strong>le</strong>ttiva sulla memoria individua<strong>le</strong>. Si può verificare l’adesione<br />
col<strong>le</strong>ttiva a un modello interpretativo del passato che produce<br />
un’identità comune di riferimento (autoce<strong>le</strong>brazione di una comunità,<br />
esaltazione del passato, autodenigrazione del presente, filtri che non<br />
lasciano passare ciò che “offende” la maggioranza dei membri <strong>della</strong> comunità,<br />
che allontanano da sé il negativo, eccetera).<br />
Un ulteriore aspetto ri<strong>le</strong>vante attiene al linguaggio, alla parola, al<br />
racconto. <strong>La</strong> comunicazione ora<strong>le</strong> ha norme, codici, linguaggi, che non<br />
sono una semplice trasposizione <strong>della</strong> cultura scritta e dei quali occorre<br />
essere consapevoli<br />
3. Le <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong>: metodi di lavoro<br />
Nell’affrontare una ricerca sul<strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong> può essere uti<strong>le</strong> procedere<br />
ad una prima classificazione del<strong>le</strong> stesse, identificando<strong>le</strong> e suddividendo<strong>le</strong><br />
entro <strong>le</strong> tipologie al<strong>le</strong> quali appartengono, come, ad esempio,<br />
testi formalizzati (etnotesti - canti, favo<strong>le</strong>); testimonianze su un aspetto<br />
di vita col<strong>le</strong>ttiva (alimentazione, scuola); testimonianza fattua<strong>le</strong> su un<br />
evento; periodi di vita del testimone (la Resistenza, la prigionia, il ‘68);<br />
<strong>storia</strong> di vita (autobiografie e tranche de vie); testimonianza contemporanea<br />
agli eventi.<br />
Una volta definita la natura del “materia<strong>le</strong> ora<strong>le</strong>”, si procede rispettando<br />
alcune direttrici di lavoro. Innanzittutto vanno esplicitati i criteri<br />
di scelta del campione sulla base dell’oggetto e dello scopo <strong>della</strong> ricerca,<br />
evitando di generalizzare i risultati, percependo piuttosto <strong>le</strong> differenze e<br />
<strong>le</strong> comp<strong>le</strong>ssità, individuando i testimoni e gli intermediari, conferendo<br />
la giusta importanza ai diversi soggetti (ad esempio, la memoria autobiografica<br />
del<strong>le</strong> donne, anche per temi tipicamente “maschili” come la<br />
guerra e la politica).<br />
<strong>La</strong> traccia, predisposto per guidare l’intervista, non per sottoporre<br />
l’intervistato a un “interrogatorio”, deve poi definire i temi, <strong>le</strong> scelte di<br />
campo, formulare <strong>le</strong> ipotesi, <strong>le</strong> domande (l’operazione storiografica è<br />
produzione consapevo<strong>le</strong> di memoria) e valutare l’importanza <strong>della</strong> contestualizzazione<br />
storica e quindi <strong>della</strong> conoscenza degli eventi rispetto al<br />
campo tematico oggetto dell’indagine.<br />
18<br />
19<br />
Cap. 1 – <strong>La</strong> <strong>didattica</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong><br />
4. Fonti <strong>orali</strong>, processo di apprendimento, ri<strong>le</strong>vanza <strong>didattica</strong><br />
<strong>La</strong> <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong>, in quanto momento di incontro e dialogo tra due<br />
persone, costituisce non solo, e non tanto, un’occasione di acquisizione<br />
di conoscenza ma anche, e soprattutto, un’opportunità di apprendimento.<br />
Nella conversazione, nel confronto, nel parlare, <strong>le</strong> differenze<br />
sociali, di istruzione forma<strong>le</strong> tra intervistato ed intervistatore si stemperano<br />
fino ad annullarsi o, addirituttra, a capovolgersi a sfavore di<br />
quest’ultimo.<br />
È, infatti, chi chiede, chi domanda, chi interroga colui che necessita<br />
di nuova conoscenza, di sapere, di capire dall’altro.<br />
Per tali ragioni l’ascolto è la competenza fondamenta<strong>le</strong> dello storico<br />
ora<strong>le</strong>, una capacità alla qua<strong>le</strong> non si può rinunciare ed il cui valore travalica,<br />
naturalmente, i confini <strong>della</strong> disciplina e del momento dell’intervista<br />
per divenire un carattere intimo e distintivo <strong>della</strong> persona,<br />
prezioso in innumerevoli occasioni di vita e di lavoro.<br />
Come afferma A<strong>le</strong>ssandro Portelli, «questa esperienza ha dato forma<br />
anche al mio lavoro di insegnante, aiutandomi a ricordare che gli studenti<br />
possiedono esperienze, abilità, conoscenze (per esempio, nel campo<br />
musica<strong>le</strong> o nell’informatica) superiori al<strong>le</strong> mie. Posso imparare qualcosa<br />
da loro, e insegnare meglio quello che so, se comincio applicando<br />
all’insegnamento la tecnica fondamenta<strong>le</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong>: l’ascolto» 7 .<br />
L’umiltà di chi impara ad apprendere diviene così un requisito essenzia<strong>le</strong><br />
per ogni persona che, come lo storico ora<strong>le</strong>, ricerchi in primo luogo<br />
il dialogo. <strong>La</strong> vicinanza umana insita nel rapporto fondato sull’ascolto,<br />
sulla comprensione, sulla reciproca apertura, sul superamento del<strong>le</strong><br />
barriere di classe, di gerarchia, di “sapere forma<strong>le</strong>”, modifica allora,<br />
oltre al tradiziona<strong>le</strong> rapporto tra fautore e scrittore <strong>della</strong> <strong>storia</strong>, anche<br />
quello tra persone comuni e concetto stesso di <strong>storia</strong><br />
<strong>La</strong> <strong>storia</strong> è spesso percepita, in contesti scolastici tradizionali, come<br />
una materia inuti<strong>le</strong> e astratta che si occupa di passati morti e persone<br />
scomparse. <strong>La</strong> <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong> aiuta a sentire che la <strong>storia</strong> accade a<br />
persone come noi, a individui comuni, in contesti familiari e quotidiani,<br />
e che in questo modo la <strong>storia</strong> dà forma in modi molto concreti<br />
e tangibili a quello che diventiamo e al<strong>le</strong> nostre esperienze. Ma<br />
questo non va<strong>le</strong> solo in termini ricettivi: facendo vedere il ruolo<br />
7 ALESSANDRO PORTELLI, Storia ora<strong>le</strong> come scuola, in “memoria/memorie”, 1 (2006),<br />
numero monografico intitolato <strong>La</strong> memoria che resiste, pp. 15-17.