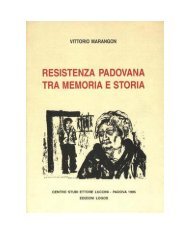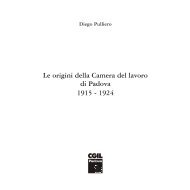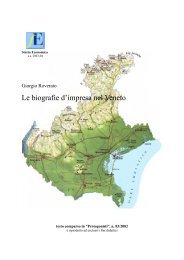La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>didattica</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> <strong>attraverso</strong> <strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong><br />
tema e verificare la disponibilità del<strong>le</strong> persone contattate ad essere intervistate.<br />
Non vi è stata quindi una se<strong>le</strong>zioni a monte dei testimoni, ma si è data<br />
voce a tutti coloro che avevano offerto la propria disponibilità.<br />
2.6 - Specificità <strong>della</strong> fonte ora<strong>le</strong><br />
<strong>La</strong> raccolta di <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong> come e<strong>le</strong>mento fondante per la realizzazione<br />
di un progetto di studio di <strong>storia</strong> loca<strong>le</strong> presuppone la conoscenza dei<br />
meccanismi reconditi <strong>della</strong> memoria e <strong>della</strong> rielaborazione del passato<br />
da parte del testimone, ma richiede altresì la capacità di interagire con<br />
l’intervistato, di creare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto. <strong>La</strong><br />
fonte ora<strong>le</strong> si costruisce, non preesiste. Per questo motivo è importante<br />
che docenti e studenti comprendano la peculiarità <strong>della</strong> fonte ora<strong>le</strong>. Vediamo<br />
alcuni tratti di ta<strong>le</strong> specificità:<br />
a) <strong>La</strong> doppia soggettività. È importante ricordare come si manifesti<br />
sempre un’interferenza reciproca tra intervistatore e intervistato<br />
e come sia illusorio pensare di eliminarla <strong>attraverso</strong> questionari<br />
chiusi. Ogni intervista è produzione (e non prodotto statico) di un<br />
discorso, ed è necessario uno spazio di distanza tra intervistato e<br />
intervistatore, per consentire l’esercizio critico e autocritico. Si deve<br />
stabilire una relazione sulla base del rispetto del testimone e del<br />
“patto” che si viene a stabilire tra intervistatore e intervistato: esplicitare<br />
<strong>le</strong> finalità <strong>della</strong> ricerca, rispettare <strong>le</strong> condizioni e <strong>le</strong> richieste<br />
del testimone ecc.<br />
b) L’attendibilità. Occorre essere consapevoli <strong>della</strong> dinamica <strong>della</strong><br />
memoria e <strong>della</strong> soggettività di chi racconta (il peso del “dopo”, del<strong>le</strong><br />
circostanze in cui si produce il racconto, dei condizionamenti<br />
interni e esterni). Nel racconto autobiografico, ad esempio, si manifestano<br />
meccanismi di difesa e rimozione. Occorre saper decodificare:<br />
l’attendibilità è sostanzialmente un prob<strong>le</strong>ma di interpretazione.<br />
c) Linguaggio, parola, racconto. <strong>La</strong> comunicazione ora<strong>le</strong> ha <strong>le</strong> sue<br />
norme, i suoi codici, i suoi linguaggi, che non sono una semplice<br />
trasposizione <strong>della</strong> cultura scritta. Occorre essere consapevoli dei<br />
principali meccanismi <strong>della</strong> trasmissione e <strong>della</strong> cultura ora<strong>le</strong>, dei<br />
ruoli del racconto di sé e <strong>della</strong> narrazione nella vita quotidiana.<br />
d) Tipologia del<strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong>. È sempre uti<strong>le</strong> un esrcizio di chiarezza<br />
e di distinzione sul<strong>le</strong> diverse forme tipologiche <strong>della</strong> fonte. Esem-<br />
42<br />
Cap. 2 – L’uso del<strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong> per la <strong>storia</strong> loca<strong>le</strong><br />
plificando:<br />
1. testi formalizzati <strong>della</strong> tradizione ora<strong>le</strong> (etnotesti: canti, favo<strong>le</strong><br />
ecc.);<br />
2. testimonianza fattua<strong>le</strong> su un singolo evento;<br />
3. testimonianze circoscritte a un singolo aspetto di vita col<strong>le</strong>ttiva<br />
(alimentazione, istruzione, religione ecc.);<br />
4. periodi di vita del testimone (tranche de vie: la Resistenza, la<br />
prigionia, il ‘68 ecc.);<br />
5. <strong>storia</strong> di vita in senso lato (autobiografie e tranche de vie);<br />
6. testimonianza contemporanea agli eventi (ad esempio, dichiarazioni,<br />
commenti, interviste su fatti di cronaca e attualità).<br />
Produrre <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong> e lavorare con esse implica il rispetto di alcune<br />
precise norme metodologiche:<br />
a) esplicitare i criteri di se<strong>le</strong>zione del campione sulla base dell’oggetto<br />
e dello scopo <strong>della</strong> ricerca. Individuare i testimoni, gli intermediari.<br />
b) formulare un questionario o traccia (deve guidare l’intervista, non<br />
si deve sottoporre l’intervistato a una sorta di interrogatorio). Occorre<br />
definire i temi, <strong>le</strong> scelte di campo, formulare <strong>le</strong> ipotesi, <strong>le</strong><br />
domande (operazione molto importante dal punto di vista didattico,<br />
in quanto può esplicitare un principio fondamenta<strong>le</strong>, ovvero che<br />
l’operazione storiografica è produzione consapevo<strong>le</strong> di memoria).<br />
Non si deve dimenticare l’importanza <strong>della</strong> contestualizzazione storica<br />
e quindi <strong>della</strong> conoscenza degli eventi riguardanti il campo tematico<br />
oggetto dell’indagine;<br />
c) “saper ascoltare”: è fondamenta<strong>le</strong> l’educazione all’ascolto del<strong>le</strong><br />
esperienze autobiografiche; bisogna essere consapevoli del<strong>le</strong> “astuzie”<br />
del testimone che si mo<strong>della</strong> sul<strong>le</strong> aspettative dell’intervistatore.<br />
Rivestono grande importanza l’ambiente, il ruolo del testimone<br />
e dell’intervistatore;<br />
d) strumenti di corredo. È indispensabi<strong>le</strong> compilare una scheda con<br />
i dati sul testimone, sul<strong>le</strong> modalità del colloquio;<br />
e) la trascrizione. Lo strumento principa<strong>le</strong>, la fonte per eccel<strong>le</strong>nza è<br />
il nastro, la registrazione, il fi<strong>le</strong> informatico. <strong>La</strong> trascrizione è un illusorio<br />
sostituto dell’interpretazione soggettiva, inevitabi<strong>le</strong> nel passaggio<br />
dall’<strong>orali</strong>tà alla scrittura, tuttavia essa deve essere rigorosa,<br />
rispettando fedeltà e <strong>le</strong>ggibilità. Ogni trascrizione è una sorta di<br />
traduzione, in quanto rappresentazione scritta del testo ora<strong>le</strong>. Tutte<br />
43