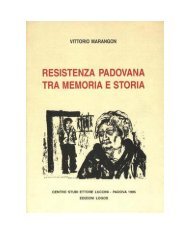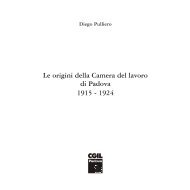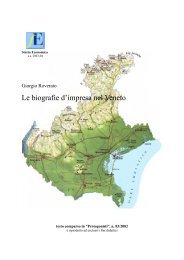La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
La didattica della storia attraverso le fonti orali - Centro Studi Ettore ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>La</strong> <strong>didattica</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> <strong>attraverso</strong> <strong>le</strong> <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong><br />
A questo punto il metodo storico si era aperto ad ogni aspetto <strong>della</strong><br />
realtà. <strong>La</strong> quotidianità venne sempre più vista non come e<strong>le</strong>mento di<br />
scarso valore, bensì come fondamenta<strong>le</strong> indicatore del<strong>le</strong> grandi relazioni<br />
che definivano la società ed il suo divenire. <strong>La</strong> “vita norma<strong>le</strong> del<strong>le</strong> persone<br />
comuni” venne compresa qua<strong>le</strong> il rif<strong>le</strong>sso, la trasposizione socialmente<br />
e culturalmente costruita, di meccanismi ad essa sovrastanti,<br />
di origine intimamente economica.<br />
Avvicinandosi alla “piccola realtà” acquisendo i ricordi, i pensieri e <strong>le</strong><br />
valutazioni di chi non aveva lasciato testimonianze scritte, il ricercatore<br />
si approssimava a quell’obiettivo di comprensione globa<strong>le</strong> che fu proprio<br />
dell’approccio marxista. Al tempo steso la classe lavoratrice conquistò<br />
l’opportunità di riappropriarsi, nel lavoro di collaborazione con lo storico<br />
che si instaura tramite l’intervista, <strong>della</strong> costruzione del proprio<br />
passato, nonché di raggiungere, <strong>attraverso</strong> il medesimo meccanismo,<br />
una comprensione del presente libera dal<strong>le</strong> sovrastrutture ideologiche<br />
imposte dal<strong>le</strong> classi egemoni. Strappata dal dominio borghese, la <strong>storia</strong><br />
mutava – con l’avvento dell’<strong>orali</strong>tà – di forma, confini e dimensioni per<br />
divenire patrimonio col<strong>le</strong>ttivo.<br />
Natura<strong>le</strong> corollario di quanto espresso si rivelò il passaggio, gradua<strong>le</strong><br />
e progressivo, dalla <strong>storia</strong> dei grandi eventi e degli uomini importanti a<br />
quella del<strong>le</strong> classi lavoratrici viste tramite i loro stessi occhi. Il recupero<br />
del<strong>le</strong> voci marginalizzate dominò questo passaggio, congiuntamente alla<br />
traslazione dell’interesse verso la quotidianità, il vissuto rea<strong>le</strong> <strong>della</strong><br />
gente comune, la partecipazione insita nello stesso processo di produzione<br />
dei documenti sui quali si sarebbe poi costruita la <strong>storia</strong>.<br />
Il processo ora delineato non fu esente da critiche e da attacchi provenienti<br />
da più parti, e supportati da differenti motivazioni.<br />
Proprio la dimostrazione <strong>della</strong> parzialità del documento scritto, espressione<br />
del potere esercitato dalla società che lo aveva fabbricato<br />
secondo i rapporti di forza in essa vigenti in funzione ad una predeterminata<br />
visione del<strong>le</strong> costruzione storica, interpretata, al di là del<br />
valore intrinsecamente cultura<strong>le</strong> <strong>della</strong> stessa, qua<strong>le</strong> strumento per la<br />
<strong>le</strong>gittimazione del presente e per la programmazione del futuro, indusse<br />
ad una difesa ad oltranza del materia<strong>le</strong> ufficia<strong>le</strong> e, nel contempo, ad un<br />
altrettanto deciso attacco alla fonte ora<strong>le</strong>. Quest’ultima fu criticata qua<strong>le</strong><br />
fonte “minore”, soggetta all’interpretazione persona<strong>le</strong>, al filtro discorsivo<br />
e del ricordo, al plagio, all’utilizzo parzia<strong>le</strong>, prigioniera <strong>della</strong> piccola<br />
scala, dell’evento margina<strong>le</strong>, del persona<strong>le</strong>, dell’intimo, mentre vennero<br />
ce<strong>le</strong>brate <strong>le</strong> qualità di invariabilità nella forma, precisione cronologica,<br />
14<br />
15<br />
Cap. 1 – <strong>La</strong> <strong>didattica</strong> <strong>della</strong> <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong><br />
possibilità di confronto caratteristiche <strong>della</strong> fonte.<br />
«Gran parte del<strong>le</strong> documentazioni scritte […]» ebbe tuttavia ad osservare<br />
Emilio Franzina rif<strong>le</strong>ttendo su tali osservazioni, «altro non sono<br />
se non trascrizioni e formalizzazioni di altrettanti momenti verbali a cui<br />
solo un malinteso concetto dell’obiettività scientifica conferisce credibilità<br />
ed autorevo<strong>le</strong>zza 4 ».<br />
In effetti la verificabilità, ad esempio, del contenuto espresso dalla<br />
testimonianza non pone, nella sua sostanza, prob<strong>le</strong>mi diversi rispetto ad<br />
un analogo utilizzo del<strong>le</strong> <strong>fonti</strong> scritte. Essa infatti implica il necessario<br />
confronto con altre narrazioni, così come i documenti necessitano il<br />
confronto con altri prodotti sullo stesso argomento.<br />
Se poi consideriamo i contenuti, non si può negare che «asserendo<br />
che i grandi eventi, <strong>le</strong> datazioni, <strong>le</strong> decisioni dei potenti contano per noi<br />
meno <strong>della</strong> vita quotidiana degli uomini e del<strong>le</strong> donne comuni, la <strong>storia</strong><br />
ora<strong>le</strong> si pone – intenzionalmente – come <strong>storia</strong> alternativa rispetto a<br />
quella tradiziona<strong>le</strong> che non ha mai guardato a ciò che importa veramente<br />
e quindi ha parlato erroneamente di fatti significativi» 5 .<br />
In effetti «la <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong> non tratta discorsi scelti, ma ha l’ambizione<br />
di affrontare il linguaggio nella sua totalità, non solo quello degli uomini<br />
illustri, ma quello <strong>della</strong> gente comune, non solo <strong>le</strong> lingue colte, ma i dia<strong>le</strong>tti,<br />
non solo l’espressione esplicita, ma i codici inarticolati di coloro<br />
che non hanno voce ufficia<strong>le</strong> […] L’esigenza è quella di affrontare lo studio<br />
degli esseri umani non solo rispetto al potere politico, al<strong>le</strong> strutture<br />
economiche, all’organizzazione socia<strong>le</strong>; ma anche rispetto ai comportamenti<br />
interpersonali, ai meccanismi psicologici e conoscitivi, agli interessi,<br />
al<strong>le</strong> idee, al<strong>le</strong> immagini che stanno nella testa degli individui» 6 .<br />
Alla debo<strong>le</strong>zza del<strong>le</strong> molte critiche alla <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong>, si contrappose la<br />
sua ri<strong>le</strong>vanza, evidente in quanto <strong>storia</strong> alternativa, in quanto meccanismo<br />
diverso per la formazione <strong>della</strong> memoria col<strong>le</strong>ttiva.<br />
2. Aspetti e prob<strong>le</strong>mi <strong>della</strong> fonte ora<strong>le</strong><br />
L’espressione <strong>storia</strong> ora<strong>le</strong> è un’abbreviazione d’uso per riferirsi a<br />
quello che più propriamente andrebbe designato come “uso del<strong>le</strong> <strong>fonti</strong><br />
4<br />
EMILIO FRANZINA, Merica! Merica! Emigrazione e colonizzazione nel<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere dei contadini<br />
veneti e friulani in America <strong>La</strong>tina. 1876-1902, Verona, Cierre, 1994.<br />
5<br />
LUISA PASSERINI, Storia e soggettività. Le <strong>fonti</strong> <strong>orali</strong>, la memoria, Firenze, <strong>La</strong> Nuova<br />
Italia, 1988.<br />
6<br />
Ibidem.