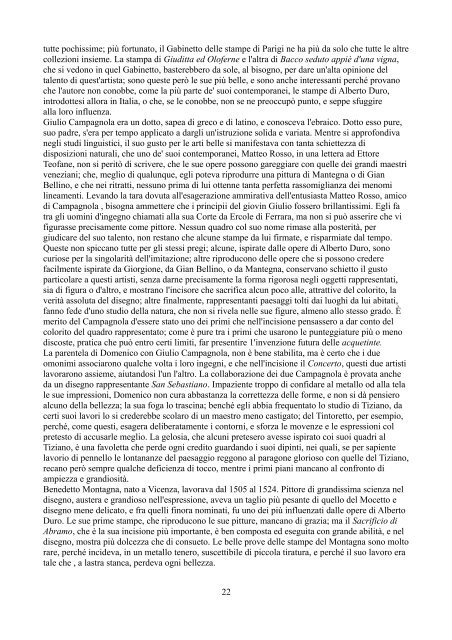Duplessis, Giorgio, Le meraviglie dell'incisione ... - Toni Pecoraro
Duplessis, Giorgio, Le meraviglie dell'incisione ... - Toni Pecoraro
Duplessis, Giorgio, Le meraviglie dell'incisione ... - Toni Pecoraro
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tutte pochissime; più fortunato, il Gabinetto delle stampe di Parigi ne ha più da solo che tutte le altre<br />
collezioni insieme. La stampa di Giuditta ed Oloferne e l'altra di Bacco seduto appiè d'una vigna,<br />
che si vedono in quel Gabinetto, basterebbero da sole, al bisogno, per dare un'alta opinione del<br />
talento di quest'artista; sono queste però le sue più belle, e sono anche interessanti perché provano<br />
che l'autore non conobbe, come la più parte de' suoi contemporanei, le stampe di Alberto Duro,<br />
introdottesi allora in Italia, o che, se le conobbe, non se ne preoccupò punto, e seppe sfuggire<br />
alla loro influenza.<br />
Giulio Campagnola era un dotto, sapea di greco e di latino, e conosceva l'ebraico. Dotto esso pure,<br />
suo padre, s'era per tempo applicato a dargli un'istruzione solida e variata. Mentre si approfondiva<br />
negli studi linguistici, il suo gusto per le arti belle si manifestava con tanta schiettezza di<br />
disposizioni naturali, che uno de' suoi contemporanei, Matteo Rosso, in una lettera ad Ettore<br />
Teofane, non si peritò di scrivere, che le sue opere possono gareggiare con quelle dei grandi maestri<br />
veneziani; che, meglio di qualunque, egli poteva riprodurre una pittura di Mantegna o di Gian<br />
Bellino, e che nei ritratti, nessuno prima di lui ottenne tanta perfetta rassomiglianza dei menomi<br />
lineamenti. <strong>Le</strong>vando la tara dovuta all'esagerazione ammirativa dell'entusiasta Matteo Rosso, amico<br />
di Campagnola , bisogna ammettere che i principii del giovin Giulio fossero brillantissimi. Egli fa<br />
tra gli uomini d'ingegno chiamati alla sua Corte da Ercole di Ferrara, ma non si può asserire che vi<br />
figurasse precisamente come pittore. Nessun quadro col suo nome rimase alla posterità, per<br />
giudicare del suo talento, non restano che alcune stampe da lui firmate, e risparmiate dal tempo.<br />
Queste non spiccano tutte per gli stessi pregi; alcune, ispirate dalle opere di Alberto Duro, sono<br />
curiose per la singolarità dell'imitazione; altre riproducono delle opere che si possono credere<br />
facilmente ispirate da <strong>Giorgio</strong>ne, da Gian Bellino, o da Mantegna, conservano schietto il gusto<br />
particolare a questi artisti, senza darne precisamente la forma rigorosa negli oggetti rappresentati,<br />
sia di figura o d'altro, e mostrano l'incisore che sacrifica alcun poco alle, attrattive del colorito, la<br />
verità assoluta del disegno; altre finalmente, rappresentanti paesaggi tolti dai luoghi da lui abitati,<br />
fanno fede d'uno studio della natura, che non si rivela nelle sue figure, almeno allo stesso grado. È<br />
merito del Campagnola d'essere stato uno dei primi che nell'incisione pensassero a dar conto del<br />
colorito del quadro rappresentato; come è pure tra i primi che usarono le punteggiature più o meno<br />
discoste, pratica che può entro certi limiti, far presentire 1'invenzione futura delle acquetinte.<br />
La parentela di Domenico con Giulio Campagnola, non è bene stabilita, ma è certo che i due<br />
omonimi associarono qualche volta i loro ingegni, e che nell'incisione il Concerto, questi due artisti<br />
lavorarono assieme, aiutandosi l'un l'altro. La collaborazione dei due Campagnola è provata anche<br />
da un disegno rappresentante San Sebastiano. Impaziente troppo di confidare al metallo od alla tela<br />
le sue impressioni, Domenico non cura abbastanza la correttezza delle forme, e non si dà pensiero<br />
alcuno della bellezza; la sua foga lo trascina; benché egli abbia frequentato lo studio di Tiziano, da<br />
certi suoi lavori lo si crederebbe scolaro di un maestro meno castigato; del Tintoretto, per esempio,<br />
perché, come questi, esagera deliberatamente i contorni, e sforza le movenze e le espressioni col<br />
pretesto di accusarle meglio. La gelosia, che alcuni pretesero avesse ispirato coi suoi quadri al<br />
Tiziano, è una favoletta che perde ogni credito guardando i suoi dipinti, nei quali, se per sapiente<br />
lavorio di pennello le lontananze del paesaggio reggono al paragone glorioso con quelle del Tiziano,<br />
recano però sempre qualche deficienza di tocco, mentre i primi piani mancano al confronto di<br />
ampiezza e grandiosità.<br />
Benedetto Montagna, nato a Vicenza, lavorava dal 1505 al 1524. Pittore di grandissima scienza nel<br />
disegno, austera e grandioso nell'espressione, aveva un taglio più pesante di quello del Mocetto e<br />
disegno mene delicato, e fra quelli finora nominati, fu uno dei più influenzati dalle opere di Alberto<br />
Duro. <strong>Le</strong> sue prime stampe, che riproducono le sue pitture, mancano di grazia; ma il Sacrificio di<br />
Abramo, che è la sua incisione più importante, è ben composta ed eseguita con grande abilità, e nel<br />
disegno, mostra più dolcezza che di consueto. <strong>Le</strong> belle prove delle stampe del Montagna sono molto<br />
rare, perché incideva, in un metallo tenero, suscettibile di piccola tiratura, e perché il suo lavoro era<br />
tale che , a lastra stanca, perdeva ogni bellezza.<br />
22