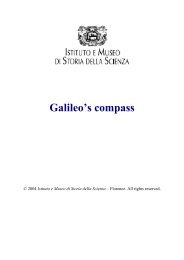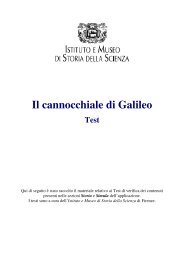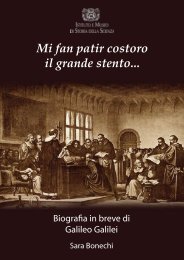Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3.2.2. Lorenzo Magalotti (1637-1712)<br />
Di nob<strong>il</strong>e famiglia fiorentina, studiò a Pisa ed ebbe come maestri grandi personalità come Marcello<br />
Malpighi (1628-1694) e Giovanni Alfonso Borelli. A Firenze si avvalse dell'amicizia e del magistero di<br />
Vincenzo Viviani. Fu nominato nel 1660, ancora giovanissimo, Segretario dell'Accademia del Cimento.<br />
Redasse i Saggi di naturali esperienze (Firenze, 1667), che contengono l'ordinata esposizione dei più<br />
r<strong>il</strong>evanti esperimenti eseguiti dagli accademici. Compì lunghi viaggi, dapprima a titolo personale, poi<br />
come diplomatico del Granduca di Toscana Ferdinando II e, in seguito, del Granduca Cosimo III<br />
(1642-1723). Un'incrinatura improvvisa dei rapporti con Cosimo III interruppe, nel 1678, la folgorante<br />
carriera e i viaggi dell'erudito, che si ritirò per un decennio dalla vita pubblica dedicandosi alla stesura<br />
delle Lettere fam<strong>il</strong>iari, pubblicate postume a Venezia nel 1719. Riprese la vita pubblica nel 1689 (con<br />
l'incarico di “terzo consigliere di Stato”) e l'intensa attività di scrittore (inizia in questi anni la stesura<br />
delle Lettere su le terre odorose d'Europa e d'America dette volgarmente buccheri). Gal<strong>il</strong>eiano, poi libertino e amico<br />
di Saint-Evremond, infine seguace della f<strong>il</strong>osofia corpuscolaristica di Pierre Gassendi (1592-1655),<br />
Magalotti visse in pieno <strong>il</strong> contrasto tra nuova scienza e ortodossia religiosa, e approdò a pratiche<br />
ascetiche che lo spinsero a indossare per qualche tempo l'abito della congregazione di S. F<strong>il</strong>ippo Neri.<br />
La tensione tra nuova scienza e ortodossia religiosa anima le sue Lettere fam<strong>il</strong>iari contro l'ateismo.<br />
3.3. I MEMBRI RESIDENTI<br />
3.3.1. Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679)<br />
Nato a Messina, le prime notizie sulla sua vita risalgono al 1630 circa, quando lo troviamo a Roma,<br />
allievo di Benedetto Castelli (1578-1643). Fu proprio <strong>il</strong> Castelli – pare – a fare <strong>il</strong> nome del Borelli<br />
all'Università di Messina per una cattedra vacante di matematica. Tra <strong>il</strong> 1641 e <strong>il</strong> 1642 <strong>il</strong> Senato di<br />
Messina, in segno di particolare apprezzamento dell'attività scientifica svolta, lo inviò in viaggio nei<br />
maggiori centri italiani, allo scopo di reclutare docenti per l'università. Negli anni immediatamente<br />
successivi, oltre a pubblicare l'opuscolo Delle cagioni de le febbri maligna (Roma, 1649), iniziò a lavorare ad<br />
un compendio dei quattro libri superstiti dei Conici di Apollonio, che avrebbe pubblicato molti anni più<br />
tardi (Roma, 1679). Aveva già intrapreso la revisione degli Elementi di Euclide (che stampò nel 1658 col<br />
titolo Euclides restitus), quando gli giunse l'offerta della cattedra di matematica all'Università di Pisa,<br />
prontamente accettata. Nei dieci anni trascorsi in Toscana <strong>il</strong> Borelli costituì uno dei punti di riferimento<br />
di tutta l'attività scientifico-sperimentale organizzata dal Principe Leopoldo de' Medici. Non vi fu<br />
praticamente esperimento dell'Accademia del Cimento che non recasse <strong>il</strong> suo apporto, pur trovandosi<br />
spesso in contrasto con Carlo Renaldini, che Borelli definiva <strong>il</strong> "Simplicio" del Cimento. Ma <strong>il</strong><br />
contributo più importante dato dal Borelli durante <strong>il</strong> soggiorno toscano fu senza dubbio <strong>il</strong> lavoro<br />
compiuto sui satelliti di Giove, le Theoricae Mediceorum Planetarum ex causis physicis deductae (Firenze, 1666),<br />
un'opera destinata a inserirsi efficacemente nelle discussioni cosmologiche europee. In un quadro di<br />
riferimento dichiaratamente copernicano, <strong>il</strong> Borelli giunse a ipotizzare un moto planetario curv<strong>il</strong>ineo<br />
animato da due forze: quella centrifuga e quella di attrazione solare, la cui composizione permetterebbe<br />
l'equ<strong>il</strong>ibrio nell'etere. Nel 1667 <strong>il</strong> Borelli si congedò dai Medici e tornò a Messina; nello stesso anno<br />
faceva stampare a Bologna <strong>il</strong> De vi percussionis, che raccoglieva, ampliandole, le ricerche fisiche effettuate<br />
nell'Accademia del Cimento. In seguito alla ribellione antispagnola che si verificò a Messina nel 1670, <strong>il</strong><br />
Borelli, <strong>il</strong> cui ruolo nella vicenda non è stato ancora ben chiarito, fu costretto a lasciare l'isola e<br />
trasferirsi prima in Calabria, poi a Roma, dove divenne, tra l'altro, uno dei membri dell'Accademia<br />
fondata dalla Regina Cristina di Svezia. Le condizioni finanziarie sempre più precarie lo costrinsero nel<br />
1677 ad accettare l'ospitalità dei Padri Scolopi. Visse gli ultimi anni dando lezioni di matematica ad<br />
alcuni novizi dell'Ordine e ultimando quello che è considerato <strong>il</strong> suo capolavoro, <strong>il</strong> De motu animalium<br />
(Roma, 1680-81). Si tratta di un trattato di fisiologia meccanicista interamente basato sul carattere<br />
35