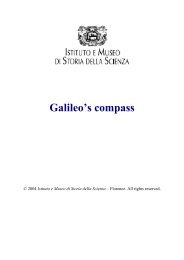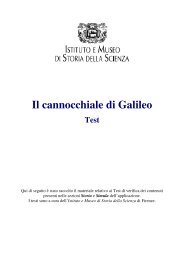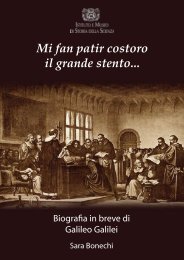Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
8. L'ASTRONOMIA<br />
8.1. IL CIMENTO DEGLI ASTRI<br />
La condanna di Gal<strong>il</strong>eo Gal<strong>il</strong>ei del 1633 proclamò eretica la concezione copernicana; ma non l’uso<br />
astronomico del cannocchiale che aveva già svelato insospettati fenomeni celesti.<br />
In questa contingenza, l’Accademia del Cimento assunse la fisionomia d’un alto tribunale<br />
scientifico — presieduto dal principe Leopoldo de’ Medici — chiamato a dirimere dispute<br />
astronomiche incentrate sulle doti dei nuovi cannocchiali. Per esempio, gli accademici verificarono in<br />
che misura le strane apparenze telescopiche di Saturno derivassero dalla qualità degli strumenti<br />
impiegati da Christiaan Huygens (1629-1695) e da Eustachio Divini (1610-1685). Nella successiva<br />
vicenda dei “paragoni”, oltre lo scontro immediato fra Divini e Giuseppe Campani (1635-1715) per<br />
aggiudicarsi <strong>il</strong> primato di miglior ottico del tempo, gli accademici cercarono un metodo oggettivo per<br />
misurare la qualità d’un cannocchiale.<br />
In questi come negli altri ambiti d’indagine toccati, gli accademici badarono sempre a non<br />
entrare in conflitto con l’autorità religiosa. Ciò spiega perché i pareri dell’Accademia, specialmente se<br />
inclini all’eliocentrismo, divennero di pubblico dominio solo dal 1780.<br />
8.2. IL PARAGONE DEGLI OCCHIALI<br />
Nel solco di una tradizione iniziata con Gal<strong>il</strong>eo, <strong>il</strong> primo secolo di storia del cannocchiale vide <strong>il</strong><br />
primato degli ottici italiani. Sin dalla fine degli anni ’40 del XVII secolo, in particolare, si era andato<br />
affermando <strong>il</strong> marchigiano Eustachio Divini (1610-1685), la cui fama si diffuse ben presto in tutta<br />
Europa. Reduce dalla vicenda di Saturno, che aveva in qualche misura offuscato la sua reputazione di<br />
ottico, alcuni anni dopo Divini dovette affrontare l’emergere, sulla scena romana, di un artigiano<br />
fermamente intenzionato a sottrargli <strong>il</strong> primato.<br />
Si trattava di Giuseppe Campani (1635-1715), che aveva cominciato la propria carriera come costruttore<br />
di orologi, per poi dedicarsi, verso <strong>il</strong> 1660, alla realizzazione di lenti. Nel 1662, assieme al fratello<br />
Matteo, aveva realizzato un occhiale da 10 palmi (c. 2,2 m) che aveva suscitato grande interesse per la<br />
qualità delle ottiche, insidiando l’indiscussa superiorità dei cannocchiali del Divini.<br />
Tra i due artefici si accese un’acerrima rivalità che aprì la stagione dei paragoni, come all’epoca venivano<br />
chiamati i confronti diretti tra cannocchiali costruiti da artigiani diversi.<br />
Nella primavera del 1664 gli occhiali del Campani avevano condotto a importanti scoperte astronomiche.<br />
A Firenze, gli accademici del Cimento, che si erano sin qui avvalsi di cannocchiali del Divini, volevano<br />
ora appurare se, e in che misura, quelli del Campani fossero superiori. Essi approntarono un foglio a<br />
stampa che riporta, con caratteri di grandezza decrescente, dieci righe tratte da versi di celebri opere<br />
letterarie. Il foglio — <strong>il</strong>luminato da due torce poste lateralmente e schermate per non disturbarne la<br />
visione — fu letto alla distanza di 100 braccia fiorentine (c. 58,4 m) per mezzo di cannocchiali di varia<br />
lunghezza, annotando accuratamente fin dove si riuscisse a leggere con ciascuno di essi. Nell’autunno di<br />
quello stesso anno, <strong>il</strong> foglio fu inviato a Roma, a Paolo Falconieri, con precise istruzioni, affinché, letto<br />
nelle stesse condizioni e con occhiali di uguale lunghezza, fornisse risultati comparab<strong>il</strong>i con quelli<br />
ottenuti a Firenze.<br />
Sin dai primi tentavi di creare fogli di prova, gli accademici si resero conto che l’uso di versi celebri<br />
poteva far «creder’a chi osserva di legger e distinguer co’ gli occhi, quello che solamente la memoria gli<br />
suggerisce». Constatarono inoltre che le lettere con la stanghetta — come ad esempio la p o la d —<br />
sono più fac<strong>il</strong>mente identificab<strong>il</strong>i di quelle che ne sono prive, <strong>il</strong> che consentiva talvolta di intuire intere<br />
parole, soprattutto se di senso compiuto. Sulla base di queste considerazioni, gli accademici<br />
approntarono due nuovi fogli di prova: uno, contrassegnato dalla lettera «A», contenente solo lettere<br />
senza stanghetta disposte a formare parole prive di senso; l’altro, contrassegnato con la lettera «B», che<br />
52