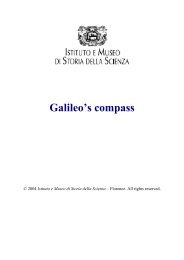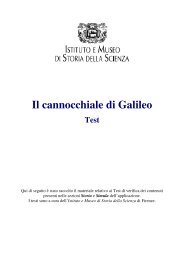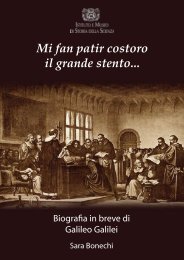Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
Apri il PDF (2369 Kb)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Londra e ad Amsterdam, ma non ancora pervenuta a Firenze e in altre parti della penisola italiana. Nella<br />
sua epistola, <strong>il</strong> medico inglese poneva particolare attenzione ai passi dell’opera di W<strong>il</strong>lis che<br />
maggiormente avevano riguardo con la produzione degli spiriti animali da parte del cervello e alle loro<br />
modalità di diramazione verso gli organi periferici della sensib<strong>il</strong>ità attraverso l’apparato nervoso. Nel<br />
suo scelto sistema di rinvii e nella selezione dei passi della Cerebri anatome si coglie chiaramente <strong>il</strong><br />
desiderio, quasi, si direbbe, l’urgenza, di comunicare con precisione temi e motivi di attualità e<br />
consistenza, la cui discussione appariva nient’affatto spenta e sopita nella sua mente, ancora vogliosa di<br />
ordire argomenti e materiali ut<strong>il</strong>i a chiarire e confermare una posizione pubblicamente sostenuta poche<br />
settimane avanti di fronte al Granduca, al Principe e all’intero corpo di scienziati e cortigiani riuniti a<br />
Firenze.<br />
La seconda testimonianza (anch’essa appartenente al Ms. Gal. 277 della BNCF) è rappresentata da una<br />
lettera dello stesso Giovanni Alfonso Borelli, inviata da Pisa a Leopoldo de’ Medici <strong>il</strong> 29 dicembre del<br />
1666. L’epistola contiene una serrata critica ai principî e ai metodi ut<strong>il</strong>izzati dal gesuita Honoré Fabri,<br />
anch’egli corrispondente di Leopoldo e, per suo tramite, collaboratore dell’Accademia del Cimento, nei<br />
Tractatus duo: quorum prior est de plantis et de generatione animalium; posterior de homine, dati quello stesso anno<br />
alla luce a Parigi presso la casa editoriale Mugnat. I trattati, dalla struttura ridondante e dai contenuti<br />
complessi e non ovvii, erano stati inviati allo scienziato napoletano direttamente dallo stesso Leopoldo,<br />
interessato a ricevere pareri accurati e competenti che gli permettessero di stimarne appieno <strong>il</strong> valore.<br />
La razionalità scientifica tipica del Borelli, ben nota del resto a Leopoldo, si reggeva su principi e criteri<br />
radicalmente diversi da quelli del Fabri e la sollecitazione principesca dové apparire, come forse era<br />
nelle intenzioni, una sorta di invito alla sfida. La lettera che <strong>il</strong> Borelli scrisse al suo principe è un piccolo<br />
capolavoro di intelligenza e ironia, penetrante ma concisa, tanto leggera e soave quanto congestionata e<br />
caotica appariva l’opera del gesuita sotto giudizio. Essa è senza dubbio una testimonianza eloquente<br />
della vitalità e del grande r<strong>il</strong>ievo che avevano assunto le questioni mediche e naturalistiche agitate fra<br />
Pisa e Firenze nei febbr<strong>il</strong>i anni del Cimento.<br />
6.4.UN DECENNIO STRAORDINARIO<br />
Il dato che più chiaramente di ogni altro palesa <strong>il</strong> nesso non accidentale e momentaneo che si strinse tra<br />
l’ideologia e <strong>il</strong> programma sperimentale dell’Accademia di Leopoldo de’ Medici e le discipline<br />
scientifiche oggi dette ‘morbide’, è rappresentato dalla gran messe di trattati medici e naturalistici dati<br />
alla luce nel corso degli anni sessanta del XVII secolo da autori che avevano ruotato intorno al circolo<br />
leopoldino. Tra <strong>il</strong> 1661 e <strong>il</strong> 1668, cioè nell’arco di anni che si apre con <strong>il</strong> trattato De pulmonibus<br />
observationes anatomicae di Marcello Malpighi (1628-1694) e si chiude con le Esperienze intorno alla<br />
generazione degli insetti di Francesco Redi, si stamparono, fra Firenze e Bologna, alcuni fra i principali<br />
trattati di anatomia comparata, sott<strong>il</strong>e e sperimentale e di fisiologia umana e animale di tutta la storia<br />
medica moderna. Oltre alle due opere citate, basterà qui ricordare l’Exercitatio anatomica de structura et usu<br />
renum (1662) di Lorenzo Bellini (1643-1704), le Tetras anatomicarum epistolarum de lingua et cerebro (1665)<br />
dello stesso Malpighi e di Carlo Fracassati (1630-1672), <strong>il</strong> Gustus organum (1665), ancora di Bellini, e <strong>il</strong><br />
Canis carchariae dissectum caput (1667) di Niccolò Stenone. Malpighi, Fracassati e Bellini, sebbene soltanto<br />
quest’ultimo fosse suddito granducale, avevano seguito a Pisa le ricerche del Borelli e, tramite lui, si<br />
erano più volte affacciati sulla soglia della Corte Medicea, assorbendone l’atmosfera e respirandone<br />
l’esuberanza intellettuale. Nelle stanze dei palazzi granducali riservati alle ostensioni anatomiche e nelle<br />
larghe aule nelle quali si ammassavano le migliaia di libri che formavano la biblioteca dei prìncipi, essi<br />
avevano potuto, con larghezza di mezzi e disponib<strong>il</strong>ità di tempo, mettere a fuoco e impostare <strong>il</strong> quadro<br />
dei motivi e delle problematiche necessario a dare sostanza all’intera impalcatura portante della loro<br />
successiva, e tanto ricca, riflessione medica. E proprio negli anni critici dell’attività del Cimento avevano<br />
potuto mettere alla prova, all’ombra dell’attività di più anziani maestri, <strong>il</strong> valore e l’efficacia dei principi<br />
e dei metodi delle conoscenze tradizionali.<br />
Niccolò Stenone, approdato nel Granducato dalla Francia nei primi mesi del 1666, già consapevole<br />
delle tendenze di ricerca e del programma scientifico dell’Accademia di Leopoldo, si integrò<br />
47