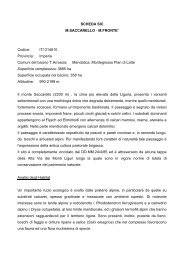Capitolo 2 - Piani di Bacino - Provincia di Imperia
Capitolo 2 - Piani di Bacino - Provincia di Imperia
Capitolo 2 - Piani di Bacino - Provincia di Imperia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Piano <strong>di</strong> <strong>Bacino</strong> dell’Ambito n° 1 “ROIA”<br />
La scala del modello venne scelta pari ad 1:70. Il tronco del fiume rappresentato nel modello a valle della<br />
passerella pedonale era <strong>di</strong> sezione rettangolare con larghezza <strong>di</strong> 140 m e con pendenza costante dello<br />
0.3%. Nella scala 1:70 la larghezza dell’alveo reale venne ridotta perciò a 2.00 m; poiché la larghezza del<br />
canale sperimentale era invece <strong>di</strong> 1.20 m, si assimilò la sezione del fiume reale a rettangolare larghissima,<br />
per cui il moto dell’acqua risultava un fenomeno piano, del quale nel modello venne rappresentata<br />
una striscia <strong>di</strong> larghezza pari a 0.6 volte la larghezza effettiva del tronco fluviale.<br />
Prima <strong>di</strong> eseguire le esperienze si provvide alla sistemazione lungo il tronco in esame <strong>di</strong> alcuni idrometri,<br />
che furono azzerati me<strong>di</strong>ante la lettura <strong>di</strong> una quota <strong>di</strong> riferimento.<br />
Vennero quin<strong>di</strong> effettuate alcune esperienze con la portata massima; il profilo liquido venne rilevato con il<br />
livello del mare alle seguenti quote: 0.00 m, 0.55 m, 0.70 m, 1.35 m e 2.11 m.<br />
Il risultato piuttosto notevole ottenuto fu che i profili liqui<strong>di</strong> risultarono pressoché uguali in<strong>di</strong>pendentemente<br />
dal livello del mare, a meno <strong>di</strong> scarti dell’or<strong>di</strong>ne dei decimi <strong>di</strong> mm, imputabili ad errori sperimentali. Con ciò<br />
fu <strong>di</strong>mostrato come il profilo <strong>di</strong> rigurgito non fosse influenzato da un livello del mare <strong>di</strong>verso da quello me<strong>di</strong>o<br />
pari a 0.00 m, almeno fino a quando tale livello si manteneva al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> quello corrispondente<br />
all’altezza critica nella sezione <strong>di</strong> sbocco.<br />
Queste prime esperienze furono eseguite senza la passerella pedonale, al fine <strong>di</strong> poter più agevolmente<br />
calcolare il coefficiente <strong>di</strong> scabrezza m della formula <strong>di</strong> Kutter nel modello e verificare quin<strong>di</strong> se esso rappresentasse<br />
il coefficiente del prototipo, avuto presente della scala <strong>di</strong> riduzione.<br />
Prima <strong>di</strong> eseguire le esperienze con la passerella pedonale si dovette procedere ad aumentare la rugosità<br />
del fondo e ad un successivo controllo del coefficiente m, fino ad ottenere un valore sufficientemente<br />
prossimo a quello desiderato.<br />
Confrontando poi i risultati sperimentali con gli analoghi, ottenuti nel modello in scala 1:200, si vide che le<br />
<strong>di</strong>fferenze erano davvero minime ed imputabili più che altro alla lieve <strong>di</strong>fferenza del coefficiente <strong>di</strong> scabrezza<br />
nei due modelli e alla maggiore importanza della resistenza delle pareti rispetto al fondo nel modello<br />
in scala 1:70, rappresentando questo solo una striscia del fiume reale.<br />
In sostanza il modello in scala 1:70 confermò in pieno i risultati ottenuti nel modello in scala 1:200, e ciò<br />
<strong>di</strong>mostrava che in tale modello le forze <strong>di</strong> capillarità avevano effetto solo in un piccolissimo tratto subito a<br />
monte dello sbocco e delle soglie.<br />
In definitiva si ebbe conferma che la passerella pedonale non dava luogo ad un rigurgito eccessivo, ma<br />
che comunque, almeno con la portata massima, il franco esistente sia a monte sia a valle della stessa,<br />
risultava piuttosto limitato.<br />
Esperienze su modelli a fondo mobile.<br />
Per la costruzione <strong>di</strong> tali modelli a fondo mobile si provvide innanzi tutto alla determinazione delle curve<br />
granulometriche del materiale costituente il fondo mobile del fiume originale, me<strong>di</strong>ante prelievo <strong>di</strong> alcuni<br />
campioni in <strong>di</strong>verse sezioni trasversali del corso d’acqua. Osservando tali curve si vide come, procedendo<br />
da valle verso monte, aumentasse la pezzatura me<strong>di</strong>a del materiale d’alveo.<br />
Si osservò che le tre curve ricavate non erano molto <strong>di</strong>fferenti fra loro, per cui, ai fini della determinazione<br />
della curva granulometrica da assumere nel modello sembrò opportuno partire da una curva granulometrica<br />
dell’originale, ottenuta come me<strong>di</strong>a aritmetica delle tre curve <strong>di</strong> cui sopra. Il <strong>di</strong>ametro me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> essa fu<br />
dm = 2.70 cm, corrispondente alla me<strong>di</strong>a aritmetica dei <strong>di</strong>ametri me<strong>di</strong> delle tre curve <strong>di</strong> partenza.<br />
68