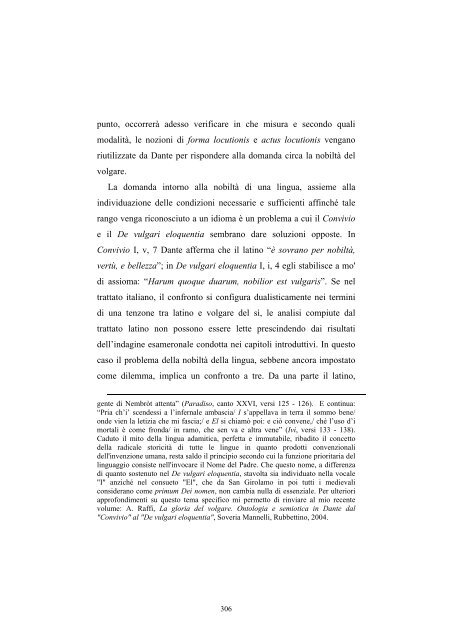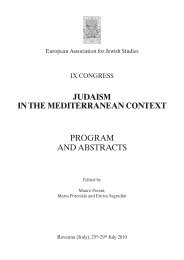la questione della nobiltà della lingua nel De Vulgari Eloquentia di
la questione della nobiltà della lingua nel De Vulgari Eloquentia di
la questione della nobiltà della lingua nel De Vulgari Eloquentia di
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
punto, occorrerà adesso verificare in che misura e secondo quali<br />
modalità, le nozioni <strong>di</strong> forma locutionis e actus locutionis vengano<br />
riutilizzate da Dante per rispondere al<strong>la</strong> domanda circa <strong>la</strong> <strong>nobiltà</strong> del<br />
volgare.<br />
La domanda intorno al<strong>la</strong> <strong>nobiltà</strong> <strong>di</strong> una <strong>lingua</strong>, assieme al<strong>la</strong><br />
in<strong>di</strong>viduazione delle con<strong>di</strong>zioni necessarie e sufficienti affinché tale<br />
rango venga riconosciuto a un i<strong>di</strong>oma è un problema a cui il Convivio<br />
e il <strong>De</strong> vulgari eloquentia sembrano dare soluzioni opposte. In<br />
Convivio I, v, 7 Dante afferma che il <strong>la</strong>tino “è sovrano per <strong>nobiltà</strong>,<br />
vertù, e bellezza”; in <strong>De</strong> vulgari eloquentia I, i, 4 egli stabilisce a mo'<br />
<strong>di</strong> assioma: “Harum quoque duarum, nobilior est vulgaris”. Se <strong>nel</strong><br />
trattato italiano, il confronto si configura dualisticamente nei termini<br />
<strong>di</strong> una tenzone tra <strong>la</strong>tino e volgare del sì, le analisi compiute dal<br />
trattato <strong>la</strong>tino non possono essere lette prescindendo dai risultati<br />
dell’indagine esameronale condotta nei capitoli introduttivi. In questo<br />
caso il problema del<strong>la</strong> <strong>nobiltà</strong> del<strong>la</strong> <strong>lingua</strong>, sebbene ancora impostato<br />
come <strong>di</strong>lemma, implica un confronto a tre. Da una parte il <strong>la</strong>tino,<br />
gente <strong>di</strong> Nembròt attenta” (Para<strong>di</strong>so, canto XXVI, versi 125 - 126). E continua:<br />
“Pria ch’i’ scendessi a l’infernale ambascia/ I s’appel<strong>la</strong>va in terra il sommo bene/<br />
onde vien <strong>la</strong> letizia che mi fascia;/ e El si chiamò poi: e ciò convene,/ ché l’uso d’i<br />
mortali è come fronda/ in ramo, che sen va e altra vene” (Ivi, versi 133 - 138).<br />
Caduto il mito del<strong>la</strong> <strong>lingua</strong> adamitica, perfetta e immutabile, riba<strong>di</strong>to il concetto<br />
del<strong>la</strong> ra<strong>di</strong>cale storicità <strong>di</strong> tutte le lingue in quanto prodotti convenzionali<br />
dell'invenzione umana, resta saldo il principio secondo cui <strong>la</strong> funzione prioritaria del<br />
<strong>lingua</strong>ggio consiste <strong>nel</strong>l'invocare il Nome del Padre. Che questo nome, a <strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>di</strong> quanto sostenuto <strong>nel</strong> <strong>De</strong> vulgari eloquentia, stavolta sia in<strong>di</strong>viduato <strong>nel</strong><strong>la</strong> vocale<br />
"I" anziché <strong>nel</strong> consueto "El", che da San Giro<strong>la</strong>mo in poi tutti i me<strong>di</strong>evali<br />
considerano come primum <strong>De</strong>i nomen, non cambia nul<strong>la</strong> <strong>di</strong> essenziale. Per ulteriori<br />
approfon<strong>di</strong>menti su questo tema specifico mi permetto <strong>di</strong> rinviare al mio recente<br />
volume: A. Raffi, La gloria del volgare. Ontologia e semiotica in Dante dal<br />
"Convivio" al "<strong>De</strong> vulgari eloquentia", Soveria Man<strong>nel</strong>li, Rubbettino, 2004.<br />
306