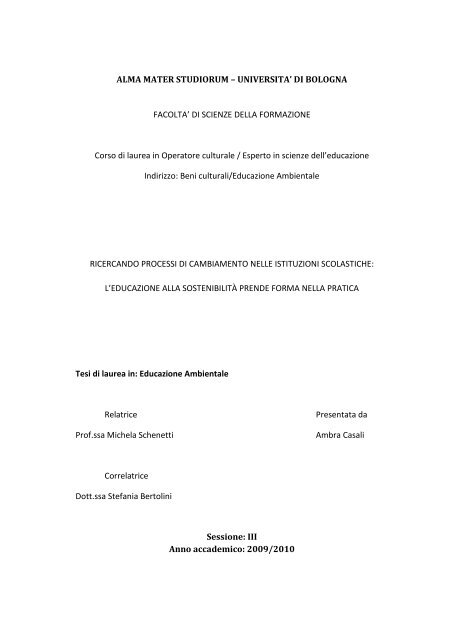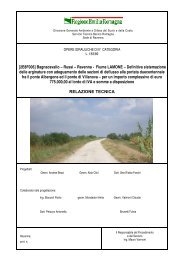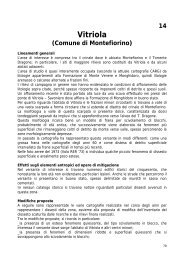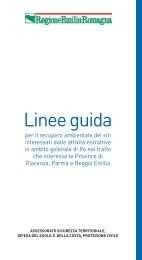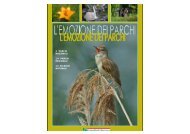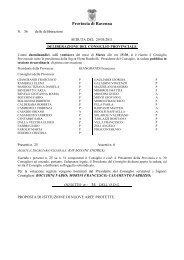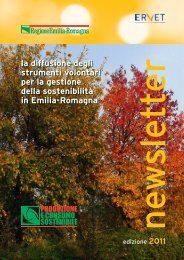Tesi di laurea - Ambiente - Regione Emilia-Romagna
Tesi di laurea - Ambiente - Regione Emilia-Romagna
Tesi di laurea - Ambiente - Regione Emilia-Romagna
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA<br />
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE<br />
Corso <strong>di</strong> <strong>laurea</strong> in Operatore culturale / Esperto in scienze dell’educazione<br />
In<strong>di</strong>rizzo: Beni culturali/Educazione Ambientale<br />
RICERCANDO PROCESSI DI CAMBIAMENTO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:<br />
L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ PRENDE FORMA NELLA PRATICA<br />
<strong>Tesi</strong> <strong>di</strong> <strong>laurea</strong> in: Educazione Ambientale<br />
Relatrice Presentata da<br />
Prof.ssa Michela Schenetti Ambra Casali<br />
Correlatrice<br />
Dott.ssa Stefania Bertolini<br />
Sessione: III<br />
Anno accademico: 2009/2010
INDICE<br />
Introduzione 3<br />
1. Dall’Educazione Ambientale all’Educazione alla Sostenibilita’ 6<br />
1.1 Storia dello sviluppo sostenibile 7<br />
1.2 Agenda 21 11<br />
1.3 Il senso <strong>di</strong> un’educazione ambientale 14<br />
1.4 “<strong>Ambiente</strong>” e modello <strong>di</strong>alogico 18<br />
1.5 Definizioni in <strong>di</strong>venire 21<br />
1.6 L’educazione ambientale oggi 22<br />
2. Sistema In.F.E.A. 26<br />
2.1 Storia e Nascita del Sistema In.f.e.a. Nazionale 27<br />
2.2 Il sistema regionale In.f.e.a. nell’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> 32<br />
2.3 Programmazione regionale In.f.e.a. 2008-10 35<br />
2.4 Evoluzione legislativa recente 39<br />
3. Lettura dei progetti presentati al Bando Infea 2010 42<br />
3.1 Bando In.f.e.a. 2010 42<br />
3.2 L’ambiente e l’educazione alla sostenibilità 46<br />
nelle Istituzioni scolastiche<br />
3.3 Le fasi del mio lavoro 50<br />
3.4 Risultati ottenuti 56<br />
4. Conclusioni 67<br />
4.1 Cambiamenti in atto nelle scuole 70<br />
4.2 Complessità <strong>di</strong> un’educazione sostenibile 76<br />
4.3 Educazione degli adulti 79<br />
4.4 Scuola e politiche 82<br />
4.5 Proposta per una progettazione futura 86<br />
Appen<strong>di</strong>ce 90<br />
Strumenti <strong>di</strong> ricerca utilizzati<br />
2
Introduzione<br />
Con il mio lavoro ho tentato <strong>di</strong> chiarire ed esemplificare il concetto <strong>di</strong><br />
sviluppo sostenibile, tracciando, insieme a nozioni storiche e concetti<br />
pedagogici, anche una visione pragmatica dell’educazione alla sostenibilità.<br />
Prendendo in esame il contesto della <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>. Il mio<br />
obiettivo vorrebbe, infatti, essere quello <strong>di</strong> mostrare nel concreto cosa significa<br />
e come sia possibile tendere verso la realizzazione <strong>di</strong> una citta<strong>di</strong>nanza attiva.<br />
Come Operatrice culturale, con in<strong>di</strong>rizzo Beni culturali/Educazione<br />
Ambientale, ho affrontato questo tema cercando <strong>di</strong> toccare i punti più<br />
significativi che sono emersi, nel corso degli anni fino ad oggi a livello<br />
internazionale, sull’idea <strong>di</strong> educazione e sul nuovo ruolo attribuitogli,<br />
specialmente quello dell’educazione ambientale come strumento principale<br />
per la formazione <strong>di</strong> una nuova società sostenibile. Sono state, per questo,<br />
considerate le nuove responsabilità delle Istituzioni scolastiche, le rivisitazioni<br />
necessarie da realizzare al loro interno, al fine <strong>di</strong> creare quell'ambiente<br />
formativo idoneo per lo sviluppo <strong>di</strong> una citta<strong>di</strong>nanza sostenibile e<br />
consapevole.<br />
Attraverso il mio lavoro <strong>di</strong> ricerca sui progetti vincitori del Bando In.F.E.A.<br />
2010, mi sono posta l’obiettivo <strong>di</strong> analizzare iniziative e progetti de<strong>di</strong>cati al<br />
cambiamento dello spazio scolastico e <strong>di</strong> esaminare come si stanno<br />
mo<strong>di</strong>ficando le scuole. Queste sono, infatti, i principali luoghi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong><br />
conoscenza, in cui si incontrano nuove generazioni, famiglie, insegnanti,<br />
operatori educativi e personale. Le Istituzioni scolastiche sono per questo<br />
invitate a comprendere la loro funzione nel territorio, lavorando in interazione<br />
con l’intera realtà esterna circostante, riconoscendo e sviluppando così nella<br />
pratica la loro <strong>di</strong>mensione comunitaria.<br />
3
La prima parte del mio lavoro spiega l’evoluzione che ha avuto il concetto <strong>di</strong><br />
educazione ambientale, trasformato oggi in educazione alla sostenibilità, e i<br />
motivi che l’hanno portato in essere. Inizialmente sono trattate le fasi storico-<br />
politiche più importanti che hanno dato il via al cambiamento culturale e al<br />
modo <strong>di</strong> vedere il ruolo dell’educazione ambientale: il Rapporto Bruntland, in<br />
cui si trova la definizione più conosciuta <strong>di</strong> “sviluppo sostenibile”; l’incontro a<br />
Rio delle Nazioni Unite e la nascita del programma <strong>di</strong> Agenda 21, con la<br />
conseguente <strong>di</strong>ffusione a livello locale. Dopo questa panoramica storica, ho<br />
poi proseguito esponendo il ruolo dell’educazione come strumento importante<br />
per la realizzazione <strong>di</strong> una nuova società, capace <strong>di</strong> rispondere e riuscire a<br />
realizzare gli obiettivi sostenibili prefissati.<br />
Uno dei primi passi da compiere per riuscire a cambiare una società e i suoi<br />
stili <strong>di</strong> vita non può che essere quello <strong>di</strong> partire dalle azioni governative; è per<br />
questo motivo che il secondo capitolo della mia tesi è stato incentrato sulla<br />
descrizione del Sistema Nazionale INFEA (acronimo <strong>di</strong> Informazione,<br />
Formazione ed Educazione Ambientale). Ho voluto, infatti, mostrare cosa è<br />
stato fatto nel nostro paese a livello sia nazionale, sia locale per sostenere<br />
azioni governative, al fine <strong>di</strong> rispondere ai nuovi accor<strong>di</strong> internazionali.<br />
Partendo, dunque, anche qui con la descrizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse tappe storiche<br />
importanti, come l’accordo tra il Ministero dell’ambiente e quello della<br />
Pubblica Istruzione, si giunge al contesto regionale ed ai programmi che sono<br />
stati realizzati negli ultimi <strong>di</strong>eci anni dal Sistema In.F.E.A. dell’<strong>Emilia</strong><br />
<strong>Romagna</strong>. Questo al fine <strong>di</strong> fornire un quadro <strong>di</strong> riferimento sulla situazione<br />
regionale, formatosi riguardo l’educazione ambientale e l’educazione alla<br />
sostenibilità.<br />
Questa descrizione, inoltre, è <strong>di</strong> aiuto per comprendere in quale contesto si<br />
inserisce il Bando In.F.E.A. 2010, de<strong>di</strong>cato al tema “Comunità scolastica e<br />
sostenibilità dello spazio educativo”, <strong>di</strong> cui tratta il terzo capitolo insieme alla<br />
descrizione della mia esperienza <strong>di</strong> ricerca, sviluppatasi presso la sede del<br />
Servizio Comunicazione ed educazione alla sostenibilità della <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<br />
4
<strong>Romagna</strong>. Attraverso l’esame dei progetti vincitori presentati al Bando, ho<br />
voluto, nel corso <strong>di</strong> questa tesi, rintracciare elementi significativi al fine <strong>di</strong><br />
realizzare un’analisi su quale idea <strong>di</strong> sostenibilità fosse presente oggi nelle<br />
scuole, e quali processi <strong>di</strong> cambiamento si stessero compiendo al loro interno,<br />
per riuscire a realizzare al meglio un’educazione alla sostenibilità,<br />
considerando le nuove responsabilità delle Istituzioni scolastiche.<br />
Sono, infine, elaborate e <strong>di</strong>scusse alcune conclusioni generali, che sintetizzano<br />
quanto emerso dall’intero lavoro svolto, ed è riportata la riflessione e la<br />
proposta per una progettazione futura, che riguar<strong>di</strong> la formazione e<br />
l’educazione non solo delle nuove generazioni, ma anche degli adulti.<br />
5
1<br />
“Non si tratta soltanto <strong>di</strong> dare delle norme <strong>di</strong><br />
comportamento, ma <strong>di</strong> far acquistare una<br />
“mentalità ecologica” che implica<br />
sia l’aspetto razionale che quello emotivo,<br />
sia il modo <strong>di</strong> pensare che quello <strong>di</strong> agire.<br />
L’educazione ambientale è dunque<br />
un’educazione globale:<br />
scientifica, morale, estetica, civica …<br />
È globale perché è globale l’ambiente.”<br />
Clau<strong>di</strong>o Longo<br />
DALL’EDUCAZIONE AMBIENTALE ALL’EDUCAZIONE<br />
ALLA SOSTENIBILITÀ<br />
Se dovessimo definire oggi che cos’è l’educazione ambientale ci troveremmo<br />
sicuramente in <strong>di</strong>fficoltà: cominceremmo a pensare a <strong>di</strong>versi contesti e ambiti<br />
educativi, ma faremmo senz’altro fatica a <strong>di</strong>stinguere esattamente quelli che<br />
ne fanno parte da quelli che ne sono esclusi.<br />
Questo problema è dato dal fatto che essa si è evoluta nel tempo e ha ampliato<br />
i suoi campi d’azione e mo<strong>di</strong>ficato la sua forma; ciò ha fatto si che sia <strong>di</strong>fficile<br />
dare <strong>di</strong> essa una definizione imme<strong>di</strong>ata, in quanto ampia <strong>di</strong> significati e<br />
sfumature.<br />
Per essere più chiara, riporto qui <strong>di</strong> seguito la definizione data da Michela<br />
Mayer che definisce l’educazione ambientale come «un processo, uno<br />
strumento, un metodo che deve essere orientato alla costruzione <strong>di</strong> una società<br />
sostenibile, incentivando nuove identità <strong>di</strong> cura per il territorio e il pianeta a<br />
livello locale e globale. È un processo che alimenta la citta<strong>di</strong>nanza attiva<br />
fondandosi su processi <strong>di</strong> partecipazione, me<strong>di</strong>azione e gestione dei conflitti e<br />
propone contesti e metodologie coerenti con una modalità <strong>di</strong> costruzione della<br />
6
conoscenza che rispetta non solo la complessità e l’incertezza dei fenomeni<br />
sociali e naturali, ma anche la complessità dell’in<strong>di</strong>viduo e l’incertezza del suo<br />
appren<strong>di</strong>mento» (Mayer, 2005: p. 7-8).<br />
In questa definizione troviamo parole importanti come “società sostenibile”,<br />
“nuove identità”, “citta<strong>di</strong>nanza attiva”; prima <strong>di</strong> spiegarle e approfon<strong>di</strong>rle,<br />
ritengo sia utile fare un passo in<strong>di</strong>etro e illustrare quei passaggi storico-politici<br />
significativi che hanno contribuito a mo<strong>di</strong>ficare il ruolo e lo scopo<br />
dell’educazione stessa.<br />
1.1. Storia dello Sviluppo Sostenibile<br />
L’origine del concetto <strong>di</strong> sviluppo sostenibile si deve ricercare nella storia<br />
dell’ecologia e delle politiche per l’ambiente. Gli anni ’60 sono stati testimoni<br />
<strong>di</strong> forti cambiamenti culturali, tra questi molti legati anche all’approccio verso<br />
la natura e il rapporto con essa. All’inizio <strong>di</strong> questi si è assistito alla nascita <strong>di</strong><br />
una delle associazioni ambientali più famose al mondo: il World Wildlife<br />
Fund; verso la loro fine si era ormai formata una cultura ambientale<br />
consapevole in quanto per la prima volta nella storia umana si erano<br />
manifestati i pericoli per la vita futura del pianeta.<br />
Sono cominciate, quin<strong>di</strong>, a insorgere le problematiche legate al rapporto che<br />
l’uomo aveva instaurato con la natura, all’idea <strong>di</strong> questa che stava alla base<br />
dell’atteggiamento umano, e <strong>di</strong> come sarebbe stato possibile mettere in moto<br />
un cambiamento culturale per riuscire a salvaguardare il pianeta e l’umanità<br />
che lo abitava.<br />
Il primo passo concreto verso questa rivoluzione culturale è testimoniato<br />
dall’importante tappa storico-politica che ha contrassegnato la sostenibilità<br />
dello sviluppo nel 1987: il Rapporto Bruntland.<br />
Questo ci pone davanti alla definizione più completa, autorevole e<br />
riconosciuta <strong>di</strong> sviluppo sostenibile, inclusa nel documento “Il futuro <strong>di</strong> tutti<br />
noi: rapporto per la commissione mon<strong>di</strong>ale per l’ambiente e lo sviluppo”<br />
7
elaborato dalla Commissione delle Nazioni Unite guidata dal primo ministro<br />
norvegese Gro Bruntland, il quale ha portato il tema dello sviluppo sostenibile<br />
ufficialmente nel <strong>di</strong>battito internazionale.<br />
«Si intende per sviluppo sostenibile una forma <strong>di</strong> sviluppo<br />
che risponde alle esigenze del presente senza<br />
compromettere la capacità delle generazioni future <strong>di</strong><br />
sod<strong>di</strong>sfare le proprie».<br />
Come ci fa notare Edo Ronchi, questa definizione ci introduce una nozione<br />
che qualifica tale sviluppo sostenibile: quella del tempo; ed è proprio questa<br />
che ha portato ad una prima evoluzione degli approcci dell’educazione e<br />
tematiche ambientali.<br />
«Se le valutazioni ambientali tra<strong>di</strong>zionali sono valutazioni<br />
<strong>di</strong> stato, quin<strong>di</strong> si misura la capacità <strong>di</strong> un certo ambiente<br />
<strong>di</strong> sostenere una certa pressione antropica, lo sviluppo<br />
sostenibile introduce la capacità <strong>di</strong> sostenere queste azioni<br />
antropiche nel tempo».<br />
Ciò che <strong>di</strong>ce Edo Ronchi ci fa riflettere e capire come sia possibile misurare<br />
l’incidenza che le nostre attività antropiche avranno sul nostro futuro e su<br />
quella del pianeta, misurare quin<strong>di</strong> anche la responsabilità del nostro agire e<br />
delle nostre scelte.<br />
A questo proposito è nata l’impronta ecologica: un in<strong>di</strong>ce statistico che misura<br />
la richiesta umana nei confronti della natura; confronta, cioè, quante risorse<br />
consumiamo e quante ne abbiamo a <strong>di</strong>sposizione in spazio per la produzione.<br />
Essa consente quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> rispondere alla domanda: la terra è in grado <strong>di</strong><br />
rigenerare tutte le risorse che noi utilizziamo? Si applica quin<strong>di</strong> il concetto <strong>di</strong><br />
contabilità, ma invece che <strong>di</strong> sol<strong>di</strong> si riferisce alle risorse. In altre parole<br />
8
l’impronta ecologica ci consente <strong>di</strong> misurare l’impatto ambientale dei nostri<br />
consumi quoti<strong>di</strong>ani e vedere la quantità <strong>di</strong> terreno che in un anno ognuno <strong>di</strong><br />
noi occupa con il suo stile <strong>di</strong> vita, e lo fa sommando tutte le superfici <strong>di</strong> terra<br />
che usiamo: per produrre i beni <strong>di</strong> cui ci serviamo e per assorbire i rifiuti che<br />
produciamo.<br />
La sostenibilità si deve affermare come uno dei principi fondamentali nella<br />
definizione delle politiche <strong>di</strong> sviluppo a scala globale, nazionale, regionale e<br />
locale; <strong>di</strong>re questo significa porsi come obiettivo quello <strong>di</strong> riuscire a giungere,<br />
in ogni attività umana, all’equilibrio <strong>di</strong> tre <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni, equamente<br />
importanti: quella economica, quella sociale e quella ambientale.<br />
Queste sono i tre pilastri dello sviluppo sostenibile, le tre “E”: economia,<br />
ecologia, equità.<br />
Si è arrivati a comprendere l’errore <strong>di</strong> compiere scelte con alla base la<br />
prospettiva <strong>di</strong> considerare l’etica, la scienza, la politica e il sociale come campi<br />
separati tra loro e privi <strong>di</strong> connessioni e influenze reciproche; esistono, invece,<br />
interrelazioni continue, ogni <strong>di</strong>mensione influenza l’altra, quin<strong>di</strong> non si può<br />
parlare <strong>di</strong> economia escludendo la sfera sociale o ambientale; ne parlare <strong>di</strong><br />
quella sociale senza considerare il territorio e l’economia.<br />
Seguendo il para<strong>di</strong>gma delle tre “E”, noi oggi possiamo provare a valutare<br />
ogni attività umana cercando <strong>di</strong> sapere quanto si avvicina alla sostenibilità, la<br />
quale verrebbe raggiunta idealmente solo nel momento in cui si dovesse<br />
realizzare il perfetto equilibrio tra economia, ecologia ed equità sociale. Una<br />
tale valutazione potrebbe, inoltre, riuscire a <strong>di</strong>mostrare quanto questa attività<br />
sarà in grado <strong>di</strong> protrarsi nel tempo, e quin<strong>di</strong>, se il territorio potrà rispondere<br />
alle nostre esigenze senza compromettere quelle delle generazioni future.<br />
Oggi, più <strong>di</strong> ieri, possiamo percepire e vivere sulla nostra pelle l’incidenza che<br />
hanno avuto le nostre scelte passate sul pianeta; abbiamo aperto le porte alla<br />
globalizzazione, ma questa non è stata portata avanti seguendo una base <strong>di</strong> un<br />
pensiero sociale, bensì per la maggior parte economico; ogni azione viene per<br />
9
lo più promossa da regole <strong>di</strong> profitto. L’economia è alimentata dal consumo,<br />
paragonato ormai al benessere, che è possibile con la produzione <strong>di</strong> merci;<br />
tutto ciò porta a inquinamento, sfruttamento sociale e delle risorse naturali.<br />
«Una rappresentazione semplicistica designa la globalizzazione come il flusso<br />
libero e integrato <strong>di</strong> merci e capitali da cui <strong>di</strong>pende l’accrescimento della<br />
prosperità su scala mon<strong>di</strong>ale. Ad un’analisi <strong>di</strong>sincantata dell’economia reale,<br />
si verifica negli ultimi decenni l’incremento della <strong>di</strong>suguaglianza tra paesi<br />
ricchi e paesi poveri, nonché l’aggravarsi delle sperequazioni all’interno delle<br />
stesse società dell’Occidente. Il <strong>di</strong>vario tra le popolazioni del mondo non è<br />
mai stato così profondo» (Malavasi, 2008: p.10).<br />
Manifestazione principale e più preoccupante <strong>di</strong> questo impatto globale è la<br />
crisi climatica, oltre alla crisi della bio<strong>di</strong>versità e l’assottigliamento della<br />
fascia d’ozono. Queste rappresentano l’altra faccia dello sviluppo economico e<br />
della globalizzazione, dei nostri stili <strong>di</strong> vita che hanno portato a questo e<br />
quin<strong>di</strong> delle nostre responsabilità.<br />
È proprio qui che comincia a farsi strada l’educazione e il suo nuovo ruolo.<br />
Nel comprendere l’impatto che ha il nostro stile <strong>di</strong> vita attuale sul pianeta,<br />
possiamo anche capire che, se questo non verrà sostituito con uno più eco-<br />
compatibile, saremo responsabili noi delle carenze che avranno le generazioni<br />
future, ed anche dei possibili problemi che si verificheranno a livello<br />
ambientale.<br />
Per cercare quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> attenuare il più possibile questi eventi occorre formare<br />
una nuova popolazione, una citta<strong>di</strong>nanza più attiva, più sensibile e più<br />
responsabile sulle tematiche sociali e ambientali, ed inoltre mo<strong>di</strong>ficare i nostri<br />
stili <strong>di</strong> vita, per un futuro più equo e sostenibile. E’ proprio all’educazione che<br />
spetta questo ruolo importante.<br />
10
1.2. Agenda 21<br />
Abbiamo parlato del rapporto Bruntland e <strong>di</strong> cosa implica la sua definizione <strong>di</strong><br />
sviluppo sostenibile, cioè il raggiungimento dell’equilibrio tra l’aspetto<br />
economico, ecologico e sociale.<br />
Acquisita la consapevolezza della necessità <strong>di</strong> questo modo <strong>di</strong> operare e<br />
compiere scelte, in quanto non ci possiamo più permettere <strong>di</strong> andare avanti<br />
con uno sviluppo privo <strong>di</strong> sostenibilità, gli stati si sono mossi per sviluppare<br />
un programma d’azione appropriato.<br />
Nel 1992 con la Conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro, fu<br />
sottoscritta da circa 180 Paesi il programma de<strong>di</strong>cato allo sviluppo sostenibile<br />
chiamato Agenda 21, il quale <strong>di</strong>ede il via a una grande partita <strong>di</strong> conseguenze:<br />
è a Rio, infatti, che possiamo far cominciare l’epoca che viviamo, cioè quella<br />
del passaggio dallo sviluppo quantitativo dell’economia classica allo sviluppo<br />
qualitativo.<br />
«L’Agenda 21 <strong>di</strong> Rio resta a tutt’oggi uno dei documenti<br />
fondamentali della cultura ambientale e dello sviluppo<br />
sostenibile a livello mon<strong>di</strong>ale, una pietra miliare<br />
ineguagliata della cultura politica per un futuro sostenibile<br />
del nostro pianeta» (Beccastrini, Cipparone, 2005: p.67).<br />
Questa ha stimolato l’introduzione <strong>di</strong> nuovi strumenti, il coinvolgimento e la<br />
responsabilizzazione dei <strong>di</strong>versi settori sociali ed economici, ha riorientato<br />
politiche pubbliche e attività private verso i nuovi obiettivi strategici. Infine,<br />
anche l’educazione ambientale ha tratto da quel documento fondamentali<br />
stimoli per ridefinire il suo compito.<br />
Con essa si sono definiti gli in<strong>di</strong>rizzi strategici per l’attuazione <strong>di</strong> uno sviluppo<br />
sostenibile; si sono fissati traguar<strong>di</strong> da raggiungere e delle scadenze da<br />
11
ispettare; forse proprio per queste incombenze, nel nome viene in<strong>di</strong>cato il<br />
numero 21: ad evidenziare il ventunesimo secolo, che porta in sé le emergenze<br />
climatiche - ambientali e socio - economiche.<br />
Il Programma proponendosi come linea guida ha significato una svolta, cioè il<br />
passaggio dall’astratto al concreto per conseguire gli obiettivi, tutti equamente<br />
importanti, a livello globale, nazionale, regionale, locale.<br />
L’Agenda 21 è composta da 40 capitoli, <strong>di</strong>visi in quattro sezioni:<br />
Sezione I: Dimensioni Sociali ed Economiche<br />
include la lotta alla povertà, il cambiamento della struttura dei consumi, della<br />
popolazione e delle <strong>di</strong>namiche demografiche, la promozione della salute e dei<br />
programmi sostenibili <strong>di</strong> popolamento, e l'integrazione delle problematiche<br />
relative all'ambiente e allo sviluppo nel processo <strong>di</strong> decision-making.<br />
Sezione II: Conservazione e Gestione delle Risorse per lo Sviluppo<br />
comprende la protezione dell'atmosfera, la lotta alla deforestazione, la<br />
protezione degli ambienti deboli, la conservazione della <strong>di</strong>versità biologica<br />
(bio<strong>di</strong>versità), e il controllo dell'inquinamento.<br />
Sezione III: Rafforzamento del ruolo dei Major Groups<br />
comprende i ruoli dei gruppi <strong>di</strong> rappresentanza dei bambini e dei giovani, delle<br />
donne, delle ONG (Organizzazioni Non Governative, ve<strong>di</strong> anche NGO), delle<br />
autorità locali, del commercio e dei lavoratori.<br />
Sezione IV: Mezzi per l'Esecuzione (del programma)<br />
comprende la scienza, la <strong>di</strong>ffusione della tecnologia, l'educazione, le<br />
istituzioni internazionali e i meccanismi <strong>di</strong> finanziamento.<br />
Osservando questi obiettivi, possiamo sottolineare come questo programma<br />
d’azione sia tanto ambizioso quanto necessario. Emerge l’importanza <strong>di</strong> un<br />
12
a<strong>di</strong>camento e una <strong>di</strong>ffusione in primo luogo dal basso, con un forte impegno<br />
quin<strong>di</strong> delle comunità locali (agire nel micro), per giungere agli scopi<br />
prefissati e avere una rivoluzione globale (del macro).<br />
«Esiste un legame tra quello vicino e quoti<strong>di</strong>ano e quello che è eccezionale.<br />
Non si può lavorare per il clima se non si controllano e non si leggono i<br />
fenomeni anche nel micro quoti<strong>di</strong>ano» (Guerra, L. 2009: p.107).<br />
È necessario collocare le azioni educative alla scala dei processi globali<br />
(clima, conflitti, povertà), ma anche a quella delle <strong>di</strong>namiche economiche e<br />
sociali del nostro territorio.<br />
Non si può, infatti, parlare <strong>di</strong> sviluppo sostenibile se nella sua costruzione non<br />
c’è una forte partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni; questo non è semplicemente un<br />
problema <strong>di</strong> democrazia, ma si tratta dell’impossibilità <strong>di</strong> compiere una scelta<br />
sostenibile senza la con<strong>di</strong>visione della stragrande maggioranza della comunità;<br />
deve quin<strong>di</strong> avvenire una naturale adesione dei citta<strong>di</strong>ni a questa nuova<br />
prospettiva <strong>di</strong> vita in quanto non si possono ottenere risultati imponendola.<br />
Il documento fondamentale per la realizzazione del programma a livello locale<br />
è la Carta <strong>di</strong> Aalborg, piccola città della Danimarca in cui nel 1994 un gruppo<br />
<strong>di</strong> enti locali si è riunito spontaneamente su invito del sindaco, il quale ha<br />
pensato <strong>di</strong> dare vita a una rete che si connettesse in modo nuovo, senza passare<br />
attraverso la gerarchia degli stati, per scambiare liberamente opinioni e<br />
esperienze allo scopo <strong>di</strong> promuovere nel nostro continente lo sviluppo<br />
sostenibile.<br />
«La Carta <strong>di</strong> Aalborg è il comune denominatore <strong>di</strong> tutti gli enti locali che<br />
vogliono promuovere attraverso i principi e i meto<strong>di</strong> dell’Agenda 21 lo<br />
sviluppo sostenibile» (Nora, E. 2005: p. 60).<br />
Essa contiene in<strong>di</strong>cazioni riguardo a fasi, strumenti, modalità per sviluppare i<br />
processi promossi dalle autorità locali.<br />
È così nata l’Agenda 21 locale: principale strumento <strong>di</strong> realizzazione degli<br />
impegni che una comunità assume per raggiungere obiettivi <strong>di</strong> sviluppo<br />
13
sostenibile; essa è un passaggio chiave in quanto crea un collegamento tra le<br />
decisioni assunte dai governi e le azioni che devono essere compiute a livello<br />
periferico.<br />
«L’Agenda 21 locale è un processo, una sequenza <strong>di</strong> fasi partecipate, dentro<br />
ognuna delle quali ci sono delle cose da fare per un obiettivo finale» (Nora, E.<br />
2005: p. 61); grazie a questa definizione possiamo già acquisire la<br />
consapevolezza <strong>di</strong> quanto sia importante aprire le nostre prospettive ad un<br />
approccio sistemico, in altre parole possiamo comprendere quanto ogni azione<br />
o attività possa mo<strong>di</strong>ficare e influenzare il sistema.<br />
Il grado <strong>di</strong> evoluzione delle esperienze <strong>di</strong> Agenda 21 locale varia<br />
significativamente a livello europeo. I processi <strong>di</strong> questa, nei paesi del Nord -<br />
Europa, in particolare Inghilterra, Olanda, Paesi Scan<strong>di</strong>navi, sono iniziati<br />
precocemente da metà anni '90 con un'ampia <strong>di</strong>ffusione e un consistente<br />
impulso da parte dei Governi centrali.<br />
Negli ultimi anni la tendenza si sta invertendo. I paesi me<strong>di</strong>terranei, in<br />
particolare Spagna e Italia, si segnalano come i nuovi centri dove si<br />
manifestano i maggiori fermenti <strong>di</strong> coinvolgimento da parte delle autorità<br />
locali sull'Agenda 21. Questo accade nonostante il fenomeno appaia ancora<br />
nella sua fase iniziali rispetto alle esperienze del Nord-Europa già consolidate<br />
da tempo e rivolte verso un'evoluzione dei processi e una maggiore<br />
integrazione nell'ambito delle politiche <strong>di</strong> sostenibilità.<br />
A questo proposito mi è sembrato interessante considerare nella mia tesi le<br />
iniziative che si sono sviluppate in Italia e, nello specifico, all’interno della<br />
regione in cui ci troviamo: l’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>.<br />
1.3. Il Senso <strong>di</strong> un’ Educazione Ambientale<br />
L’ambiente ha sempre avuto un posto <strong>di</strong> rilievo in campo educativo. Già dai<br />
“padri fondatori” dell’educazione europea, come Locke, Rousseau, Pestalozzi,<br />
14
Froebel, veniva considerata la sua valenza educativa in quanto complessa e<br />
variegata realtà naturale e culturale, che rimanendo fuori dall’aula scolastica,<br />
era una preziosa fonte <strong>di</strong> esperienze, <strong>di</strong> risorse, <strong>di</strong> scoperte educative che<br />
permeavano tutte le fasi <strong>di</strong> sviluppo dell’in<strong>di</strong>viduo (Beccastrini, 2005).<br />
Volendo anche uscire dal contesto pedagogico, emerge comunque che tutta la<br />
storia dell’umanità è costellata <strong>di</strong> uomini che si sono interrogati circa il senso<br />
delle relazioni uomo-natura come ad esempio San Francesco, Leonardo da<br />
Vinci, che hanno praticato e <strong>di</strong>ffuso l’educazione ambientale prima ancora che<br />
questa nascesse. La coscienza ambientale è dunque sempre esistita. Oggi,<br />
questa non servirebbe se l’umanità avesse seguito la saggezza ecologica e<br />
avesse, quin<strong>di</strong>, vissuto come parte del sistema naturale rispettandolo senza<br />
invece arrivare a un rapporto <strong>di</strong> sfruttamento (Angelini e Pizzuto, 2007).<br />
Nonostante l’importanza della natura nel processo formativo ed educativo, con<br />
l’affermarsi della modernità l’asse culturale portante si è andato<br />
progressivamente spostando verso l’uomo e la tecnologia a tutto sfavore<br />
dell’ambiente.<br />
La fiducia nella tecnologia e nella scienza e il loro sviluppo hanno fatto quasi<br />
completamente <strong>di</strong>menticare che l’uomo è parte <strong>di</strong> sistemi più ampi da cui<br />
<strong>di</strong>pende.<br />
Quando si è compreso che il rapporto uomo-natura era basato sullo<br />
sfruttamento delle risorse globali per l’aumento costante della produzione ai<br />
fini del consumo, dovuto inoltre solamente ad una parte della popolazione<br />
mon<strong>di</strong>ale e cioè quella ricca, ci si rese conto che occorreva più che mai un<br />
cambiamento culturale che portasse a pratiche più eco-compatibili.<br />
L’Educazione Ambientale è dunque nata come rime<strong>di</strong>o per contrastare un<br />
danno.<br />
Un danno non solo ambientale, ma anche sociale rivelato anche dai dati sulla<br />
<strong>di</strong>sparità economica più recenti. «A fronte <strong>di</strong> una crescita economica globale<br />
enorme (dal 1950 al 1996 il Pil mon<strong>di</strong>ale è passato da 4.000 a 23.000 miliar<strong>di</strong><br />
15
<strong>di</strong> dollari), il 75% della popolazione mon<strong>di</strong>ale vive nel sud e fruisce solo del<br />
16% della ricchezza. Il nord, invece, consuma due terzi dei metalli e del<br />
legname, il 70% dell’energia, il 60% del cibo a livello mon<strong>di</strong>ale. Alla luce <strong>di</strong><br />
una tale <strong>di</strong>stribuzione della ricchezza, oggi si calcolano nel mondo circa 1300<br />
milioni <strong>di</strong> poveri assoluti (meno <strong>di</strong> 365 dollari annui)» (Angelini e Pizzuto,<br />
2007: p. 238).<br />
Con queste percentuali a noi paesi sviluppati viene “sbattuto in faccia” la<br />
conseguenza del nostro “non pensiamoci” e della nostra confusione, riguardo a<br />
cosa è oggi un bisogno primario e a cosa è invece solo un bisogno secondario.<br />
Confondendo i secon<strong>di</strong> con i primi, siamo arrivati a volere sempre <strong>di</strong> più senza<br />
preoccuparci delle conseguenze, che sono l’aver privato dei beni primari <strong>di</strong><br />
sussistenza i popoli sottosviluppati, e questo per la nostra mania del<br />
consumare e <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare qualsiasi nostro capriccio. La responsabilità <strong>di</strong> tutto<br />
questo però non è solamente del singolo in<strong>di</strong>viduo, ma <strong>di</strong> chi ha voluto<br />
trasformare la nostra società in un sistema <strong>di</strong> consumo senza farcene rendere<br />
conto.<br />
Nel mio caso, il documentario <strong>di</strong> Luis Fox del 2009, che mostra il ciclo <strong>di</strong> vita<br />
<strong>di</strong> un oggetto sotto una visione critica della società consumista, è stato<br />
illuminante e mi ha fatto capire il mio ruolo <strong>di</strong> “consumatrice” in questo<br />
progetto del consumo: il video in questione si chiama “The History of Stuff”.<br />
In esso appare molto chiaro perché oggi abbiamo bisogno <strong>di</strong> abbandonare la<br />
nostra visione illusoria che ci aiuta a non sentirci responsabili e rimboccarci le<br />
maniche per cambiare un sistema che è folle: noi viviamo in un mondo finito,<br />
ma il nostro sistema <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong> vita è lineare, cioè noi estrapoliamo,<br />
produciamo, acquistiamo, consumiamo e buttiamo via.<br />
Se analizziamo ogni passaggio possiamo notare quanto non possa essere una<br />
soluzione infinita:<br />
estrapoliamo senza controllo e senza preoccuparci del fatto che la terra<br />
non riesce più a rigenerarsi, pur sapendo che ne abbiamo una sola;<br />
16
produciamo senza rispettare la forza lavoro, infatti per lo più oggi si<br />
produce nei paesi sottosviluppati sfruttando bambini e donne, e non si<br />
tiene conto dell’inquinamento ambientale che si produce senza un<br />
controllo sulla produzione;<br />
acquistiamo perché siamo abituati ad associare il nostro benessere con<br />
il consumismo, quin<strong>di</strong> compriamo senza regole e vogliamo sempre <strong>di</strong><br />
più senza però esser mai sod<strong>di</strong>sfatti, e cosa più triste siamo arrivati a<br />
vivere per lavorare e per poter quin<strong>di</strong> permetterci <strong>di</strong> consumare, questo<br />
infatti non è più associato ad una esigenza primaria, ma sono tutti<br />
“sfizi” secondari, che però noi percepiamo come primari, <strong>di</strong>menticando<br />
che però la nostra tracotanza va ad intaccare popolazioni che a causa<br />
nostra non riescono nemmeno più a sod<strong>di</strong>sfare i bisogni primari;<br />
il passaggio dal consumo all’eliminazione è purtroppo breve, infatti<br />
spesso finiamo per eliminare cose che non sono nemmeno vecchie, ma<br />
la moda ci fa percepire che lo sono, e nel buttare via avviene lo spreco<br />
più grande, che poi come <strong>di</strong>ce Goleman <strong>di</strong>re “buttare via” è<br />
un’illusione perché in realtà tutti i rifiuti non vanno da nessuna parte,<br />
rimangono qua nella stessa terra che noi abitiamo.<br />
Tutto questo noi non possiamo più trascurarlo e dobbiamo imparare ad<br />
assumerci le responsabilità delle nostre scelte e riuscire ad aiutare le nuove<br />
generazioni a crescere con un modello culturale nuovo, privo della schiavitù al<br />
consumismo e più virtuoso e consapevole delle tematiche ambientali e sociali,<br />
per riuscire a passare da questo modello lineare ad un sistema circolare che<br />
prevede più riciclo, energia verde, più rispetto sociale, zero inquinamento.<br />
L’educazione dovrebbe aiutare in questo processo e fare sviluppare nuove<br />
linee interpretative e nuovi pensieri <strong>di</strong> azione sostenibile e responsabile,<br />
sviluppando una citta<strong>di</strong>nanza attiva capace <strong>di</strong> orientarsi nel cambiamento in<br />
modo consapevole. Per riuscire in questo, l’educazione ambientale è uno<br />
strumento in<strong>di</strong>spensabile.<br />
17
1.4. “<strong>Ambiente</strong>” e Modello Dialogico<br />
Volendo parlare dei cambiamenti avvenuti all’interno dell’educazione<br />
ambientale rispetto alle sue origini, ci terrei a sottolineare l’evoluzione che è<br />
avvenuta nell’interpretare l’ambiente stesso.<br />
Durante gli anni ’70 chi si occupava <strong>di</strong> educazione ambientale il significato<br />
che attribuiva all’ambiente era <strong>di</strong> “ambiente naturale”. In seguito al Rapporto<br />
Bruntland, quin<strong>di</strong> con l’introduzione del concetto <strong>di</strong> sviluppo sostenibile e con<br />
la concezione della natura come eco-sistema complesso caratterizzato dalla<br />
relazione tra attività antropica, contesto bio - sferico e socio - culturale,<br />
l’educazione ambientale trasforma il significato attribuito all’ambiente,<br />
facendolo <strong>di</strong>ventare una realtà inter<strong>di</strong>sciplinare complessa <strong>di</strong> cui non è<br />
possibile parlare tenendo in considerazione esclusivamente un solo aspetto <strong>di</strong><br />
essa.<br />
«L’ambiente è ciò che ci circonda, materialmente e<br />
socialmente. Noi lo definiamo come tale servendoci delle<br />
nostre categorie interpretative in<strong>di</strong>viduali e imposte<br />
culturalmente, ed esso esiste come ambiente nel momento<br />
in cui gli <strong>di</strong>amo un nome e lo dotiamo <strong>di</strong> significato.<br />
Pertanto l’ambiente non è qualcosa che abbia una realtà<br />
totalmente esterna o separata da noi e dal nostro contesto<br />
sociale. Deve piuttosto essere considerato come la<br />
risultante delle interazioni concettuali tra il nostro<br />
ambiente fisico e le forze sociali, politiche ed economiche<br />
che ci organizzano all’interno <strong>di</strong> tale contesto. E’ in questo<br />
senso che il concetto <strong>di</strong> “ambiente” è costruito<br />
socialmente. E se consideriamo l’ambiente un costrutto<br />
sociale, allora accettiamo che certe sue qualità possono<br />
essere cambiate o trasformate a seconda dei rapporti<br />
sociali vigenti» (Bardulla E., 1998: p. 201).<br />
18
Ve<strong>di</strong>amo qui dunque l’ampliamento <strong>di</strong> significato che è avvenuto nel concetto<br />
“ambiente”. Dall’inizio delle considerazioni su <strong>di</strong> esso, grazie anche alle<br />
pratiche <strong>di</strong> educazione ambientale realizzate in <strong>di</strong>fferenti contesti, si è<br />
arricchito <strong>di</strong>ventando un ambito inter<strong>di</strong>sciplinare.<br />
Da quando è nata l’Educazione Ambientale sono stati sperimentati molti mo<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> praticarla da <strong>di</strong>versi attori (scuole, terzo settore con le Associazioni<br />
ambientaliste e le Ong, alcuni movimenti Aree Protette, Agenzie<br />
internazionali, Università) ed in <strong>di</strong>fferenti contesti e ne è emerso un panorama<br />
altamente <strong>di</strong>fferenziato del modo <strong>di</strong> intenderla.<br />
Prendendo in considerazione le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> approcci e meto<strong>di</strong> Giovanni<br />
Borgarello descrive questo quadro poliedrico riconducendo le <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong><br />
approcci e meto<strong>di</strong> a 6 modelli principali (Angelini A. e Pizzuto P., 2007):<br />
la ricerca d’ambiente, che prevede il contatto con la realtà esterna e<br />
quin<strong>di</strong> la scoperta del territorio vivendo il quartiere come aula;<br />
la <strong>di</strong>dattica naturalistica, cioè la trasmissione <strong>di</strong> informazioni<br />
riguardanti la biologia, sociologia, botanica, ecologia; la convinzione<br />
qui più <strong>di</strong>ffusa è che sia sufficiente far conoscere la natura per orientare<br />
i comportamenti verso la sua <strong>di</strong>fesa e la sua conservazione;<br />
l’educazione ecologica, approccio inter<strong>di</strong>sciplinare con una visione<br />
sistemica e complessa della <strong>di</strong>dattica naturalistica dove si integrano gli<br />
aspetti sociali, politici, economici, storici, geografici, l’uomo è ancora<br />
separato dalla natura;<br />
modello etico - formativo, vuole <strong>di</strong>vulgare pratiche virtuose per<br />
l’ambiente;<br />
modello <strong>di</strong>sciplinari;<br />
modello <strong>di</strong>alogico.<br />
19
Il modello <strong>di</strong>alogico guida la riflessione dell’Educazione Ambientale a livello<br />
nazionale e internazionale, infatti è proprio questo che si è affermato nel corso<br />
degli anni ’90 e che attualmente è considerato un punto <strong>di</strong> riferimento per la<br />
maggior parte degli attori <strong>di</strong> questo settore educativo. L’ottica sistemica<br />
acquista un’importanza centrale e l’approccio metodologico è <strong>di</strong> ricerca ed<br />
ecologico. Il soggetto ha ruolo centrale e la riflessione educativa si intreccia<br />
con quella ambientale. L’approccio contenutistico, con la predominanza <strong>di</strong> tale<br />
modello, è oggi ormai completamente sorpassato. L’accento è sulle modalità<br />
<strong>di</strong> svolgimento dei processi educativi, cioè sulla qualità del processo <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>mento e non più sulla quantità <strong>di</strong> informazioni trasmesse. Assume una<br />
forte rilevanza l’integrazione e il <strong>di</strong>alogo continuo tra gli attori coinvolti e il<br />
lavoro in rete.<br />
Questo modello ha rappresentato un punto <strong>di</strong> riferimento comune per<br />
l’Accordo <strong>di</strong> programma in materia In.F.E.A. tra Stato, Regioni e Province<br />
autonome (Conferenza Stato-Regioni, 2000), <strong>di</strong> cui approfon<strong>di</strong>rò il <strong>di</strong>scorso in<br />
seguito.<br />
Secondo il nuovo modello interpretativo dell’Educazione Ambientale è<br />
fondamentale la promozione <strong>di</strong> «un approccio conoscitivo (il pensiero<br />
ecologico) che metta in evidenza le relazioni <strong>di</strong> profonda e complessa<br />
inter<strong>di</strong>pendenza esistenti tra i fenomeni su scala globale e le relazioni <strong>di</strong><br />
inter<strong>di</strong>pendenza tra i vari soggetti (persone, istituzioni, associazioni . . .) che<br />
su scala locale concorrono nel generarli (intreccio locale – globale )»<br />
(Angelini A. e Pizzuto P., 2007: p.229).<br />
È cambiato quin<strong>di</strong> il modo <strong>di</strong> intenderla.<br />
Sono cambiati i soggetti: non sono più soltanto bambini e ragazzi, ma anche<br />
adulti. I semplici citta<strong>di</strong>ni vanno coinvolti nei processi <strong>di</strong> Educazione<br />
Ambientale e accanto a loro anche coloro che amministrano, coloro che<br />
governano e come tali prendono le decisioni, e coloro che hanno le<br />
competenze tecniche per intervenire.<br />
20
Sono cambiati i contesti: non si opera più soltanto a scuola o nell’università,<br />
nei centri <strong>di</strong> formazione o nei Cea (centri <strong>di</strong> educazione ambientale), ma la<br />
sfida è portare avanti i processi <strong>di</strong> sviluppo sostenibile territoriale.<br />
Sono cambiati i mo<strong>di</strong>: non più unità <strong>di</strong>dattiche o percorsi educativi e<br />
formativi, ma processi <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento in contesti complessi.<br />
È necessario che le istituzioni scolastiche comprendano questo ampliamento <strong>di</strong><br />
pensiero per poter agire in un’ottica sistemica, per non limitare le loro azioni<br />
educative nello spazio scuola, ma aprirsi al territorio ed aiutare la “società<br />
educante” nell’attivare quei cambiamenti importanti. Si parla <strong>di</strong> un’importante<br />
responsabilità che alla scuola viene attribuita, questa però dev’essere colta per<br />
riuscire effettivamente a produrre quelle mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> comportamento e <strong>di</strong><br />
modo <strong>di</strong> pensare auspicabile per giungere a quegli obiettivi <strong>di</strong> Agenda 21<br />
prefissati a livello internazionale.<br />
1.5. Definizioni in Divenire<br />
L’evoluzione interna avvenuta nella concezione <strong>di</strong> Educazione Ambientale la<br />
si può raccontare anche attraverso le sue definizioni in <strong>di</strong>venire nel tempo e i<br />
suoi cambiamenti intrinseci.<br />
Una delle prime definizioni dell’Educazione Ambientale, è stata data dalla<br />
Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) nel 1970:<br />
«l’Educazione Ambientale è il processo <strong>di</strong> riconoscimento<br />
dei valori e <strong>di</strong> chiarimento dei concetti in or<strong>di</strong>ne allo<br />
sviluppo <strong>di</strong> capacità ed attitu<strong>di</strong>ni necessarie per capire ed<br />
apprezzare le interrelazioni tra l’uomo, la sua cultura e<br />
l’ambiente biofisico che lo circonda. L’EA coinvolge i<br />
processi decisionali e la formazione <strong>di</strong> un co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />
comportamento per il raggiungimento degli obiettivi della<br />
qualità ambientale» (Cipparone, 2005, p.33).<br />
21
Rileva l’importanza <strong>di</strong> prendere coscienza dell’inter<strong>di</strong>pendenza che lega i<br />
sistemi umani (cultura, economia e società) a quelli naturali e invita ad un<br />
conseguente cambiamento <strong>di</strong> comportamento.<br />
Sulla base dell’esperienza maturata dopo un ventennio <strong>di</strong> attività nel 1993 la<br />
Commissione Educazione della Iucn prova cosi a ridefinirla:<br />
«L’Educazione Ambientale è un processo per mezzo del<br />
quale gli in<strong>di</strong>vidui acquisiscono consapevolezza ed<br />
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e<br />
scambiano conoscenze, valori, attitu<strong>di</strong>ni, esperienze, come<br />
anche la determinazione e la motivazione che li metterà in<br />
grado <strong>di</strong> agire, in<strong>di</strong>vidualmente o collettivamente, per<br />
risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente»<br />
(ibidem).<br />
In questa definizione l’Educazione Ambientale appare come uno strumento in<br />
mano agli uomini, che con la loro partecipazione possono contribuire alla<br />
risoluzione della crisi ambientale.<br />
E’ la partecipazione la chiave <strong>di</strong> volta della concezione Iucn.<br />
1.6 L’Educazione Ambientale Oggi<br />
Il termine “educazione ambientale” è nato alla fine degli anni ’60 in seguito<br />
alle prime manifestazioni delle problematiche ambientali, dovute al mancato<br />
rispetto dei tempi necessari al pianeta per la sua rigenerazione <strong>di</strong> materie<br />
prime e il mantenimento dei suoi equilibri ecologici.<br />
Dalla sua apparizione nei documenti <strong>di</strong> carattere internazionale, non è rimasta<br />
immutata nella sua forma, ma si è evoluta fino ad oggi mo<strong>di</strong>ficando significati,<br />
obiettivi, metodologie, esperienze concrete.<br />
22
Questi cambiamenti si sono verificati in seguito alle nuove tematiche<br />
internazionali, descritte precedentemente, ed anche in seguito alle analisi delle<br />
esperienze sul campo: si è passati, infatti, da una generica sensibilizzazione e<br />
conoscenza della natura e dalla rincorsa alle emergenze ambientali, ad<br />
un'educazione alla sostenibilità. Il cambiamento <strong>di</strong> prospettiva cruciale che è<br />
avvenuto nell’Educazione Ambientale è stato il passaggio «da un’educazione<br />
per la conservazione della natura, cioè <strong>di</strong>fensiva e reattiva, a un’educazione<br />
ambientale per lo sviluppo sostenibile, cioè preventiva e proattiva».<br />
«Da Rio in poi cultura e azione ambientale non significa<br />
più soltanto “conservare la natura” o riparare i danni in<br />
coda ai processi produttivi, ma riorientare sulla qualità<br />
sociale e ambientale l’intero modo <strong>di</strong> produrre e<br />
consumare dei citta<strong>di</strong>ni del pianeta»<br />
(Bertolini S., 2005: p.18).<br />
In questo senso significa puntare ad una politica preventiva e proattiva invece<br />
<strong>di</strong> conservativa e reattiva.<br />
L’Educazione Ambientale oggi è considerata uno strumento importante per<br />
compiere una rivoluzione ecologica del sapere e quin<strong>di</strong> per promuovere lo<br />
sviluppo sostenibile e consapevole; la si identifica come una <strong>di</strong>mensione<br />
educativa permanente e globale che coinvolge l’istruzione scolastica, la<br />
sensibilizzazione dei citta<strong>di</strong>ni, la formazione professionale, la ricerca<br />
(Bertolini, 2005).<br />
Nelle prime esperienze <strong>di</strong> educazione ambientale veniva ritenuto sufficiente<br />
conoscere meglio l’ambiente per comportarsi conseguentemente in modo più<br />
responsabile nei suoi confronti; assumevano quin<strong>di</strong> un carattere nozionistico<br />
dando importanza per lo più ai contenuti, spesso trasmessi da libri che<br />
decontestualizzavano l’ambiente stesso.<br />
23
Come ci mostra Edgar Morin nel suo libro “La testa ben fatta” l’Educazione<br />
Ambientale si colloca all’interno delle gran<strong>di</strong> trasformazioni culturali e<br />
scientifiche contemporanee, nell’orizzonte <strong>di</strong> una riforma ecologica del sapere<br />
verso un para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong> complessità (Morin, 2000).<br />
Ed è proprio questo para<strong>di</strong>gma che ha permesso all’Educazione Ambientale <strong>di</strong><br />
cogliere il suo approccio statico, come inadatto alla società ricca<br />
d'interconnessioni, e che l’ha portata ad ampliarsi unendo ai suoi saperi<br />
ambientali anche i saperi sociali ed economici.<br />
L’educazione alla sostenibilità cerca <strong>di</strong> sviluppare le conoscenze, i valori e le<br />
abilità operative necessarie perché la gente possa collaborare al miglioramento<br />
della qualità e sostenibilità del proprio ambiente naturale e sociale.<br />
«L’EA cerca <strong>di</strong> fornire nel corso del tempo esperienze <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>mento tramite le quali <strong>di</strong>venti possibile occupare<br />
un posto nella società come citta<strong>di</strong>ni informati, impegnati e<br />
attivi, capaci <strong>di</strong> fare la propria parte per rendere la società<br />
un luogo migliore in cui vivere, prendendosi cura delle<br />
necessità <strong>di</strong> tutte le specie e denunciando e combattendo le<br />
ingiustizie sociali ed ecologiche» (Bardulla, 1998: p. 201).<br />
Rende dunque consapevoli i singoli dell’impatto che tanto sulla società quanto<br />
sugli ecosistemi viene esercitato dall’attuale sistema economico e sociale; per<br />
questo punta allo sviluppo negli allievi delle conoscenze e abilità politiche<br />
necessarie per partecipare a pieno titolo al cambiamento <strong>di</strong> tale sistema. Fare<br />
educazione per l’ambiente è tutto questo.<br />
Per come viene interpretata e trasmessa l’educazione ambientale <strong>di</strong> oggi<br />
l’ambiente non è più l’unico insegnamento e obiettivo. L’educazione allo<br />
sviluppo sostenibile è infatti «un concetto ampio che trae origine<br />
dall’educazione ambientale, ma che non si limita ad essa e rafforza<br />
quell’approccio integrato che mette in relazione <strong>di</strong>verse tematiche da<br />
24
affrontare sia a livello locale che globale, come la citta<strong>di</strong>nanza attiva, la pace,<br />
la democrazia, i <strong>di</strong>ritti umani, lo sviluppo equo solidale, la tutela della salute,<br />
la protezione dell’ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali»<br />
(DGR N°1271/2008).<br />
Dunque ci si prefigge come obiettivo quello <strong>di</strong> cogliere la sistematicità degli<br />
elementi, economici e sociali, che interagiscono e influenzano l’ambiente.<br />
L’educazione ambientale deve considerare nel suo processo educativo questi<br />
tre aspetti e farli emergere costantemente nelle loro connessioni, poiché è solo<br />
imparando a vedere l’ambiente, non più inteso esclusivamente come realtà<br />
naturale, ma anche come contesto economico e sociale <strong>di</strong> cui facciamo parte,<br />
che si arriva a comprende l’interconnessione presente e si impara a valutare<br />
ogni situazione nella sua complessità. Se prima si focalizzava l’attenzione<br />
sull’ambiente oggi la prospettiva si è spostata allargandosi e si riesce a vedere<br />
che questo è inter<strong>di</strong>pendente dalla sfera sociale ed economica.<br />
Lo sviluppo sostenibile si può intendere, in termini generali, come modello<br />
economico pienamente compatibile con l’ecosistema della terra in termini<br />
fisici e biochimici. Per arrivare quin<strong>di</strong> ad una gestione delle risorse<br />
responsabile, dobbiamo occuparci <strong>di</strong> tutte le tre sfere importanti in egual<br />
misura.<br />
L’educazione deve far cogliere fin da subito alle nuove generazioni questa<br />
realtà complessa e abituarli a tenerla sempre in considerazione nelle loro<br />
valutazioni e attività, per sviluppare le capacità utili a far fronte alle<br />
problematiche del futuro.<br />
Una nuova educazione ambientale tiene conto dei legami tra ambiente e<br />
educazione, punta alla qualità del processo d’appren<strong>di</strong>mento valorizzando i<br />
meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> una comunicazione educativa e mantenendo importante lo sviluppo<br />
meta cognitivo dell’in<strong>di</strong>viduo. Aggiungerei anche che oggi si presta molta<br />
attenzione alla “partecipazione” poiché è proprio questa che consente <strong>di</strong> fare<br />
esperienza, ed è l’esperienza che innesca un’evoluzione/riflessione interna che<br />
aiuta a giungere fino all’appren<strong>di</strong>mento.<br />
25
2<br />
SISTEMA IN.F.E.A.<br />
Nella prima parte del mio lavoro ho parlato dell’importanza <strong>di</strong> arrivare a<br />
sviluppare una cultura sostenibile per una società del presente e del futuro.<br />
L’obiettivo che ci si pone è complesso e <strong>di</strong>fficile in quanto richiede una<br />
rivoluzione noologica 1 , ma non impossibile e comunque necessario. La<br />
<strong>di</strong>fficoltà sta nel trovare la metodologia e il processo d’avviamento giusto e<br />
ricco <strong>di</strong> sviluppi e riscontri.<br />
Il primo passo per riuscire a cambiare una società e i suoi stili <strong>di</strong> vita non può<br />
che partire dalle azioni governative, se non partono da queste, infatti, i<br />
cambiamenti legati ai nostri stili <strong>di</strong> vita saranno <strong>di</strong>fficili da attuarsi, e gli sforzi<br />
fatti da molte associazioni e volontari sensibili alle tematiche ambientali e<br />
sociali potranno solamente avere un impatto limitato rispetto al globale.<br />
Occorre, inoltre, mantenere sempre presente la consapevolezza che bisogna<br />
lavorare su tempi lunghi, per dare senso all’educazione per lo sviluppo<br />
sostenibile (ciò ce lo fa presente: la costruzione dei sistemi regionali, i<br />
processi formativi e partecipativi, i sistemi <strong>di</strong> valutazione e <strong>di</strong> monitoraggio, il<br />
long life learning).<br />
È qui che si introduce il tema <strong>di</strong> cui tratterò in questo capitolo: il Programma<br />
Nazionale e Regionale In.F.E.A.<br />
1 Per rivoluzione noologica si intende andare a ricercare le ra<strong>di</strong>ci profonde dei<br />
comportamenti antiecologici, che si trovano nel’impianto concettuale della natura<br />
occidentale; Gregory Bateson parte dal presupposto che l’inquinamento materiale ha origine<br />
da un inquinamento mentale ed è per questo che occorre agire sulle prospettive concettuali,<br />
specialmente sulla definizione e idea <strong>di</strong> natura, per mo<strong>di</strong>ficare i comportamenti nei suoi<br />
confronti e del rapporto che l’uomo ha instaurato con essa: agire dunque sulla nostra<br />
noosfera (rinominando l’idea <strong>di</strong> natura) (Bateson, 1990).<br />
26
2.1 Storia e Nascita del Sistema Infea Nazionale<br />
Il sistema nazionale In.F.E.A. ha preso forma in risposta alle spinte<br />
internazionali riguardanti il tema dell’educazione ambientale. Trovo<br />
opportuno illustrare qui <strong>di</strong> seguito le tappe più importanti che hanno<br />
sottolineato la necessità <strong>di</strong> creare un programma nazionale e locale per la<br />
progettazione <strong>di</strong> interventi educativi e la gestione <strong>di</strong> iniziative legate alla<br />
sostenibilità, svolte da <strong>di</strong>versi attori.<br />
In Italia si inizia a parlare <strong>di</strong> educazione ambientale a livello istituzionale nel<br />
1988 quando viene firmato un primo accordo <strong>di</strong> programma tra il Ministro<br />
dell’<strong>Ambiente</strong> ed il Ministero della Pubblica Istruzione, finalizzato ad<br />
introdurre alcune iniziative <strong>di</strong> educazione ambientale nelle scuole italiane.<br />
La collaborazione tra i due Ministeri è nata, probabilmente, in seguito alla<br />
presa <strong>di</strong> coscienza dell’attenzione con<strong>di</strong>visa <strong>di</strong> lavorare sui temi <strong>di</strong> educazione<br />
ambientale, sia delle associazioni ambientalistiche, sia delle istituzioni<br />
scolastiche; questa con<strong>di</strong>visione era emersa da una ricerca svolta<br />
dall’Università <strong>di</strong> Parma, commissionata dal Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, la quale<br />
aveva riportato l’attenzione della scuola, per i problemi ambientali, come un<br />
fenomeno già abbastanza <strong>di</strong>ffuso e consolidato, anche se ancora legato solo<br />
alla trasmissione <strong>di</strong> nozioni riguardanti l’ecologia e temi naturalistici e quin<strong>di</strong><br />
un’Educazione Ambientale ancora in forma embrionale e poco strutturata<br />
(Soprano, 2005).<br />
Nel 1997 viene stilata a Fiuggi la Carta dei principi per l’educazione<br />
ambientale che, attraverso 10 articoli, riporta le linee guida per promuovere<br />
un’educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole. Si<br />
rivolge ai citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> ogni età, alla Pubblica Amministrazione, alle imprese, ai<br />
lavoratori, alle scuole, alle agenzie educative del territorio.<br />
Sancisce il ruolo che l'educazione ambientale ha nel comprendere l'istruzione<br />
formale, la sensibilizzazione e la formazione. L'educazione ambientale si<br />
27
protrae per tutta la durata dell'esistenza, acquisendo una prospettiva educativa<br />
del long life learning, prepara l'in<strong>di</strong>viduo alla vita e coinvolge, <strong>di</strong>rettamente e<br />
continuamente, tutte le generazioni sulla base del principio che ognuna ha<br />
qualcosa da imparare dalle altre.<br />
Riprendendo dall’accordo tra i due Ministeri, gli in<strong>di</strong>rizzi operativi promossi<br />
hanno portato, sotto la spinta della Commissione Nazionale Italiana (CNI) per<br />
l’UNESCO, alla realizzazione del Programma In.F.E.A. (Informazione,<br />
Formazione ed Educazione Ambientale) e alla nascita del Sistema In.F.E.A.<br />
nazionale, una rete <strong>di</strong> persone ed organismi, istituzioni e società civile che, a<br />
vario titolo, si occupavano <strong>di</strong> educazione ambientale sul territorio.<br />
L’obiettivo che ci si prefiggeva (con questo sistema) era quello <strong>di</strong> far penetrare<br />
nel tessuto sociale e istituzionale l’Educazione Ambientale, farla <strong>di</strong>venire<br />
componente organica <strong>di</strong> tutte le politiche pubbliche, quelle formative ed<br />
ambientali innanzitutto; ciò in quanto si riconosceva oramai il suo ruolo <strong>di</strong><br />
strumento <strong>di</strong> cambiamento della società, favorendo l’integrazione delle<br />
politiche, nell’ottica della sostenibilità.<br />
Il sistema In.F.E.A. ha lo scopo <strong>di</strong> promuovere una serie <strong>di</strong> iniziative<br />
coor<strong>di</strong>nate in un progetto unitario; si sviluppa come “raccoglitore” <strong>di</strong> tutte le<br />
esperienze, anche se avvenute in settori <strong>di</strong>versi o da enti <strong>di</strong>versi riguardanti<br />
l’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità; un’altro fine è anche quello <strong>di</strong><br />
creare anche una documentazione ricca riguardante questo tema e far<br />
accrescere la qualità dei <strong>di</strong>versi progetti, potendoli confrontare o consultare in<br />
una raccolta, a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti.<br />
È volto a:<br />
«rafforzare le conoscenze specifiche sulle tematiche<br />
ambientali, a favorire la crescita della sensibilità collettiva<br />
verso i temi della tutela ambientale, a promuovere<br />
cambiamenti comportamentali in<strong>di</strong>rizzati verso il<br />
miglioramento della qualità dell’ambiente e favorire la<br />
28
partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni a tutti i livelli per la<br />
realizzazione <strong>di</strong> uno sviluppo sostenibile»<br />
(Danisi A., 2005: p. 86).<br />
Lo sviluppo <strong>di</strong> questo sistema a livello nazionale si è avviato attraverso i<br />
programmi triennali <strong>di</strong> tutela ambientale (PTTA) 1989/91 e 1994/96, iniziative<br />
del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, con finalità <strong>di</strong> coagulare le <strong>di</strong>fferenti esperienze<br />
maturate sul territorio in tema <strong>di</strong> educazione ambientale, favorendo la<br />
costruzione <strong>di</strong> reti locali caratterizzate da obiettivi e linguaggi comuni.<br />
Il Sistema In.F.E.A. (acronimo <strong>di</strong> Informazione, Formazione, Educazione<br />
Ambientale) a sua volta si è sviluppato sul territorio costruendo alleanze con<br />
Enti, Università, Istituti <strong>di</strong> ricerca, scuole, mondo del volontariato ed imprese.<br />
Questa compartecipazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi soggetti ha consentito all’educazione<br />
ambientale <strong>di</strong> affermarsi nelle politiche <strong>di</strong> governo, a livello regionale e<br />
nazionale.<br />
Ogni <strong>Regione</strong> ha attivato il Sistema In.F.E.A, utilizzando, con i propri tempi,<br />
risorse organizzative e finanziarie. Ognuna ha redatto e attuato propri<br />
Programmi a scadenza triennale che si sono mantenuti ed evoluti<br />
progressivamente in modo coor<strong>di</strong>nato sul territorio, dando continuità e<br />
sistematicità alle iniziative, e coor<strong>di</strong>nando strutture che sul territorio<br />
promuovono l’educazione ambientale (CEA-Centro <strong>di</strong> Educazione<br />
Ambientale, Scuole Laboratorio e altre Strutture).<br />
Nell’aprile 2000, presso la Conferenza Stato-Regioni, è stato costituito<br />
formalmente il Tavolo tecnico INFEA Stato-Regioni che rappresenta uno<br />
strumento idoneo <strong>di</strong> verifica del Sistema Nazionale, quale integrazione dei<br />
sistemi a scala regionale e confronto tra lo Stato e le Regioni, per poter<br />
mantenere sempre uno scambio collaborativo tra le <strong>di</strong>verse realtà ed<br />
esperienze realizzare.<br />
Il Tavolo Tecnico INFEA ha redatto un Documento (“Linee <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo per<br />
una nuova programmazione concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province<br />
29
Autonome <strong>di</strong> Trento e Bolzano in materia In.F.E.A.: verso un sistema<br />
nazionale In.F.E.A come integrazione dei sistemi a scala regionale”)<br />
approvato ufficialmente nel novembre del 2000 che rappresenta ancora oggi lo<br />
strumento <strong>di</strong> riferimento per lo sviluppo del Sistema.<br />
Da qui l’Educazione Ambientale è trattata a livello istituzionale, come una<br />
materia “concorrente”, «le “Linee <strong>di</strong> orientamento”, infatti, stabiliscono che lo<br />
Stato, le Regioni e le Province Autonome concorrono nell’attuazione del<br />
Sistema INFEA sulla base delle proprie competenze e <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong>versi <strong>di</strong><br />
programmazione e attuazione delle politiche, nella convinzione con<strong>di</strong>visa <strong>di</strong><br />
poter raggiungere in questo modo un’efficacia e un’efficienza maggiore delle<br />
politiche stesse» (Soprano, 2005: p.154).<br />
Il percorso istituzionale e politico intrapreso è quello <strong>di</strong> attribuire, da parte dei<br />
Governi Regionali e dello Stato, al Sistema In.F.E.A. un ruolo <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento, <strong>di</strong> promozione e <strong>di</strong> facilitazione.<br />
Il Primo Programma In.F.E.A. risale al 2002-2003 ed ha significato un<br />
passaggio importante sia sotto il profilo metodologico sia <strong>di</strong> attuazione<br />
amministrativa. Tale programmazione si è costruita attraverso una serie <strong>di</strong><br />
incontri istituzionali del Tavolo Tecnico INFEA, che vedeva presenti anche il<br />
Ministero e le Regioni, per poter con<strong>di</strong>videre criteri <strong>di</strong> ripartizione delle<br />
somme messe a <strong>di</strong>sposizione dal Ministero, poter decidere le priorità <strong>di</strong><br />
intervento e infine scegliere le procedure <strong>di</strong> attuazione e monitoraggio<br />
(Soprano, 2005).<br />
Sono stati tre gli argomenti scelti in questa sede sulla base delle priorità<br />
emergenti per l’attuazione del Sistema In.F.E.A.:<br />
realizzare una formazione rivolta ai referenti regionali del Sistema<br />
In.F.E.A. e ai coor<strong>di</strong>natori dei centri territoriali con funzioni <strong>di</strong> nodo<br />
delle reti regionali e della rete nazionale;<br />
30
il progetto interregionale sul sistema <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> qualità da applicare<br />
ai sistemi regionali In.F.E.A.;<br />
la produzione <strong>di</strong> materiali e<strong>di</strong>toriali <strong>di</strong> promozione del Sistema<br />
Nazionale In.F.E.A.<br />
Un contesto ricco e significativo quello del Sistema Nazionale INFEA,<br />
espressione dell’opera congiunta dello Stato e delle Regioni per l’Educazione<br />
Ambientale. L’In.F.E.A. rappresenta, a partire dalla prima metà degli<br />
anni ’90, la scelta <strong>di</strong> costruire un’organizzazione de<strong>di</strong>cata all’Educazione<br />
Ambientale, come “Sistema <strong>di</strong> istituzioni pubbliche”.<br />
Alla sua crescita hanno compartecipato in modo sostanziale <strong>di</strong>versi soggetti,<br />
che hanno riconosciuto nell’Ente Pubblico, il soggetto idoneo a consentire<br />
all’Educazione Ambientale <strong>di</strong> affermarsi quale parte integrante e fondamentale<br />
delle politiche <strong>di</strong> governo, a livello regionale e nazionale.<br />
“Pertanto l’idea fondante dell’In.F.E.A. era, ed è tutt’ora,<br />
<strong>di</strong> far penetrare nel tessuto istituzionale l’EA, quale<br />
strumento <strong>di</strong> cambiamento della società, favorendo<br />
l’integrazione delle politiche, nell’ottica della sostenibilità.<br />
Per raggiungere tale obiettivo, lo Stato e le Regioni hanno<br />
operato affinché si costituissero, a scala regionale, reti <strong>di</strong><br />
strutture, (<strong>di</strong> cui fanno parte i centri regionali <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento, i C.E.A., ecc. ) che con le necessarie<br />
competenze e risorse organizzative possano promuovere<br />
con continuità l'EA per lo sviluppo sostenibile 2 ”.<br />
Volendo dunque sintetizzare il Sistema INFEA nelle sue principali tre<br />
caratteristiche descrittive <strong>di</strong>remmo che:<br />
2 Citazione presa dal documento “Il Sistema Nazionale INFEA ed il Decennio UNESCO dell’Educazione<br />
allo Sviluppo Sostenibile: riflessioni, interazioni e proposte”.<br />
31
il Sistema Nazionale In.F.E.A. è organizzato in reti <strong>di</strong> Centri <strong>di</strong><br />
coor<strong>di</strong>namento regionali, Laboratori <strong>di</strong> Educazione Ambientale<br />
(L.E.A.), Centri <strong>di</strong> Educazione Ambientale (CEA) e Centri <strong>di</strong><br />
esperienza (C.E.).<br />
gli strumenti utilizzati sono quelli della partecipazione, della<br />
con<strong>di</strong>visione, della me<strong>di</strong>azione e della coesione sociale e sono<br />
finalizzati a facilitare lo sviluppo <strong>di</strong> reti territoriali per la sostenibilità.<br />
il Sistema In.F.E.A. nazionale è “costruito” come integrazione delle reti<br />
regionali e richiede che siano messi in campo degli strumenti <strong>di</strong><br />
valutazione da applicare sia ai no<strong>di</strong> fisici del Sistema, sia all’attività<br />
proposta.<br />
Grazie agli sforzi congiunti <strong>di</strong> tante istituzioni e <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi soggetti, lo scenario<br />
che si presenta oggi nel nostro Paese è quello <strong>di</strong> un sistema nazionale <strong>di</strong><br />
educazione ambientale articolato e <strong>di</strong>ffuso sul territorio, in grado <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare<br />
una domanda vasta e <strong>di</strong>fferenziata, proveniente non solo dal mondo della<br />
scuola, ma dalla generalità dei citta<strong>di</strong>ni. Tutto questo può contribuire alla<br />
costruzione <strong>di</strong> una nuova cultura, in grado <strong>di</strong> promuovere e <strong>di</strong>ffondere modelli<br />
<strong>di</strong> consumo e stili <strong>di</strong> vita più attenti all’uso e alla conservazione delle risorse<br />
naturali e, allo stesso tempo, in grado <strong>di</strong> rispettare le legittime aspettative <strong>di</strong><br />
crescita e <strong>di</strong> benessere economico e sociale, vincendo così la sfida dello<br />
sviluppo sostenibile (Soprano, 2005).<br />
2.2 Il Sistema regionale Infea nell’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong><br />
Con il mio lavoro intendo focalizzare la mia analisi sul caso della regione<br />
<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>. In essa si trovano esperienze <strong>di</strong> attività pregresse <strong>di</strong><br />
educazione ambientale sviluppatesi già dagli anni ’80, attivate da <strong>di</strong>versi enti e<br />
associazioni sensibili riguardo tematiche dell’educazione allo sviluppo<br />
32
sostenibile. Volendo valorizzare, stimolare e riqualificare queste, la regione<br />
<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> fu la prima in Italia a promuovere una legge per<br />
favorire lo sviluppo <strong>di</strong> azioni e attività <strong>di</strong> educazione ambientale,<br />
<strong>di</strong>ventando così punto <strong>di</strong> riferimento per tutte le altre regioni d’Italia: la L.R.<br />
15/1996 “Promozione organizzazione e sviluppo delle attività <strong>di</strong><br />
informazione e <strong>di</strong> educazione ambientale”, che tende a voler consolidare e<br />
rendere continuative e non più spora<strong>di</strong>che e prive <strong>di</strong> riconoscimento le<br />
esperienze e attività preesistenti de<strong>di</strong>cate all’EA.<br />
«Il sistema In.F.E.A. regionale sviluppato si compone <strong>di</strong> decine (96) <strong>di</strong> Centri<br />
<strong>di</strong> Educazione Ambientale sul territorio, Scuole Laboratorio, Agenzie<br />
scientifiche e formative a supporto, e rappresenta un originale laboratorio <strong>di</strong><br />
cooperazione tra istituzioni politiche e formative, ricerca e associazionismo»<br />
(DGR N°1217/2008).<br />
Con le programmazioni triennali passate, le azioni realizzate si possono<br />
sud<strong>di</strong>videre in tre tipologie principali:<br />
1. “azioni <strong>di</strong> sistema”, attivate dai servizi centrali a supporto e sviluppo<br />
della rete del sistema regionale INFEA;<br />
2. “azioni per il potenziamento dell’attività dei CEA”, sviluppate<br />
attraverso i Ban<strong>di</strong> regionali annuali a sostegno <strong>di</strong> progetti e iniziative<br />
dei CEA;<br />
3. “azioni per il potenziamento dell’attività delle Scuole Laboratorio <strong>di</strong><br />
EA”, sviluppate in particolare attraverso i Ban<strong>di</strong> regionali annuali a<br />
sostegno <strong>di</strong> progetti e iniziative dei CEA (DGR N°1217/2008).<br />
Negli ultimi anni, l’operatività del Sistema Nazionale INFEA si è<br />
concretizzata tramite una Programmazione congiunta e coor<strong>di</strong>nata. Gli accor<strong>di</strong><br />
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno avviato programmi <strong>di</strong><br />
educazione ambientale. Ogni programmazione è stata strettamente legata al<br />
territorio, si è infatti trattato <strong>di</strong> fare una pianificazione coerente con le proprie<br />
33
esigenze. In molti casi, questi interventi hanno rappresentato la continuazione<br />
<strong>di</strong> una programmazione che, da molti anni, è parte organica delle politiche <strong>di</strong><br />
sostenibilità. In altri casi, invece, la programmazione regionale ha costituito la<br />
spinta decisiva per far transitare l’educazione ambientale da progettazione<br />
occasionale ad un’azione stabile e continuativa delle Amministrazioni.<br />
La legge regionale e la sua attuazione, insieme ai documenti nazionali e<br />
internazionali, ha in<strong>di</strong>rizzato le prime quattro programmazioni triennali<br />
regionali dell’informazione ed educazione ambientale, (1999-2001, 2002-<br />
2004, 2005-2007) realizzate nell’arco dei <strong>di</strong>eci anni dal 1996 al 2006, le quali<br />
hanno finanziato e realizzato oltre 500 progetti con i CEA e Scuole e oltre 100<br />
azioni per lo sviluppo del sistema In.F.E.A. (Report 1, 2009).<br />
Per conoscere meglio le attività che sono state svolte in quest’arco <strong>di</strong> tempo, e<br />
sapere in quale contesto si ritrova l’azione educativa <strong>di</strong> oggi, qui <strong>di</strong> seguito mi<br />
sembra importante riportare in sintesi l’evolversi delle programmazioni<br />
regionali realizzate con i piani triennali.<br />
Le prime a svilupparsi sono state promosse e finanziate con risorse statali<br />
attraverso il Programma triennale <strong>di</strong> tutela ambientale (PTTA) 1994-1996,<br />
avviato dal Ministero dell’ambiente, con cui si è cercato <strong>di</strong> accompagnare la<br />
nascita e il consolidamento <strong>di</strong> vari CEA e sono stati prodotti <strong>di</strong>versi materiali<br />
<strong>di</strong>dattici <strong>di</strong> qualità per sensibilizzare alle tematiche ambientali e sociali.; ha<br />
avviato dunque la costituzione <strong>di</strong> una struttura regionale <strong>di</strong> riferimento.<br />
Si è cominciata a sviluppare in modo sistemico e continuativo la<br />
programmazione regionale e sono state avviate importanti azioni <strong>di</strong> sistema,<br />
con il “Programma regionale INFEA 1999-01” che ha previsto lo sviluppo<br />
del Master post-<strong>laurea</strong> in esperto in Educazione Ambientale, il legame tra<br />
A21L e INFEA, sono stati dati contributi attraverso ban<strong>di</strong> annuali, a scuole e<br />
CEA, finalizzati e orientati da in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> qualità.<br />
Il “Programma regionale INFEA 2002-04” ha previsto il consolidamento del<br />
processo avviato con quello precedente, questo anche grazie all’aiuto dato dal<br />
34
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, consentendo <strong>di</strong> sostenere <strong>di</strong>eci progetti<br />
particolarmente complessi e significativi: si è potuto infine realizzare il<br />
“Progetto interregionale sul sistema degli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> qualità da applicare ai<br />
sistemi regionali INFEA” con il quali si è arrivati a un accre<strong>di</strong>tamento dei<br />
CEA e ad attivare un sistema <strong>di</strong> monitoraggio e documentazione delle azioni<br />
intraprese.<br />
Con il “Programma regionale INFEA 2005-07” si sono incentrate le<br />
in<strong>di</strong>cazioni regionali nel portare CEA e scuole a lavorare in partnership per<br />
affinità tematiche, metodologiche o territoriali.<br />
Nello stesso periodo è stata avviata la ricerca Educazione Ambientale 10+,<br />
progettata e in<strong>di</strong>rizzata da un comitato scientifico con esperti del mondo<br />
universitario e delle istituzioni scolastiche, e coor<strong>di</strong>nata dal Servizio<br />
Comunicazione ed Educazione alla Sostenibilità. Questa ha permesso <strong>di</strong> fare<br />
una valutazione approfon<strong>di</strong>ta sui <strong>di</strong>eci anni d’attività, per verificare lo stato del<br />
sistema regionale riguardante le tematiche ambientali, potendo dunque<br />
ricavare dei suggerimenti su possibili azioni necessarie da svolgere in futuro<br />
(Report 1, 2009).<br />
2.3 Programma regionale Infea 2008-10<br />
Le programmazioni citate precedentemente hanno consentito <strong>di</strong> sviluppare il<br />
“Sistema regionale INFEA”, composto da CEA, Scuole Laboratorio, Agenzie<br />
scientifiche e formative <strong>di</strong> supporto che rappresenta un originale laboratorio <strong>di</strong><br />
cooperazione tra istituzioni politiche e formative, ricerca e associazionismo<br />
(DGR N°1217/2008).<br />
Importante è considerare che lungo questo percorso è mutato il contesto <strong>di</strong><br />
riferimento per le problematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile,<br />
rispetto ai programmi triennali precedenti.<br />
Si possono sintetizzare quattro punti decisivi che hanno influenzato questo<br />
cambiamento:<br />
35
la conferenza <strong>di</strong> Johannesburg 2002, nella cui sede è stato riportato il<br />
bilancio dell’attuazione della strategia <strong>di</strong> Agenda 21, attivata <strong>di</strong>eci anni<br />
prima a Rio De Janeiro, che ha fatto emergere la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> una<br />
concreta attuazione delle politiche <strong>di</strong> sostenibilità ed è stato dunque<br />
riba<strong>di</strong>ta l’importanza del supporto culturale ed educativo a tali<br />
strategie. È così che successivamente, dalle Nazioni Unite, è stato<br />
proclamato il Decennio dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile<br />
(DESS) 2005-2014.<br />
la «Strategia UNECE (United Nation Economic Commission for<br />
Europe) per l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), che si pone<br />
come quadro <strong>di</strong> riferimento e <strong>di</strong> orientamento per le politiche dei vari<br />
paesi aderenti, volto a supportare l’introduzione del concetto <strong>di</strong><br />
sviluppo sostenibile nei vari sistemi educativi (formale, informale e non<br />
formale) e a sviluppare metodologie, strumenti e competenze<br />
adeguate» (DGR N°1217/2008). Nel nostro paese tale azione viene<br />
promossa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.<br />
costituzione del Comitato Nazionale Italiano per il Decennio<br />
dell’educazione allo sviluppo sostenibile (DESS UNESCO Italia), il<br />
quale sviluppa un programma annuale <strong>di</strong> attività e collabora con le<br />
Regioni e i Sistemi regionali INFEA, riconosciuti come interlocutori<br />
per l’attuazione del DESS sui rispettivi territori.<br />
la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, che il 15 marzo<br />
2007, ha approvato il documento politico “Orientamenti e obiettivi per<br />
il nuovo quadro programmatico per l’educazione all’ambiente e allo<br />
sviluppo sostenibile” che riafferma la vali<strong>di</strong>tà del Sistema In.F.E.A.<br />
nazionale come integrazione <strong>di</strong> Sistemi a scala regionale, impegna «a<br />
sviluppare la propria azione congiunta per la crescita <strong>di</strong> una cultura<br />
della sostenibilità da attuarsi anche favorendo una forte integrazione<br />
delle politiche <strong>di</strong> settore, necessaria per rendere i processi della<br />
36
formazione, dell’educazione e della sensibilizzazione per lo sviluppo<br />
sostenibile organici alle politiche del territorio» (DGR N°1217/2008).<br />
In seguito a queste tappe importanti, dalla Conferenza Stato-Regioni, il 1°<br />
agosto 2007, è stato redatto e approvato il “Nuovo Quadro Programmatico<br />
Stato Regioni e Province autonome per l’educazione all’ambiente e alla<br />
sostenibilità”, che rappresenta lo strumento principale per attuare ed<br />
in<strong>di</strong>rizzare le attività delle Amministrazioni centrali e regionali.<br />
Per la presentazione del mio lavoro è opportuno prendere in considerazione <strong>di</strong><br />
questo “Quadro Programmatico”, che prevede <strong>di</strong>versi livelli d’azione, servizi e<br />
attività, quelle legate alle azioni <strong>di</strong> livello regionale, che sono articolate in:<br />
sviluppo dei Sistemi Regionali In.F.E.A. e dei Centri <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento<br />
regionale, cercando <strong>di</strong> integrare strutture e competenze;<br />
sostegno ai CEA, alle Scuole, alle Strutture operanti nei sistemi <strong>di</strong> EA<br />
nell’ambito dell’educazione formale e non formale;<br />
formazione mirata per gli operatori dei CEA (come il caso del Master <strong>di</strong><br />
esperto in Educazione Ambientale dell’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>);<br />
educazione ambientale per gli adulti e promozione <strong>di</strong> modelli <strong>di</strong><br />
produzione e consumi sostenibili; citta<strong>di</strong>nanza attiva: elaborazione <strong>di</strong><br />
programmi e progetti che promuovono processi partecipativi <strong>di</strong><br />
trasformazione territoriale sostenibile (DGR N°1217/2008).<br />
Prendendo in considerazione nello specifico il caso delle Scuole laboratorio, è<br />
emerso che, grazie ai programmi precedenti, si sono delineate nuove<br />
caratteristiche, attitu<strong>di</strong>ni e profili <strong>di</strong> «una scuola che si relaziona in modo<br />
nuovo con il proprio territorio, facendosi carico con gli altri attori sociali dei<br />
suoi problemi e che nello stesso tempo è in grado <strong>di</strong> accogliere le competenze<br />
e le risorse esterne che possono utilmente integrarsi con il suo piano<br />
dell’offerta formativa» (DGR N°1217/2008).<br />
37
Grazie alla ricerca “Educazione Ambientale 10+” è emerso il bisogno <strong>di</strong><br />
lavorare sulla sostenibilità curricolare poiché la scuola ha la possibilità <strong>di</strong><br />
intervenire <strong>di</strong>rettamente nei processi <strong>di</strong> sviluppo territoriale e non può dunque<br />
più essere lasciata all’iniziativa <strong>di</strong> un singolo docente. La ricerca citata è<br />
considerata un ricco lavoro per l’aver verificato quale sia il posto che occupa<br />
l’educazione ambientale nell’impianto formativo intenzionale <strong>di</strong> un<br />
determinato territorio e attraverso quali modelli <strong>di</strong>dattici esso viene<br />
realizzato.<br />
Questo nuovo Programma regionale INFEA per il triennio 2008-2010<br />
«assume gli obiettivi generali definiti dai documenti internazionali e nazionali<br />
de<strong>di</strong>cati all’educazione alla sostenibilità,» «ha come sfondo la consapevolezza<br />
che il problema del surriscaldamento del pianeta rappresenta la principale<br />
emergenza attuale e dei prossimi decenni e che affrontare tali problematiche<br />
richiede un impegno coerente <strong>di</strong> lunga durata da parte <strong>di</strong> tutti gli attori sociali,<br />
economici e istituzionali» (Tamburini P., 2009: p. 28).<br />
Gli obiettivi operativi del presente Programma toccano un totale <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci aree<br />
principali <strong>di</strong> azione:<br />
Evoluzione del Sistema Regionale In.F.E.A.<br />
Documentazione e monitoraggio permanente del sistema <strong>di</strong> Educazione<br />
ambientale<br />
Sviluppo <strong>di</strong> forme permanenti <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tra le educazioni alla<br />
sostenibilità <strong>di</strong> tutti i settori regionali<br />
Aggiornamento e formazione permanente <strong>di</strong> operatori<br />
Potenziamento attività dei Centri <strong>di</strong> Educazione Ambientale<br />
Potenziamento attività Scuole Laboratorio <strong>di</strong> EA<br />
Partnership, progetti e reti nazionali ed europee<br />
Informazione e Comunicazione<br />
38
Produzione e <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong>dattici per insegnanti ed<br />
educatori<br />
Promozione <strong>di</strong> una cultura della sostenibilità<br />
2.4 Evoluzione legislativa recente<br />
Si è descritto in precedenza della L.R. 15/1996 “Promozione, organizzazione<br />
e sviluppo delle attività <strong>di</strong> informazione e <strong>di</strong> educazione ambientale”, della<br />
rilevanza che ha avuto sia a livello regionale sia nazionale, essendo stata il<br />
primo caso in Italia <strong>di</strong> una legge declinata all’evoluzione e consolidamento <strong>di</strong><br />
attività sviluppate per promuovere lo sviluppo <strong>di</strong> comportamenti nei confronti<br />
dell’ambiente.<br />
Dalla sua emanazione, però, è mutato il contesto <strong>di</strong> riferimento delle<br />
problematiche dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, e vi è stata anche<br />
un’evoluzione delle strategie informative ed educative, che hanno reso<br />
opportuno un adeguamento <strong>di</strong> questa.<br />
Nel <strong>di</strong>cembre 2009 è stato infatti approvato, dall’Assemblea legislativa<br />
dell’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>, il progetto <strong>di</strong> legge “Promozione, organizzazione e<br />
sviluppo delle attività d’informazione ed educazione alla sostenibilità”, L.R.<br />
27/2009, un nuovo strumento culturale, organizzativo e operativo per fare<br />
crescere la cultura e la pratica della sostenibilità che aggiorna, integra e<br />
sviluppa, in un quadro più ampio, gli obiettivi e le funzioni <strong>di</strong> quella<br />
precedente.<br />
Questa nuova legge testimonia la volontà <strong>di</strong> procedere nel tentativo <strong>di</strong><br />
giungere nel concreto, grazie appunto al cambiamento <strong>di</strong> una normativa,<br />
da un’educazione ambientale ad una più globale e sistemica educazione<br />
alla sostenibilità; <strong>di</strong>minuire dunque la confusione ancora esistente<br />
riguardo la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> approcci <strong>di</strong> questi due tipi <strong>di</strong> educazione.<br />
39
Con la L.R. 15/1996 si è avviato un processo importante che ha portato allo<br />
sviluppo <strong>di</strong> conoscenze ambientali, grazie a tutte quelle attività sviluppate atte<br />
a promuovere comportamenti in<strong>di</strong>viduali e sociali compatibili tra gli esseri<br />
viventi ed il loro habitat, attività sia <strong>di</strong> educazione che <strong>di</strong> informazione<br />
ambientale.<br />
Nel contesto attuale però si è compresa la necessità <strong>di</strong> ampliare i concetti e i<br />
temi esclusivamente <strong>di</strong> carattere ambientale che trattava questa prima legge,<br />
inglobandola in una nuova, più adeguata e in grado <strong>di</strong> cogliere quella<br />
complessità <strong>di</strong> elementi, presente nella realtà, che interagendo portano alla sua<br />
mo<strong>di</strong>fica.<br />
La L.R. 27/2009 sull’educazione alla sostenibilità mette in gioco e integra<br />
nuove risorse umane e organizzative, nuovi meto<strong>di</strong> e nuovi luoghi in cui<br />
attivare il cambiamento responsabile e sostenibile.<br />
Promuovere un’educazione alla sostenibilità significa integrare in un <strong>di</strong>segno<br />
comune gli aspetti globali e locali della citta<strong>di</strong>nanza attiva, della pace, della<br />
democrazia, dei <strong>di</strong>ritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della<br />
salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell’ambiente e<br />
della gestione sostenibile delle risorse naturali; intende far crescere<br />
conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità <strong>di</strong> azione idonee a<br />
perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale anche<br />
attraverso strumenti e meto<strong>di</strong> partecipativi, educativi e comunicativi (L.R. 29<br />
<strong>di</strong>cembre 2009, n. 27).<br />
Le finalità e gli obiettivi che il nuovo testo <strong>di</strong> legge persegue sono in sintesi<br />
quattro:<br />
1. assumere le nuove definizioni e l’evoluzione dell’educazione<br />
ambientale a educazione alla sostenibilità sancite da ONU e Unesco;<br />
2. definire una nuova organizzazione del sistema regionale<br />
dell’educazione alla sostenibilità, ampliando i soggetti che vi prendono<br />
parte e precisando l’apporto specifico <strong>di</strong> ciascuno;<br />
40
3. in<strong>di</strong>care le nuove funzioni delle strutture educative sul territorio (i<br />
Centri <strong>di</strong> educazione alla sostenibilità) e il ruolo delle reti <strong>di</strong> scuole per<br />
la sostenibilità, prevedendo nuovi criteri per il riconoscimento e<br />
promuovendo la razionalizzazione della loro presenza sui territori;<br />
4. promuovere ai <strong>di</strong>versi livelli il coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutte le educazioni<br />
(all’ambiente, alla salute, alla corretta alimentazione, alla sicurezza<br />
stradale e mobilità sostenibile, alla partecipazione, etc.), in coerenza<br />
con i principi del Decennio per l’educazione alla sostenibilità<br />
(L.R. 29 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 27).<br />
Il cambiamento legislativo appena descritto è importante da considerare<br />
poiché ha influenzato la realizzazione del Bando In.F.E.A. 2010, con una sua<br />
particolarità sotto tale aspetto, ed i progetti che sono stati presentati in sua<br />
risposta. Questo sarà approfon<strong>di</strong>to nel capitolo che segue, insieme alla<br />
descrizione della mia esperienza <strong>di</strong> ricerca svolta per la realizzazione <strong>di</strong> questa<br />
tesi.<br />
41
3<br />
LETTURA DEI PROGETTI PRESENTATI AL BANDO INFEA<br />
2010<br />
3.1 Bando Infea 2010<br />
Con il Bando INFEA 2010 la <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> intende promuovere<br />
e finanziare la programmazione, progettazione e realizzazione <strong>di</strong> azioni<br />
educative, coerenti con i documenti programmatici internazionali, nazionali e<br />
regionali, in materia <strong>di</strong> ambiente e sostenibilità. Per fare questo verranno<br />
concessi contributi a reti <strong>di</strong> istituti scolastici regionali che proporranno progetti<br />
ed azioni nel campo dell’educazione all’ambiente e alla sostenibilità (DGR<br />
N°683/2010).<br />
Le finalità del bando sono state definite dalla <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong><br />
tenendo presente gli obiettivi:<br />
definiti dal decennio UNESCO 2005/2014 per l’Educazione allo<br />
Sviluppo Sostenibile e le Linee Guida per il programma In.F.E.A.-ESS<br />
nazionale;<br />
in<strong>di</strong>viduati dalla L.R. 27/2009, anche se questa entrerà in vigore solo<br />
nell’anno nuovo 2011 (il seguente bando, infatti, deve ancora attenersi<br />
alla L.R. 15/1996);<br />
quelli che sono stati prefissati nel Programma regionale In.F.E.A.<br />
2008/2010.<br />
Viene chiesto agli Istituti scolastici della regione <strong>di</strong> progettare e realizzare in<br />
rete tra loro “laboratori <strong>di</strong> educazione alla sostenibilità” che in modo<br />
42
continuativo promuovano lo sviluppo <strong>di</strong> conoscenze e azioni concrete per<br />
migliorare l’ambiente, gli stili e la qualità <strong>di</strong> vita; queste attività devono essere<br />
inserite in modo stabile nei Piani dell’Offerta Formativa (POF) delle scuole,<br />
essere in relazione con l’insieme del curricolo e prevedere metodologie <strong>di</strong><br />
ricerca-azione.<br />
Tema a cui devono attenersi i progetti è la “Comunità scolastica e<br />
sostenibilità dello spazio educativo”, questo «dovrà essere affrontato con<br />
attività che facciano esplicito riferimento ad almeno una delle sue seguenti<br />
articolazioni:<br />
1. Sostenibilità dello spazio interno all’e<strong>di</strong>ficio scolastico: progettazione e<br />
realizzazione <strong>di</strong> azioni volte alla riqualificazione ecologica dell’e<strong>di</strong>ficio<br />
scolastico sia in riferimento al suo funzionamento in chiave <strong>di</strong><br />
risparmio <strong>di</strong> risparmio e uso consapevole delle risorse (tecniche<br />
costruttive e <strong>di</strong> materiali secondo le in<strong>di</strong>cazioni della bio-e<strong>di</strong>lizia,<br />
soluzioni energetiche compatibili con l’ambiente interno ed esterno,<br />
riciclaggio dei rifiuti annullando anche lo spreco “dell’usa e getta”,<br />
utilizzo razionale dell’acqua e suo riciclaggio, consumi e alimentazione<br />
a “chilometro zero”, ecc.); sia inteso come spazio <strong>di</strong> vita dove<br />
quoti<strong>di</strong>anamente si incontrano tra loro alunni, docenti, personale non<br />
docente, genitori (aula, mensa, corridoi, laboratori, palestra, ecc.<br />
pensando anche alla <strong>di</strong>sposizione degli arre<strong>di</strong>, ai colori, ai suoni, ai<br />
materiali, ecc. per rendere gli spazi della scuola accoglienti ed<br />
esteticamente piacevoli);<br />
2. Sostenibilità dello spazio relazionale nella comunità scolastica: azioni<br />
volte a ridefinire la scuola, ambiente formativo istituzionale, come un<br />
sistema complesso, costituito da relazioni tra soggetti e soggetti,<br />
soggetti e oggetti, oggetti e oggetti; relazioni che costituiscono il<br />
tessuto vitale <strong>di</strong> ogni comunità scolastica inserita in una più ampia<br />
comunità locale (gestione delle relazioni professionali e personali e<br />
43
personali, qualificazione e gestione dei tempi educativi, elaborazione <strong>di</strong><br />
strategie auto-organizzative secondo modalità <strong>di</strong> connessione,<br />
integrazione e partecipazione ecc., in una visione <strong>di</strong> scuola come<br />
comunità <strong>di</strong> persone in grado <strong>di</strong> assumere<br />
/elaborare/ampliare/mo<strong>di</strong>ficare un’identità con<strong>di</strong>visa in termini <strong>di</strong><br />
visioni, valori, culture ed esperienze <strong>di</strong> riferimento).<br />
3. Sostenibilità dello spazio esterno all’e<strong>di</strong>ficio scolastico: progettazione e<br />
realizzazione <strong>di</strong> azioni volte alla riqualificazione del parco, del giar<strong>di</strong>no<br />
o del cortile scolastico e alla sua gestione;<br />
4. Sostenibilità dello spazio città-scuola: pensare e costruire nuovi mo<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> interpretare e vivere gli spazi collettivi che riescano a sod<strong>di</strong>sfare le<br />
esigenze <strong>di</strong> spostamento e <strong>di</strong> vivibilità <strong>di</strong> bambini/e e ragazzi/e, in<br />
rapporto con i <strong>di</strong>versi attori sociali del territorio (percorsi casa-scuola,<br />
trasposto collettivo, mobilità sostenibile, vivibilità dei luoghi<br />
d’incontro vicino alla scuola come giar<strong>di</strong>netti, piazze, strade, ecc.)»<br />
(DGR N°683/2010).<br />
Si può supporre che la scelta, del tema, sia stata guidata anche dall’analisi <strong>di</strong><br />
contesto sviluppata dal servizio regionale In.F.E.A. negli anni precedenti.<br />
Come riporta, infatti, il testo regionale de<strong>di</strong>cato alla “Ricerca: Educazione<br />
ambientale 10+” i temi legati alla qualità della vita dei bambini e dei ragazzi,<br />
in ambito scolastico ma anche al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> esso, sono stati in aumento nei<br />
progetti realizzati negli ultimi anni; molti <strong>di</strong> questi erano stati incentrati sulle<br />
riqualificazioni delle scuole come ambienti <strong>di</strong> vita (Report 1, 2009).<br />
Nel bando sono presenti anche i termini d’ammissione a cui devono<br />
rispondere i progetti; questi richiedono specifici elementi che devono essere<br />
previsti e che vanno esplicitati nella presentazione della domanda, quali:<br />
44
un programma <strong>di</strong> lavoro integrato nel quale siano esplicitate le modalità<br />
<strong>di</strong> realizzazione e l’apporto <strong>di</strong> ciascun Istituto / Scuola e dei Partner del<br />
territorio coinvolti;<br />
l’inserimento nel Curricolo dell’Istituto Scolastico della/e azione/i<br />
previste nel progetto;<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> metodologie <strong>di</strong> partecipazione, sperimentazione e<br />
coinvolgimento <strong>di</strong>retto dei bambini e delle bambine nella realizzazione<br />
del progetto;<br />
le modalità per rendere l’azione continuativa nel tempo;<br />
gli in<strong>di</strong>catori e le modalità <strong>di</strong> autovalutazione dei risultati previsti e <strong>di</strong><br />
quelli raggiunti;<br />
le modalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione dei risultati in modo da renderli <strong>di</strong>sponibili.<br />
I progetti che otterranno il finanziamento dovranno avviarsi con l’anno<br />
scolastico 2010/2011 e dovranno terminare entro il 31 <strong>di</strong>cembre 2011. Entro<br />
novanta giorni dal termine le scuole saranno tenute a presentare la<br />
documentazione dei risultati.<br />
A livello legislativo, cioè riguardo a quale legge fa riferimento, il seguente<br />
bando ha una sua particolarità: esso rientra nella Programmazione triennale<br />
2008/2010, che ha preso forma in vigore alla L.R. 15/1996, rispettandola con<br />
le sue linee guida, ma riprende anche degli obiettivi e degli elementi nuovi che<br />
sono inseriti nella L.R. 27/2009, che guiderà la futura Programmazione<br />
triennale nel prossimo anno. Si potrebbe quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>re che il Bando 2010<br />
rispecchia, legislalmente, un anno <strong>di</strong> transizione tra la L.R. 15/1996 e quella<br />
27/2009. L’ultima legge approvata dalla regione ingloba, come si è spiegato<br />
nel capitolo precedente, una parte <strong>di</strong> quella del ’96, adattandola con la nuova<br />
concezione <strong>di</strong> educazione ambientale inserita nell’educazione allo sviluppo<br />
sostenibile.<br />
45
Il mio interesse verso i progetti presentati al Bando Infea 2010 si è sviluppato<br />
partendo dalla mia curiosità <strong>di</strong> comprendere come venivano realizzate nel<br />
concreto le azioni educative legate all’educazione ambientale ed allo sviluppo<br />
sostenibile. Oltre a questo volevo vedere come le istituzioni scolastiche si<br />
approcciano oggi, dopo ormai vent’anni che si parla <strong>di</strong> sviluppo sostenibile,<br />
all’educazione alla sostenibilità e come rispondono al nuovo ruolo che è stato<br />
attribuito all’educazione, dopo il Summit <strong>di</strong> Johannesburg soprattutto, in<br />
quanto <strong>di</strong>vulgatrice <strong>di</strong> cultura e <strong>di</strong> comportamenti e come essenziale<br />
collaboratrice per portare ad una vera coevoluzione tra uomo e natura.<br />
Queste istituzioni hanno compreso il loro valore e l’enormità del contributo<br />
che possono apportare al cambiamento dei comportamenti in una società? Si<br />
sono responsabilizzati in questo senso e si stanno muovendo per rispondere a<br />
questo importante ruolo? Ho voluto dunque cominciare a darmi delle risposte<br />
a queste domande partendo dalle possibilità che avevo, prendendo in<br />
considerazione il mio territorio: la <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>.<br />
3.2 L’ambiente e l’educazione alla sostenibilità nelle<br />
istituzioni scolastiche regionali<br />
La tematica che affronta questa tesi è legata alla nuova concezione <strong>di</strong> sviluppo<br />
sostenibile che, come si è precedentemente illustrato, si sta cercando <strong>di</strong> portare<br />
avanti a livello internazionale.<br />
In quanto Operatrice culturale, rivolto a beni culturali ed educazione<br />
ambientale, ho approfon<strong>di</strong>to il <strong>di</strong>scorso cercando <strong>di</strong> toccare i punti più<br />
significativi che sono emersi, nel corso degli anni fino ad oggi, sull’idea <strong>di</strong><br />
educazione e sul nuovo ruolo attribuitogli, specialmente quello<br />
dell’educazione ambientale come strumento principale per la formazione <strong>di</strong><br />
una nuova società sostenibile.<br />
46
Occorre dunque considerare anche le nuove responsabilità delle Istituzioni<br />
scolastiche, le rivisitazioni necessarie da realizzare al loro interno, al fine <strong>di</strong><br />
creare quel contesto formativo idoneo per lo sviluppo <strong>di</strong> una citta<strong>di</strong>nanza<br />
attiva, consapevole delle implicazioni ambientali che ci sono con gli stili <strong>di</strong><br />
vita attuali della nostra società e che vanno quin<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficati con l’assunzione<br />
<strong>di</strong> comportamenti sostenibili e buone pratiche.<br />
«L’educazione ambientale non si insegna, nel senso che<br />
non può essere semplicisticamente riportata allo stu<strong>di</strong>o<br />
ecologico degli elementi e dei meccanismi che<br />
caratterizzano l’ambiente. Essa rappresenta una<br />
<strong>di</strong>mensione educativa molto più coinvolgente, che mette tra<br />
l’altro in <strong>di</strong>scussione i docenti come “modelli” <strong>di</strong><br />
riferimento e la struttura scolastica come “contenitore” <strong>di</strong><br />
processi, interazioni e relazioni fondamentali»<br />
«L’ambiente scuola rappresenta, infatti, uno spazio e un<br />
tempo dove i ragazzi passano una buona parte della loro<br />
vita ed in cui sono impegnati sia emotivamente che<br />
culturalmente. Per questo riteniamo limitati quegli<br />
approcci all’educazione ambientale che si esauriscono in<br />
esplorazioni soltanto esterne all’ambiente scolastico»<br />
(Bertacci, 2005: pag.62).<br />
Ho voluto, per questo, vedere come si stanno mo<strong>di</strong>ficando le scuole, principali<br />
luoghi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> conoscenza in cui si incontrano oltre alle nuove<br />
generazioni anche famiglie, insegnanti, operatori educativi e personale; scuole<br />
dunque che oramai non possono più essere chiuse ma aperte e in interazione<br />
con l’intera realtà territoriale, e riconoscere e sviluppare, quin<strong>di</strong>, la loro<br />
<strong>di</strong>mensione comunitaria.<br />
47
Le domande principali che hanno guidato la mia ricerca sono state <strong>di</strong>verse:<br />
-quale idea <strong>di</strong> educazione alla sostenibilità è presente come guida alla<br />
realizzazione <strong>di</strong> progetti educativi all’interno delle scuole?<br />
-come si sta portando avanti il progetto internazionale dello sviluppo <strong>di</strong> nuovi<br />
comportamenti e valori ambientali/sostenibili a livello locale?<br />
-quali tematiche vengono affrontate dalle scuole per educare alla<br />
sostenibilità?<br />
-Vi è una prevalenza <strong>di</strong> informazione o <strong>di</strong> educazione ambientale?<br />
Per rispondere a queste mie domande ho pensato fosse utile analizzare i<br />
progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche regionali in risposta al Bando<br />
In.F.E.A. 2010, sviluppato intorno al tema “Comunità scolastica e<br />
sostenibilità dello spazio educativo”.<br />
Il materiale mi è stato fornito dal Servizio Comunicazione ed educazione alla<br />
sostenibilità della <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> presso la cui sede mi sono recata<br />
per un periodo all’incirca <strong>di</strong> tre mesi, per poter avere accesso alla<br />
consultazione <strong>di</strong> tutti i progetti presentati al Bando.<br />
Ho ritenuto utile cercare <strong>di</strong> rintracciare, durante una prima lettura dei progetti,<br />
quegli elementi in<strong>di</strong>cativi ai fini <strong>di</strong> ottenere una visione del contesto generale;<br />
sono stati dunque delineati criteri, che hanno in<strong>di</strong>rizzato il percorso iniziale,<br />
tra cui anche la scelta dell’oggetto specifico su cui concentrare il percorso<br />
d’analisi; questo sarà approfon<strong>di</strong>to nella descrizione della prima fase <strong>di</strong> lavoro<br />
nel prossimo paragrafo. Per rendere il materiale più leggibile e comparabile ho<br />
deciso <strong>di</strong> articolare i contenuti all’interno <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse tabelle.<br />
La prima <strong>di</strong>fficoltà, che ho riscontrato nel mio percorso, infatti, si è verificata<br />
quando, una volta finito <strong>di</strong> compilare la prima tabella, è emersa la criticità <strong>di</strong><br />
alcuni elementi raccolti in maniera poco idonea per poter realizzare<br />
effettivamente una vera analisi, come per esempio l’elemento della tematica<br />
prevalente; il mio errore era stato quello <strong>di</strong> non utilizzare le stesse parole<br />
48
chiave in ogni progetto per poter poi rintracciare le effettive somiglianze,<br />
criticità o risorse, ma <strong>di</strong> raccogliere i dati più in maniera descrittiva piuttosto<br />
che definita e strutturata. Questo ha portato alla rivalutazione in itinere degli<br />
strumenti <strong>di</strong> lavoro e delle modalità <strong>di</strong> raccolta dei dati. Ho cercato <strong>di</strong><br />
delineare nello specifico le caratteristiche principali su cui portare avanti la<br />
ricerca, creando dunque nuovi strumenti più idonei per estrapolare dalla lettura<br />
i dati significativi per il lavoro definitivo.<br />
Ho riportato poi i risultati ottenuti, <strong>di</strong> modo che la loro argomentazione<br />
potesse fornire spunti utili per una riflessione sull’esistenza <strong>di</strong> una visione<br />
sistemica e ricercata nel contesto scolastico che evidenzi la consapevolezza<br />
della nuova responsabilità educativa delle istituzioni e che sia volta allo<br />
sviluppo concreto <strong>di</strong> una nuova mentalità. Questa può portare a mo<strong>di</strong>ficare gli<br />
stili <strong>di</strong> vita in un’ottica ecosostenibile; formare ed educare una società, che<br />
abbia alla base quel sentimento <strong>di</strong> responsabilità in<strong>di</strong>viduale sui processi, reali,<br />
che esistono a livello globale e che cominciano da un semplice gesto<br />
quoti<strong>di</strong>ano.<br />
Volevo vedere se all’interno delle istituzioni scolastiche, in quanto principali<br />
agenti e promotrici <strong>di</strong> cultura, esiste e si è ormai affermata una consapevolezza<br />
concreta del loro ruolo importante per poter contribuire al raggiungimento<br />
degli obiettivi, esplicitati nel piano strategico <strong>di</strong> Agenda 21 a livello<br />
internazionale; se le proposte educative <strong>di</strong> queste hanno alla base la volontà <strong>di</strong><br />
portare un cambiamento significativo all’interno della propria istituzione e del<br />
territorio circostante, <strong>di</strong> riflettersi e allargarsi verso la citta<strong>di</strong>nanza, non solo<br />
accogliendo l’aiuto <strong>di</strong> competenze esterne, come Enti locali e CEA, ma<br />
portando nella realtà esterna della scuola l’attività legata alla sostenibilità,<br />
considerando in un’ottica sistemica non solo l’educando, in quanto ragazzo o<br />
bambino, ma coinvolgendo nell’azione anche la comunità stessa e dunque i<br />
soggetti appartenenti all’ambiente <strong>di</strong> vita. Far partire dunque quel processo <strong>di</strong><br />
cambiamento sull’intera realtà territoriale, e non mantenere come obiettivo<br />
49
esclusivo quello <strong>di</strong> formare ed educare solamente gli in<strong>di</strong>vidui appartenenti al<br />
mondo della scuola, poiché questi vengono formati non solo da essa, ma anche<br />
dalla famiglia e dalla comunità abitante. Analizzando questo si comincerebbe<br />
a riflettere su pratiche concrete e ottimizzate per riuscire a coinvolgere gli<br />
adulti, quali sono quelle possibili, quali le migliori e quali quelle non ancora<br />
provate. È per questi motivi che ritengo importante dare uno sguardo<br />
all’interno delle proposte che provengono dalla realtà istituzionale e fare un<br />
tentativo <strong>di</strong> provare a cogliere quale idea effettivamente sta alla base delle loro<br />
azioni.<br />
Si può dunque proporre una descrizione del lavoro realizzato <strong>di</strong>visa per tre fasi<br />
principali.<br />
Prima Fase<br />
3.3 Le fasi del mio lavoro<br />
Come oggetto specifico su cui concentrare il mio stu<strong>di</strong>o sono stati scelti i<br />
se<strong>di</strong>ci progetti risultati vincitori del Bando Infea 2010. Inizialmente si era<br />
pensato <strong>di</strong> prendere sotto esame tutti quelli che erano stati presentati, sia<br />
vincitori che non, per poter cogliere l’idea generale emergente nelle scuole<br />
riguardo l’educazione alla sostenibilità, ma essendo un totale <strong>di</strong> sessantacinque<br />
progetti per ragioni <strong>di</strong> tempo e per poter effettuare una migliore analisi si è<br />
pensato ad una scrematura, dunque <strong>di</strong> tener in considerazione solamente quelli<br />
che effettivamente sarebbero stati realizzati dalle scuole, nel corso dell’anno<br />
scolastico 2010/2011, grazie ai finanziamenti ottenuti. Inoltre, focalizzarsi sui<br />
progetti vincitori ha permesso anche <strong>di</strong> riflettere sull’idea <strong>di</strong> sostenibilità<br />
promossa dalla <strong>Regione</strong> stessa, <strong>di</strong> quello che essa sta cercando <strong>di</strong> sviluppare<br />
sul proprio territorio, attraverso le <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> sostegno sia a enti locali<br />
come i Cea, sia alle istituzioni scolastiche che si stanno muovendo verso quel<br />
50
cambiamento al loro interno in<strong>di</strong>spensabile per poter contribuire allo sviluppo<br />
<strong>di</strong> una società consapevole e responsabile.<br />
Durante una prima lettura ho cercato <strong>di</strong> interpretare la molteplicità <strong>di</strong> dati<br />
presenti nel materiale a <strong>di</strong>sposizione.<br />
Sono stati raccolti ed inseriti all’interno <strong>di</strong> una griglia i seguenti elementi:<br />
Numero <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> ogni singolo progetto, utilizzato dall’INFEA<br />
per poter ottenere una sorta <strong>di</strong> catalogazione e rintracciabilità;<br />
Nome del progetto;<br />
Città degli Istituti scolastici coinvolti in partnership;<br />
Numero degli Istituti che lavoravano in rete, per poter cogliere<br />
l’apertura verificatasi nel contesto scolastico, parlando in termini <strong>di</strong><br />
collaborazioni nate tra scuole aventi gli stessi fini educativi;<br />
Età dei soggetti coinvolti, dato importante per poter cogliere<br />
nell’imme<strong>di</strong>ato gli interlocutori principali a cui si riferisce il progetto;<br />
Enti collaboratori esterni, questo dato si riferisce sempre alla volontà <strong>di</strong><br />
voler cogliere l’apertura delle scuole sul territorio tramite la<br />
collaborazioni con agenzie esterne, tra cui quelle ricche <strong>di</strong> esperienze<br />
sull’educazione informale (extrascolastica) legata alla tematica<br />
ambientale, e per poter arricchire le attività previste dal progetto <strong>di</strong><br />
competenze multiple che collaborano allo stesso fine;<br />
Tematica;<br />
Metodologia;<br />
Obiettivi.<br />
51
N°<br />
prog<br />
Nome<br />
progett<br />
o<br />
Città<br />
Istituti<br />
in rete<br />
età soggetti<br />
coinvolti<br />
Enti<br />
collaboratori<br />
esterni<br />
Tematica Metodologia obiettivi<br />
La raccolta, in sintesi, <strong>di</strong> ognuno <strong>di</strong> questi dati, mi ha permesso <strong>di</strong> ottenere una<br />
prima visione generale <strong>di</strong> ogni progetto: del contesto in cui si situava; gli<br />
obiettivi che si prefiggeva, determinati dall’oggetto/problema/tema intorno a<br />
cui era stato costruito; delle attività che avrebbe sviluppato e soprattutto verso<br />
quali interlocutori.<br />
Questo lavoro mi ha aiutato nel definire le caratteristiche principali su cui<br />
incentrare il mio percorso d’indagine dei progetti, in quanto mi ha permesso <strong>di</strong><br />
ottenere una visione allargata dei contenuti prevalenti, che potevano essere<br />
utili ai fini <strong>di</strong> comprendere determinati aspetti su cui la riflessione, sulla<br />
progettazione <strong>di</strong> un intervento educativo rivolto alla formazione <strong>di</strong> una società<br />
sostenibile, si sta <strong>di</strong>battendo a livello pedagogico.<br />
Un altro elemento che inizialmente ho cercato <strong>di</strong> delineare è stata quello <strong>di</strong><br />
vedere, se c’era o meno, un’articolazione, espressa nel Bando In.F.E.A<br />
riportata nella parte iniziale del capitolo. riguardante il tema “Comunità<br />
scolastica e sostenibilità dello spazio educativo”, che predominava sulle<br />
altre e dunque verso cui gli Istituti in rete avevano fatto riferimento con il loro<br />
progetto proposto.<br />
Ho sviluppato, quin<strong>di</strong>, un’altra tabella dove ho potuto segnalare se le attività<br />
erano rivolte alla:<br />
a) sostenibilità dello spazio interno all’e<strong>di</strong>ficio scolastico;<br />
b) sostenibilità dello spazio relazionale nella comunità scolastica;<br />
c) sostenibilità dello spazio esterno all’e<strong>di</strong>ficio scolastico;<br />
52
N°<br />
Prog<br />
d) sostenibilità dello spazio città-scuola<br />
(Bando In.F.E.A., DGR n°683/2010).<br />
Sostenibilità dello<br />
spazio interno<br />
all’e<strong>di</strong>ficio:<br />
riqualif. Ecologia<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio<br />
(risparmio e uso<br />
consapevole delle<br />
risorse come<br />
alimentazione a Km<br />
zero, riciclaggio),<br />
sia in chiave <strong>di</strong><br />
spazio <strong>di</strong> incontro<br />
quoti<strong>di</strong>ano<br />
(<strong>di</strong>sposizione arre<strong>di</strong>,<br />
estetica gradevole<br />
colori).<br />
Sostenibilità dello<br />
spazio relazionale<br />
nella comunità<br />
scolastica: azioni<br />
volte a ridefinire la<br />
scuola come<br />
sistema complesso<br />
costituito da<br />
relazioni, comunità<br />
scolastica inserita<br />
in una comunità<br />
locale (gestione<br />
delle relazioni,<br />
gestione tempi<br />
educativi, strategie<br />
auto-organizzative)<br />
il fare in una<br />
visione <strong>di</strong> scuola<br />
come comunità <strong>di</strong><br />
persone in grado <strong>di</strong><br />
mo<strong>di</strong>ficarsi.<br />
Sostenibilità dello<br />
spazio esterno<br />
all’e<strong>di</strong>ficio<br />
scolastico: azioni<br />
volte alla<br />
riqualificazione del<br />
parco, giar<strong>di</strong>no,<br />
cortile scolastico e<br />
sua gestione.<br />
Sostenibilità dello<br />
spazio città–<br />
scuola: pensare e<br />
costruire nuovi<br />
mo<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
interpretare e<br />
vivere gli spazi<br />
collettivi che<br />
sod<strong>di</strong>sfino le<br />
esigenze <strong>di</strong><br />
spostamento e <strong>di</strong><br />
vivibilità <strong>di</strong> bimbi<br />
e ragazzi in<br />
rapporto con attori<br />
sociali del territorio<br />
(percorsi casa<br />
scuola, trasporto<br />
collettivo, mobilità<br />
sostenibile,<br />
vivibilità dei luoghi<br />
<strong>di</strong> incontro vicino<br />
alla scuola come<br />
piazze, strada..)<br />
È emersa, come scelta prevalente degli istituti, la volontà <strong>di</strong> intervenire<br />
soprattutto sullo spazio relazionale nella comunità scolastica, e <strong>di</strong> proiettare le<br />
attività del progetto verso questo fine. Come si vedrà anche in seguito, si<br />
53
iscontra all’interno delle realtà scolastiche, che hanno presentato i progetti in<br />
esame, il desiderio <strong>di</strong> ripensare all’ambiente ed allo spazio scuola come luogo<br />
<strong>di</strong> relazioni da ridefinire in maniera sistemica e collaborativa. Questo si<br />
tradurrebbe in una volontà <strong>di</strong> riqualificare gli spazi affinché possano essere<br />
utilizzati come luoghi <strong>di</strong> incontro quoti<strong>di</strong>ani all’interno dell’istituto,<br />
<strong>di</strong>ventando cosi ambienti vissuti; da de<strong>di</strong>care del tempo anche a momenti <strong>di</strong><br />
incontro e <strong>di</strong> relazione, ritenuti importanti come il tempo dato<br />
all’insegnamento delle materie curricolari.<br />
Ma questo aspetto verrà approfon<strong>di</strong>to nei paragrafi successivi.<br />
Seconda Fase<br />
Tenendo dunque presente le <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni specifiche espresse nel Bando,<br />
a cui gli istituti hanno dovuto rispondere, e partendo dai <strong>di</strong>versi fattori<br />
chiarificativi raccolti nella prima fase, ho ritenuto significativo rintracciare<br />
quelle caratteristiche potenziali, che dovrebbero essere tenute presenti, per<br />
l’ideazione <strong>di</strong> un progetto legato alla tematica dell’educazione alla<br />
sostenibilità, ed anche per cercare <strong>di</strong> cogliere se effettivamente gli Istituti<br />
scolastici presenti nella realtà regionale si stanno muovendo verso delle<br />
pratiche <strong>di</strong> rinnovamento per la costruzione <strong>di</strong> un “curricolo ecologico”.<br />
Le caratteristiche esaminate, su cui poi poter soffermare le mie riflessioni<br />
conclusive, sono riportate qui <strong>di</strong> seguito:<br />
1. temi a cui sono rivolti i progetti proposti: questo per poter vedere<br />
quali delle possibili tematiche, da affrontare per lo sviluppo <strong>di</strong> una<br />
consapevolezza e <strong>di</strong> un’etica ecologica, predominano o vengono ancora<br />
tralasciati all’interno dei progetti presi sotto esame; inoltre anche per<br />
poter delineare possibili interconnessioni <strong>di</strong> temi e saperi realizzate.<br />
2. coinvolgimento <strong>di</strong> genitori o famiglie nel progetto: volevo vedere<br />
quanti dei se<strong>di</strong>ci progetti vincitori analizzati prevedevano questa<br />
54
azione, in un approccio <strong>di</strong> sistematicità dove si cerca <strong>di</strong> cogliere e<br />
mo<strong>di</strong>ficare al fine educativo anche il contesto dell’educando; nei casi in<br />
cui era previsto, sono state raccolte le modalità effettive del<br />
coinvolgimento (es. se le attività erano per un’informazione ambientale<br />
o per un’educazione ambientale).<br />
3. età dei soggetti coinvolti nelle attività: trattandosi <strong>di</strong> progetti realizzati<br />
in un contesto <strong>di</strong> “scuole in rete”, che spesso prevedeva la<br />
collaborazione <strong>di</strong> Istituti con grado <strong>di</strong>versificato, ho voluto verificare se<br />
le attività inserite come proposta educativa, sono state adattate all’età<br />
<strong>di</strong>fferente dei soggetti coinvolti, dunque delineare criticità possibili<br />
delle azioni previste.<br />
4. quale tipo <strong>di</strong> educazione (predomina): “sul”, “nel” e “per”<br />
l’ambiente: questi dati aiutano nel comprendere che visione può essere<br />
presente e <strong>di</strong>ffusa all’interno delle istituzioni regionali per quanto<br />
riguarda l’educazione ambientale ed alla sostenibilità;<br />
5. coinvolgimento dell’area dell’informazione o dell’educazione<br />
ambientale: in entrambi i casi, a volte anche in concomitanza, ho<br />
rilevato a quali interlocutori era rivolta e con quali azioni veniva<br />
realizzata.<br />
Infine, mi sono soffermata su due punti previsti nel bando, a cui le scuole<br />
dovevano rispondere: il primo riguardava le “modalità e in<strong>di</strong>catori per la<br />
verifica del raggiungimento degli obiettivi e risultati attesi e del processo<br />
<strong>di</strong> collaborazione previsto”, in questo passaggio si potevano provare a<br />
cogliere le effettive finalità del progetto e se queste erano coerenti con tutta la<br />
descrizione delle attività fatta in precedenza; l’altro punto preso in<br />
considerazione è stato quello in cui si descrivevano “modalità e prodotti per<br />
la <strong>di</strong>vulgazione dei risultati” in cui potevano essere verificate le attività <strong>di</strong><br />
informazione ambientale, che in questo caso erano state espressamente<br />
richieste dal Bando INFEA e non erano state lasciate al giu<strong>di</strong>zio delle scuole.<br />
55
Gli strumenti utilizzati per questa fase <strong>di</strong> lavoro sono state delle tabelle,<br />
specifiche per ogni argomento, per poter raccogliere in maniera schematica i<br />
dati, sparsi nel modulo <strong>di</strong> presentazione del progetto; queste possono essere<br />
dunque identificate come i miei strumenti <strong>di</strong> lavoro (ve<strong>di</strong> appen<strong>di</strong>ce).<br />
Tematiche affrontate dai progetti<br />
(Appen<strong>di</strong>ce: Griglia 1)<br />
3.4 Risultati Emersi<br />
Il 50% dei progetti sono stati concentrati sul tema della “qualità ambientale<br />
scolastica”, che riprendeva la riqualificazione dell’e<strong>di</strong>ficio ma anche<br />
un’attenzione particolare sulle relazioni all’interno della comunità educativa;<br />
tale tematica, anche se non sempre in posizione prevalente, è comunque<br />
presente e pensata in quasi tutti i progetti eccetto quattro. Si riscontra dunque<br />
all’interno delle realtà scolastiche prese in considerazione il desiderio <strong>di</strong><br />
ripensare agli spazi come luoghi <strong>di</strong> relazioni e al voler ridefinire anche queste<br />
in un modo nuovo, più sistemico e collaborativo.<br />
Oltre alle tematiche principali su cui sono stati incentrati i progetti, sono<br />
emerse tematiche secondarie, come:<br />
la mobilità sostenibile, presente in un buon 50% dei progetti;<br />
il “verde urbano e giar<strong>di</strong>ni scolastici”, tenuto in considerazione da<br />
do<strong>di</strong>ci progetti su se<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong> cui tre incentrati proprio su questo tema;<br />
“rifiuti, risparmio energetico (comportamenti e consumi sostenibili)”,<br />
presente in egual misura del tema precedente.<br />
Sono presenti, anche se in minoranza, i temi legati: alla bio<strong>di</strong>versità, al<br />
territorio e alla sua storia, “agricoltura, alimentazione e salute”.<br />
56
Quelle che hanno riscontrato una minore attenzione, come tre progetti su<br />
se<strong>di</strong>ci, sono state le tematiche su “letteratura, intercultura, danza, pittura e<br />
ambiente” e “impronta ecologica e in<strong>di</strong>catori ambientali”.<br />
Genitori Coinvolti<br />
(Appen<strong>di</strong>ce: Griglia 2)<br />
Quasi tutti i progetti, un<strong>di</strong>ci su se<strong>di</strong>ci, hanno riflettuto e cercato <strong>di</strong> ricercare un<br />
coinvolgimento verso le famiglie nel progetto. Occorre però sottolineare le<br />
<strong>di</strong>verse modalità che sono state scelte per farlo. In certi casi è stata prevista la<br />
partecipazione <strong>di</strong>retta ad alcune delle attività, oppure una sollecitazione da<br />
parte delle scuole alle famiglie <strong>di</strong> collaborare dopo essere stati informati<br />
riguardo al progetto che si vuole realizzare nella realtà scolastica, come per<br />
esempio:<br />
nel ripensare alla riqualificazione del giar<strong>di</strong>no della scuola;<br />
collaborare nella comprensione e nelle possibili soluzioni <strong>di</strong> problemi<br />
<strong>di</strong> tipo relazionale, che si rivelano ostacoli nell’ambiente educativo,<br />
anche grazie al supporto <strong>di</strong> una pedagogista; quest’ultima figura si<br />
ritrova, anche in un altro progetto, con l’obiettivo <strong>di</strong> aiutare le famiglie<br />
ad affrontare il tema dell’educazione allo spazio;<br />
altri genitori ancora vengono invitati a partecipare ad incontri serali per<br />
conoscere la natura e lo scopo del progetto o anche a partecipare alla<br />
formazione <strong>di</strong> un Eco comitato insieme al personale scolastico ed ai<br />
propri ragazzi.<br />
Ci sono, inoltre, progetti che prevedono il coinvolgimento delle famiglie<br />
tramite:<br />
57
questionari a tema, per esempio relativi agli spostamenti casa –<br />
scuola per poter oltre che essere informati riguardo la mobilità<br />
sostenibile anche offrire dei possibili suggerimenti;<br />
interviste, che oltre ad informare i genitori, li rendono anche<br />
collaboratori dei figli nel comprendere la tematica affrontata;<br />
invito ad uno spettacolo teatrale a tema, esibito dai bambini a<br />
fine del percorso, tramite il quale vengono comunicate le azioni svolte,<br />
relative al progetto realizzato, e vengono sensibilizzate le famiglie sulla<br />
tematica affrontata lungo tutto l’anno;<br />
partecipazione, a progetto terminato sul tema della mobilità<br />
sostenibile, ad una biciclettata finale per poter essere sensibilizzati<br />
all’assunzione <strong>di</strong> un comportamento eco – sostenibile.<br />
Riassumendo, tra i se<strong>di</strong>ci progetti che hanno vinto il Bando: quattro non<br />
prevedono nessun tipo <strong>di</strong> coinvolgimento dei genitori nel progetto; tra quelli<br />
che invece lo prevedono si potrebbe parlare principalmente <strong>di</strong> due approcci<br />
utilizzati che caratterizzano questo tipo <strong>di</strong> azioni: educativo, nei casi in cui si<br />
cerca una partecipazione delle famiglie nella realizzazione del progetto ed un<br />
coinvolgimento <strong>di</strong>retto grazie alla richiesta <strong>di</strong> proposte risolutive del problema<br />
su cui l’Istituto scolastico ha scelto <strong>di</strong> incentrare la sua attività; comunicativo,<br />
nei casi in cui si prevedono delle azioni informative relative al progetto o sui<br />
risultati ottenuti dagli studenti nel percorso a tematica ambientale.<br />
Età Dei Soggetti Coinvolti Nelle Attività<br />
(Appen<strong>di</strong>ce: Griglia 3)<br />
Grazie alla lettura dei dati raccolti durante la prima fase del mio lavoro è<br />
emerso che le reti realizzate tra gli Istituti scolastici si sviluppavano, nella<br />
maggior parte dei casi, in maniera “verticale”, cioè venivano inclusi nello<br />
stesso progetto scuole che andavano dalla prima infanzia o dalla scuola<br />
58
primaria, a scuole secondarie <strong>di</strong> primo e secondo grado, dunque uno scambio<br />
tra contesti che includevano studenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa età.<br />
Per questo motivo ho voluto verificare se nei progetti che presentavano questa<br />
caratteristica, si era riflettuto e pensato ad un adattamento reale delle attività<br />
previste per poterle far realizzare dai soggetti, sulla base della loro età e delle<br />
loro capacità.<br />
Volendo presentare una visione globale delle scuole <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso grado coinvolte<br />
nei progetti, si riporta che:<br />
sia le scuole dell’infanzia (circa 3 33 totali) che le scuole primarie (circa<br />
53 totali) sono presenti in <strong>di</strong>eci progetti su se<strong>di</strong>ci;<br />
le scuole secondarie <strong>di</strong> primo grado (circa 4 28 totali) sono quelle che<br />
hanno avuto un coinvolgimento maggiore rispetto alle altre essendo<br />
presenti in quattor<strong>di</strong>ci progetti su se<strong>di</strong>ci;<br />
le scuole secondarie <strong>di</strong> secondo grado (più <strong>di</strong> 8) hanno l’incidenza<br />
minore, rispetto alle altre, venendo coinvolte nella metà dei progetti<br />
vincitori, otto su se<strong>di</strong>ci.<br />
Per quanto riguarda l’adattamento delle attività, prevale un’attenzione nel<br />
farlo. Viene scelto un percorso idoneo per i soggetti delle <strong>di</strong>verse scuole per<br />
poter affrontare la tematica ed offrire dei contributi nella soluzione del<br />
problema con le proprie capacità; in questo modo vengono resi effettivamente<br />
partecipi sia i bambini, che non svolgono la funzione <strong>di</strong> semplici spettatori dei<br />
cambiamenti, ma <strong>di</strong> veri autori del cambiamento, offrendogli la possibilità <strong>di</strong><br />
esprimersi, farsi ascoltare e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare piccoli citta<strong>di</strong>ni attivi e consapevoli<br />
riguardo le tematiche ambientali; allo stesso tempo i ragazzi, si rivedono<br />
protagonisti nel progettare nuove soluzioni, ripensare ad i loro comportamenti<br />
3 Il numero non può essere definito con esattezza poiché uno dei progetti analizzati riporta la criticità<br />
<strong>di</strong> non aver ben specificato il numero delle scuole coinvolte, fa solo presente la tipologia, cioè scuola<br />
dell’infanzia e scuola primaria, ma non specifica il numero delle scuole dell’una e dell’altra.<br />
4 Anche in questo caso è presente un progetto che riporta il coinvolgimento <strong>di</strong> 21 scuole secondarie<br />
totali tra quelle <strong>di</strong> primo grado e <strong>di</strong> secondo grado ma non riporta i numeri precisi.<br />
59
ed agli stili <strong>di</strong> vita presenti nei loro ambienti vissuti e le criticità presenti in<br />
questi, <strong>di</strong> lavorare per esempio anche come tutor con i più piccoli, o<br />
trasmettere informazioni sulle tematiche affrontate nel progetto alla comunità<br />
citta<strong>di</strong>na.<br />
Sono presenti, comunque, tra i progetti analizzati, anche casi, cinque su se<strong>di</strong>ci,<br />
in cui si riscontrano delle criticità nel riuscire a delineare specifiche azioni a<br />
seconda dell’età, o meglio, sono ben descritte e definite le attività che<br />
andranno a svolgere ragazzi delle scuole <strong>di</strong> primo e secondo grado, ma non<br />
vengono presentate quelle de<strong>di</strong>cate ai bambini della scuola primaria o<br />
dell’infanzia, a seconda degli Istituti che hanno deciso <strong>di</strong> collaborare in rete.<br />
Tale criticità che si riscontra, nel momento in cui non viene esplicitata la<br />
modalità con cui i soggetti <strong>di</strong> età minore vengono resi effettivamente partecipi<br />
e attivi nella realizzazione del progetto, rappresenta una <strong>di</strong>fficoltà nel<br />
comprendere il come verranno coinvolti i bambini, come verrà presentata loro<br />
la tematica e come si cercherà <strong>di</strong> educarli in un ottica <strong>di</strong> sostenibilità.<br />
Educazione “Sul”, “Nel” O “Per” L’ambiente<br />
(Appen<strong>di</strong>ce: Griglia 4)<br />
Oggi si sta cercando <strong>di</strong><br />
«passare da un tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica ambientale svolta<br />
sull’ambiente, il cui obiettivo è la conoscenza degli<br />
elementi, delle relazioni e dei meccanismi che lo<br />
caratterizzano, un’attività che si esaurisce nello stu<strong>di</strong>o<br />
ecologico e che può svolgersi paradossalmente anche solo<br />
sui testi nell’ambito <strong>di</strong> una sola <strong>di</strong>sciplina, a un tipo <strong>di</strong><br />
attività svolta nell’ambiente, che ha al proprio centro<br />
l’esperienza, il vissuto, il coinvolgimento dei canali<br />
percettivi dell’allievo, fino a realizzare una vera<br />
60
educazione ambientale incentrata su attività per<br />
l’ambiente, il cui fulcro sono i comportamenti, e<br />
conseguentemente i valori da cambiare e i cambiamenti da<br />
proporre» (Bertacci, 2005: pag.58).<br />
«Le due principali <strong>di</strong>rezioni verso le quali l’educazione per<br />
l’ambiente dev’essere orientata sono: da un lato, la<br />
promozione <strong>di</strong> una nuova etica ambientale, fondata sulla<br />
consapevolezza, da parte dei singoli, dell’impatto che tanto<br />
sulla società quanto sugli ecosistemi viene esercitato<br />
dall’attuale sistema economico e sociale; dall’altro, lo<br />
sviluppo negli allievi delle conoscenze e abilità politiche<br />
necessarie per partecipare a pieno titolo al cambiamento<br />
<strong>di</strong> tale sistema» (Bardulla, 1998: pag.203).<br />
Ricercando la prospettiva <strong>di</strong> educazione ambientale prevalente nei progetti,<br />
cioè nel verificare se effettivamente riportano la volontà <strong>di</strong> voler mo<strong>di</strong>ficare i<br />
mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> riflettere e pensare all’ambiente per sviluppare cosi <strong>di</strong> conseguenza<br />
nuovi comportamenti responsabili nei confronti <strong>di</strong> esso, si potrebbe <strong>di</strong>re <strong>di</strong><br />
avere riscontrato dei risultati alquanto positivi: una prevalenza decisiva <strong>di</strong><br />
un’ educazione per l’ambiente. Si ritrova, infatti, in tutti i progetti posto<br />
come obiettivo principale quello <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare gli stili <strong>di</strong> vita e l’incidenza sui<br />
contesti locali.<br />
Ciò nonostante mi sembra opportuno segnalare che emerge comunque una<br />
criticità da non sottovalutare: non prevale la volontà <strong>di</strong> lasciare spazio alle idee<br />
dei ragazzi e <strong>di</strong> condurre iniziative basandosi su queste, ma ai soggetti<br />
vengono presentate, nella maggior parte dei casi, tematiche su cui riflettere già<br />
impostate e decise dall’ideatore del progetto stesso, senza prima aver<br />
verificato se sia questa effettivamente la necessità sentita da chi vive<br />
61
l’ambiente scolastico. Riprendendo un pensiero <strong>di</strong> Milena Bertacci, sarebbe<br />
auspicabile che nella progettazione educativa il tema ambientale possa essere<br />
assunto organizzando i <strong>di</strong>versi punti <strong>di</strong> vista, cominciando proprio dalle idee e<br />
dai vissuti che i ragazzi hanno dell’ambiente, altrimenti si corre il rischio <strong>di</strong><br />
costruire progetti anche ben strutturati dove però il bambino reale, o ragazzo,<br />
rischi <strong>di</strong> scomparire; nei progetti caso però sono in minoranza quelli che fanno<br />
partire le attività proprio da un’osservazione e riflessione degli educan<strong>di</strong><br />
(Bertacci, 2005).<br />
Modalità e In<strong>di</strong>catori per la Verifica del Raggiungimento degli Obiettivi<br />
e Risultati Attesi<br />
Il sistema In.F.E.A. è interessato a cogliere il senso generale degli effetti<br />
generati dai macrointerventi, dal momento che richiedono investimenti <strong>di</strong><br />
risorse politiche e finanziarie. Si ha ormai una crescente consapevolezza<br />
riguardo all’importanza della valutazione sulle azioni formative; questa può<br />
aiutare a riportare la valenza del progetto realizzato, delle sue risorse e<br />
criticità, per arricchire così quel patrimonio <strong>di</strong> documentazione legato alle<br />
esperienze accumulate nell’ambito dell’educazione ambientale.<br />
La valutazione nei processi formativi può essere sviluppata secondo<br />
«prospettive <strong>di</strong>fferenziate entro cui ogni tipo <strong>di</strong> valutazione trova una sua<br />
specifica caratterizzazione, il cui senso <strong>di</strong>stintivo è dato principalmente dagli<br />
oggetti su cui si concentra l’attenzione valutativa, ma anche dalle sue finalità,<br />
dai meto<strong>di</strong> utilizzati per realizzarla e, soprattutto, dai soggetti che la realizzano<br />
(oltre che dalla loro “posizione” <strong>di</strong> attori interni oppure esterni rispetto al<br />
sistema d’azione da valutare)» (Lipari, 1995: pag. 106).<br />
Nella compilazione del modulo <strong>di</strong> presentazione dei progetti veniva richiesto,<br />
esplicitamente, <strong>di</strong> descrivere quali modalità e in<strong>di</strong>catori sarebbero stati<br />
utilizzati, sia per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati<br />
attesi, sia del processo <strong>di</strong> collaborazione previsto.<br />
62
Si è rivelato <strong>di</strong>fficile cercare <strong>di</strong> riportare al meglio i dati raccolti in questa fase,<br />
poiché ogni progetto ha utilizzato una sua modalità descrittiva del processo <strong>di</strong><br />
verifica e dei criteri propri, rendendo complicato l’azione <strong>di</strong> sintesi e <strong>di</strong><br />
rappresentazione dei risultati. Oltre a questo sono state riscontrate <strong>di</strong>fferenti<br />
criticità.<br />
Come elemento comune, presente nel 50% dei progetti, è emersa la volontà <strong>di</strong><br />
rilevare il gra<strong>di</strong>mento dei soggetti coinvolti tramite report, schede e<br />
questionari.<br />
Gli in<strong>di</strong>catori scelti, nei <strong>di</strong>versi casi <strong>di</strong> progetto, sono stati sia quantitativi,<br />
come ad esempio i numeri relativi alle classi coinvolte, ai partecipanti, alle<br />
collaborazioni attivate, ai questionari compilati; sia qualitativi, come la<br />
verifica della mo<strong>di</strong>fica dei comportamenti, quali nuove pratiche sono state<br />
attivate, le conoscenze e le competenze acquisite, la qualità degli elaborati.<br />
Per la verifica dell’efficacia e riuscita del progetto è stato scelto <strong>di</strong> utilizzare<br />
strumenti come : questionari (nella maggior parte dei casi), focus group,<br />
interviste, la comparazione tra test d’ingresso e test d’uscita.<br />
I soggetti che si vedono coinvolti nella compilazione <strong>di</strong> questi strumenti, a<br />
seconda dei <strong>di</strong>versi casi, sono in or<strong>di</strong>ne decrescente rispetto alla percentuale<br />
riscontrata: ragazzi, docenti, genitori, bambini, personale ATA.<br />
Ci tengo a riportare inoltre, per una migliore comprensione del lavoro, le<br />
<strong>di</strong>fferenti criticità riscontrate in alcuni dei progetti:<br />
mancata descrizione dei soggetti coinvolti nel lavoro <strong>di</strong> verifica,<br />
criticità che si riscontra in sei progetti su se<strong>di</strong>ci;<br />
chiarificazione sugli strumenti che guideranno questa fase dei progetti,<br />
o comunque assenza <strong>di</strong> una descrizione riguardo la modalità <strong>di</strong> verifica<br />
in quattro dei progetti;<br />
in due dei progetti vi è l’assenza totale degli in<strong>di</strong>catori.<br />
63
Modalità E Prodotti Per La Divulgazione Dei Risultati<br />
Partendo dalle modalità scelte per la <strong>di</strong>vulgazione dei risultati, ne sono state<br />
riscontrate <strong>di</strong>fferenti, alcune più prevalenti in modo decisivo rispetto ad altre,<br />
che riporto qui <strong>di</strong> seguito riassunte in quattro macro categorie:<br />
utilizzo dei siti internet, scolastici, comunali, regionali, in più della<br />
metà dei progetti, do<strong>di</strong>ci su se<strong>di</strong>ci;<br />
manifestazioni, mostre, spettacoli teatrali, presenti in oltre la metà dei<br />
casi;<br />
comunicati/conferenze stampa, TV e giornali locali nel 50%;<br />
seminari e forum aperti alla citta<strong>di</strong>nanza, presenti in un 25%.<br />
Per quanto riguarda invece la scelta delle tipologie <strong>di</strong> prodotti, utili per<br />
informare sull’esperienza svolta dagli istituti, si è riscontrata la produzione <strong>di</strong><br />
una documentazione del percorso tramite:<br />
materiale cartaceo informativo, come depliant, brochure, volantini,<br />
locan<strong>di</strong>ne e report, scelta fatta da più della metà dei progetti;<br />
fotografie, video, cartelloni, <strong>di</strong>ari e <strong>di</strong>segni, che riscontra invece una<br />
percentuale più bassa rispetto quella precedente, cioè uno scarso 50%;<br />
materiale multime<strong>di</strong>ale e Dvd nella minoranza dei casi, cinque progetti<br />
su se<strong>di</strong>ci.<br />
Coinvolgimento Dell’area Dell’informazione O Dell’educazione<br />
Ambientale<br />
(Appen<strong>di</strong>ce: Griglia 5)<br />
64
In questo lavoro <strong>di</strong> lettura, si è cercato <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli interlocutori e le<br />
azioni che coinvolgevano l’area dell’informazione ambientale e quelli invece<br />
legati all’educazione ambientale.<br />
Per quanto riguarda l’area dell’informazione ambientale, nel punto precedente<br />
sono già state riportate <strong>di</strong>verse delle iniziative comunicative previste nei<br />
progetti, come mostre, spettacoli teatrali, siti web, etc. Tali iniziative erano<br />
state riprese da una specifica sezione del bando. In questa parte sono state,<br />
invece, ricercate le medesime informazioni all’interno dell’intera descrizione<br />
del progetto, per poter in<strong>di</strong>viduare, se presenti, altri elementi.<br />
Nel caso <strong>di</strong> coinvolgimento dell’area dell’educazione ambientale, è<br />
interessante riportare la risorsa <strong>di</strong> oltre la metà dei progetti, che hanno<br />
riflettuto e previsto, oltre che una formazione degli alunni, anche<br />
un’educazione rivolta agli insegnanti ed al personale scolastico grazie ad<br />
azioni come: corsi <strong>di</strong> formazione, riguardanti le tematiche affrontate nel<br />
progetto; partecipazione nell’attività pratica o nel riscontrare bisogni e<br />
miglioramenti possibili da attuare.<br />
Sempre in un 50% dei progetti, è presente la volontà <strong>di</strong> coinvolgere le<br />
famiglie, fattore che si è già riportato nel secondo punto delle caratteristiche<br />
ricercate. A queste infatti vengono de<strong>di</strong>cate attività principalmente<br />
informative, ma anche educative. Esempi <strong>di</strong> quest’ultime sono il richiedere<br />
loro <strong>di</strong> partecipare ad iniziative come laboratori <strong>di</strong> gruppo per contribuire ai<br />
lavori da attuare, fargli comprendere il loro ruolo <strong>di</strong> appartenenza, consentirgli<br />
la partecipazione nell’azione riqualificativa degli spazi.<br />
Tenendo in considerazione la percentuale <strong>di</strong> progetti che hanno previsto<br />
l’inclusione delle famiglie nei percorsi, si può ritenere <strong>di</strong> buon auspicio il fatto<br />
che oltre la metà <strong>di</strong> questi, cinque su se<strong>di</strong>ci, ha pensato ad attività che<br />
coinvolgono l’area dell’educazione ambientale. Gli altri invece de<strong>di</strong>cano agli<br />
stessi interlocutori attività <strong>di</strong> tipo comunicativo, con<strong>di</strong>videndo con loro il<br />
progetto, rivolgendogli interviste o questionari, spesso legati alla ricerca della<br />
mobilità sostenibile.<br />
65
Mantenendo sotto esame le attività che coinvolgono l’area dell’informazione<br />
ambientale, si riportano quelle rivolte all’intera comunità, presenti in ogni<br />
progetto, come: mostre a tema, che spesso riportano le buone pratiche<br />
rintracciate nel percorso <strong>di</strong> lavoro dei ragazzi, o le loro proposte d’azione;<br />
laboratori sugli spazi collettivi della scuola, della città e sulla mobilità<br />
sostenibile in cui si cerca <strong>di</strong> coinvolgere i <strong>di</strong>versi attori in modo lu<strong>di</strong>co e<br />
ricreativo; <strong>di</strong>vulgazione <strong>di</strong> materiale come volantini e brochure; promozione <strong>di</strong><br />
forme <strong>di</strong> mobilità alternative, come l’uso della bicicletta. Alcune <strong>di</strong> queste<br />
attività sono previste anche grazie alla richiesta esplicita del sistema In.F.E.A.<br />
<strong>di</strong> riportare azioni da realizzare durante la settimana DESS (Decennio<br />
dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile), quest’anno de<strong>di</strong>cata alla mobilità<br />
sostenibile.<br />
Si riporta che in tutti i progetti sono presenti attività che coinvolgono,<br />
dunque, entrambe le aree, sia dell’informazione che dell’educazione;<br />
quelle comunicative sono principalmente rivolte al territorio con la volontà<br />
delle scuole <strong>di</strong> far conoscere e <strong>di</strong>vulgare le attività realizzate insieme ai<br />
ragazzi, inoltre anche per mostrarsi come istituzioni aperte e partecipi nella<br />
realtà comunitaria e promotrici <strong>di</strong> quei cambiamenti necessari per la<br />
formazione <strong>di</strong> una nuova società sostenibile.<br />
Riguardo le attività educative, si erano già riscontrate nel primo punto le<br />
<strong>di</strong>verse tematiche affrontate nei progetti, si denota qui una prevalenza <strong>di</strong><br />
metodologie esplorative con cui si cerca <strong>di</strong> portare gli studenti ad osservare e<br />
vivere il territorio circostante, ma soprattutto anche l’ambiente scuola, con<br />
lavori sul campo per poter partecipare in azioni promotrici <strong>di</strong> cambiamento,<br />
imparare a sviluppare quelle capacità in grado <strong>di</strong> risolvere problematiche<br />
ambientali e sociali, tutto questo grazie all’esperienza <strong>di</strong>retta del fare e del co-<br />
progettare insieme.<br />
66
4<br />
CONCLUSIONI<br />
“Meglio una testa ben fatta<br />
che una testa piena”<br />
Michel De Montaigne<br />
L’educazione ambientale, nel decennio che intercorre tra Rio e Johannesburg,<br />
si è evoluta sempre più verso una più complessa e comprensiva <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong><br />
educazione alla sostenibilità. In questo periodo sono state ampliate<br />
significativamente le sue finalità, le sue metodologie e le sue tipologie <strong>di</strong><br />
servizi; oltre ad essersi elevata la qualificazione degli operatori, si sono<br />
maggiormente strutturati gli enti che la promuovono e la loro organizzazione.<br />
In altre parole si può <strong>di</strong>re che l’educazione ambientale progressivamente si è<br />
integrata con gli altri strumenti per lo sviluppo sostenibile.<br />
Nel corso <strong>di</strong> questa tesi si è cercato <strong>di</strong> illustrare alcuni dei processi che sono<br />
stati messi in atto a livello nazionale e locale, per rispondere alla sfida che ci si<br />
è preposti in seguito agli eventi <strong>di</strong> carattere internazionale come Rapporto<br />
Bruntland, Agenda 21 e tanti altri. Tale sfida è <strong>di</strong> giungere al cambiamento dei<br />
comportamenti sbagliati, che stanno alimentando una crisi sia ambientale che<br />
sociale, introducendo e sperimentando nuovi processi educativi che aiutino<br />
nella formazione <strong>di</strong> una citta<strong>di</strong>nanza attiva, partecipe e consapevole. Se si<br />
vuole giungere a una reale mo<strong>di</strong>fica degli stili <strong>di</strong> vita attuali, alla sostenibilità,<br />
non basta, anche se innegabilmente importante, soffermarsi a riflettere su<br />
un'educazione ambientale e sulla sua efficacia. Essa è <strong>di</strong>ventata uno strumento<br />
trasversale e fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile, in<br />
grado <strong>di</strong> favorire conoscenza, motivazione, partecipazione attiva non solo<br />
67
degli studenti, ma <strong>di</strong> tutti i citta<strong>di</strong>ni. Nei contenuti della Dichiarazione <strong>di</strong><br />
Salonicco, altra tappa incisiva per il nuovo contesto educativo attuale, tra i<br />
passaggi più significativi e innovativi, racchiude la seguente definizione:<br />
«Il concetto <strong>di</strong> sostenibilità comprende non solo l’ambiente<br />
ma povertà, popolazione, salute, sicurezza ambientale,<br />
democrazia, <strong>di</strong>ritti umani e pace. La sostenibilità è in<br />
ultima analisi un imperativo morale ed etico in cui devono<br />
essere rispettate <strong>di</strong>versità culturali e conoscenze<br />
tra<strong>di</strong>zionali» (Tamburini, 2007: p.455).<br />
In quanto educatori e insegnanti occorre interrogarsi sulle abitu<strong>di</strong>ni, le<br />
modalità <strong>di</strong> agire e le chiavi interpretative, appartenenti ai soggetti della<br />
società del consumo e del benessere. Da qui, bisogna fare un passo in<strong>di</strong>etro e<br />
riflettere sugli atteggiamenti, che stanno <strong>di</strong>etro ai comportamenti e che<br />
influenzano e guidano le scelte: pensare a questi vuol <strong>di</strong>re interrogarsi sui<br />
significati che sono attribuiti alle cose e su come si sono andati a creare,<br />
attraverso quali esperienze. Dal mio punto <strong>di</strong> vista queste ultime sono<br />
occasioni: situazioni attraverso cui ognuno <strong>di</strong> noi è andato a formare, anche<br />
inconsapevolmente, idee, significati, mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> leggere il mondo e gli<br />
avvenimenti.<br />
È proprio dalla riflessione su queste che l’educazione deve cominciare il suo<br />
percorso per giungere al suo fine. Chi educa non può de<strong>di</strong>care la sua azione<br />
esclusivamente nel trasmettere un sapere, ma deve soffermarsi anche a creare<br />
e proporre quelle situazioni utili che <strong>di</strong>ano la possibilità <strong>di</strong> fare esperienza<br />
formativa. È in questo modo che è permesso all’educando <strong>di</strong> produrre<br />
saperi/idee e <strong>di</strong> “condurre fuori”, vero significato della parola “educare” che<br />
oggi sembra, però, essere stato <strong>di</strong>menticato e sostituito con l’intento <strong>di</strong><br />
“mettere dentro” più informazioni possibili, con l’illusione che questo sia<br />
sufficiente alla formazione <strong>di</strong> caratteri idonei a questa società ricca <strong>di</strong><br />
68
complessità. Non dobbiamo <strong>di</strong>menticarci che, come <strong>di</strong>ce Michel De<br />
Montaigne, “meglio una testa ben fatta che una testa piena”, dunque è più<br />
importante formare piuttosto che in-formare (Morin, 2000). Credo sia utile<br />
“progettare” occasioni <strong>di</strong> esperienza per la sfera sociale e identitaria, nel<br />
tentativo <strong>di</strong> aiutare nel processo <strong>di</strong> crescita e formazione.<br />
Oggi nella società attuale l’educazione <strong>di</strong>venta motore della cultura e deve<br />
dunque «incrementare le competenze delle generazioni più giovani rendendole<br />
sempre più adeguate alle esigenze <strong>di</strong> una società moderna» (Farnè, 1991: p.<br />
109). Ci si rende conto però della necessità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la con<strong>di</strong>zione<br />
tra<strong>di</strong>zionale della scuola, cioè d'isolamento e la pre<strong>di</strong>sposizione a usare un<br />
insegnamento <strong>di</strong> tipo meramente cognitivo che fornisce sì un bagaglio<br />
notevole <strong>di</strong> conoscenze <strong>di</strong> tipo formale, astratto e simbolico, ma non è in grado<br />
<strong>di</strong> formare una persona attiva, responsabile e consapevole, in grado <strong>di</strong> far<br />
fronte alle sfide poste dalle attuali e future società complesse, in grado <strong>di</strong><br />
compiere scelte.<br />
In questo mondo in continua trasformazione le conoscenze sono destinate a<br />
essere consumate. Pertanto è in<strong>di</strong>spensabile formare le menti che possano<br />
<strong>di</strong>sporre «<strong>di</strong> un'attitu<strong>di</strong>ne generale a porre e trattare i problemi e <strong>di</strong> principi<br />
organizzatori che permettano <strong>di</strong> collegare i saperi e <strong>di</strong> dare loro senso»<br />
(Morin, 2000: p. 15).<br />
La scuola necessita <strong>di</strong> una vera rivoluzione metodologica nei rapporti tra<br />
teoria e pratica. Per quanto riguarda l’aspetto cognitivo occorre alimentare la<br />
pre<strong>di</strong>sposizione ad un’inter<strong>di</strong>sciplinarietà, poiché una criticità<br />
dell’insegnamento oggi sta nell’inadeguatezza dei nostri saperi, <strong>di</strong>stinti e<br />
frazionati in <strong>di</strong>scipline, alla realtà e ai problemi che si rivelano sempre più<br />
poli<strong>di</strong>sciplinari, globali e planetari (Morin, 2000). Occorre poi integrare il<br />
lavoro <strong>di</strong> conoscenza ad esperienze, in cui poter mettere in pratica questa. Se<br />
ci si pone l’obiettivo <strong>di</strong> educare alla sostenibilità si deve avere la<br />
69
consapevolezza che il rispetto e la tutela non si imparano stu<strong>di</strong>ando sui libri,<br />
ma agendo ed interagendo ogni giorno nella realtà in cui si vive e si agisce.<br />
«Continuità vuol <strong>di</strong>re ciclo lungo, processi maturativi più<br />
tranquilli, appren<strong>di</strong>menti più <strong>di</strong>stesi, più tempo per le<br />
relazioni e maggiori opportunità <strong>di</strong> stare nel proprio<br />
territorio e animarlo» (Sacchi, 2009: p. 144).<br />
Continuità significa anche consentire lo sviluppo <strong>di</strong> una personalità completa,<br />
in grado <strong>di</strong> operare in una realtà complessa e <strong>di</strong> maturare competenze. Occorre<br />
dunque richiamare la necessità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere occasioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo, <strong>di</strong> lavoro<br />
insieme, <strong>di</strong> scambio reciproco, <strong>di</strong> progetti e azioni comuni. Queste attività però<br />
non devono, e non possono, essere pensate esclusivamente per le giovani<br />
generazioni, ma è essenziale che ci si muova verso un’educazione anche del<br />
mondo adulto, maggiore costruttore <strong>di</strong> significati e immagine <strong>di</strong> modelli da<br />
seguire ed imitare dei ragazzi.<br />
Dopo aver illustrato i risultati emersi dalla mia ricerca, riporto qui <strong>di</strong> seguito,<br />
in questo capitolo conclusivo, gli elementi su cui ho sviluppato le mie<br />
riflessioni.<br />
4.1 Cambiamenti in Atto nelle Scuole<br />
Nel capitolo 36 dell’Agenda 21 l’educazione, sia formale che informale, è<br />
in<strong>di</strong>spensabile per la promozione dello sviluppo sostenibile e per promuovere<br />
ed ottenere un’effettiva partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni nei processi decisionali. In<br />
esso sono presenti i punti essenziali che sarebbe necessario mo<strong>di</strong>ficare, per<br />
riorientare l’educazione verso questi nuovi obiettivi, come:<br />
inserire i concetti <strong>di</strong> ambiente e sviluppo in tutti i programmi <strong>di</strong><br />
istruzione;<br />
70
attuare una completa revisione dei curricula per rendere possibile un<br />
approccio multi<strong>di</strong>sciplinare a questi temi;<br />
<strong>di</strong>ffondere lo stu<strong>di</strong>o dello stato <strong>di</strong> salute dell’ambiente locale e<br />
regionale;<br />
<strong>di</strong>ffondere l’innovazione <strong>di</strong>dattica e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> provata efficacia.<br />
Si <strong>di</strong>mostra chiara la volontà del voler condurre e stimolare un approccio<br />
innovativo integrato e intersettoriale, nel quale a integrarsi sono le <strong>di</strong>scipline e<br />
gli strumenti (gestionali, informativi, formativi, partecipativi,<br />
responsabilizzanti) (Tamburini, 2007).<br />
Ritengo significativo soffermarmi sul punto che riguarda la revisione dei<br />
curricula, in quanto azione complessa ma necessaria che sta portando al<br />
cambiamento della <strong>di</strong>dattica e dell’organizzazione scolastica. Il curricolo,<br />
infatti, è proprio lo strumento che può consentire alla scuola <strong>di</strong> dare una<br />
risposta significativa e che permette <strong>di</strong> costruire l’orizzonte formativo entro il<br />
quale le preoccupazioni della sostenibilità si <strong>di</strong>vidono nei saperi, nei meto<strong>di</strong>,<br />
nelle attività, nei comportamenti, nelle relazioni, ecc. Si intende, con la sua ri-<br />
elaborazione, far giungere a nuove interpretazioni, sensibilità, comportamenti<br />
e competenze necessarie (Sacchi, 2009). Occorre costruire nuove “identità e<br />
capacità progettuali” che, misurandosi con le sfide e le innovazioni in atto,<br />
cerchino <strong>di</strong> orientarle verso la sostenibilità e la solidarietà, invece che verso la<br />
competizione in<strong>di</strong>viduale e la crescita illimitata.<br />
Le nuove competenze, che sarebbe necessario promuovere e coltivare, sono<br />
ad esempio <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>alogico, <strong>di</strong> ascolto, reinterpretazione, cognitivo/emotive,<br />
<strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione, <strong>di</strong> autovalutazione e autocorrezione, ecc. Se la scuola dovesse<br />
perseverare a privilegiare l’aspetto cognitivo, in modo pressoché esclusivo,<br />
rischierebbe <strong>di</strong> non adempiere pienamente ai suoi compiti educativi: la società<br />
attuale richiede alle persone flessibilità e capacità <strong>di</strong> adeguare le conoscenze<br />
proprie in situazioni sempre nuove; la capacità dunque <strong>di</strong> essere reattivi e in<br />
grado <strong>di</strong> prendere decisioni partecipate, <strong>di</strong> essere attivi e pratici, quin<strong>di</strong> non<br />
71
astratti e simbolici. Una scuola quin<strong>di</strong> “statica” in una società complessa non<br />
coglie le giuste sfide educative che gli vengono poste per formare personalità<br />
idonee e citta<strong>di</strong>ni in grado <strong>di</strong> compiere scelte attive. In questo contesto è da<br />
attuare una completa revisione dei curricola per rendere possibile un approccio<br />
multi<strong>di</strong>sciplinare ai temi <strong>di</strong> sviluppo sostenibile e <strong>di</strong> un’effettiva<br />
partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni.<br />
Tenendo in considerazione il mio lavoro svolto con riferimento al Bando<br />
In.F.E.A. 2010, penso sia interessante riportare la presenza <strong>di</strong> una sezione<br />
de<strong>di</strong>cata al curricolo ed alla sua mo<strong>di</strong>fica, in quanto risorsa dei progetti.<br />
L’Infea ha, infatti, richiesto <strong>di</strong> prevedere ed esplicitare nei progetti presentati<br />
dalle scuole, per essere ammesse al bando, l’inserimento nel Curricolo<br />
dell’Istituto Scolastico delle azioni previste nel progetto; inoltre si dovevano<br />
prevedere modalità per rendere l’azione realizzata permanente e continuativa<br />
nel tempo. Ciò significa che tutti i progetti che saranno realizzati dalle scuole<br />
vincitrici, da ricordare che sono tutte attività realizzate da scuole in rete,<br />
consentiranno un concreto cambiamento ed un'evoluzione del curricolo<br />
scolastico in un’ottica sostenibile. Oltre a questa richiesta, il sistema In.F.E.A.,<br />
nella valutazione dei progetti, ha tenuto anche conto, come fattore positivo, <strong>di</strong><br />
un'eventuale partecipazione al progetto “Verso un’ecologia del curricolo”<br />
degli insegnanti delle scuole in partnership; questo fattore può consentire <strong>di</strong><br />
avere un quadro sul grado <strong>di</strong> conoscenze e interesse dei docenti ed educatori<br />
coinvolti, verso un'effettiva realizzazione <strong>di</strong> una scuola sostenibile.<br />
Dall’analisi sui risultati emersi riguardo ai temi affrontati nei progetti, è<br />
opportuno sottolineare la volontà delle scuole <strong>di</strong> voler introdurre delle effettive<br />
mo<strong>di</strong>fiche all’interno del loro spazio, non solo per quanto riguarda l’ambiente<br />
naturale e la sua riqualificazione, ma soprattutto rivisitare la scuola in quanto<br />
ambiente <strong>di</strong> relazioni e <strong>di</strong> luogo situato in un territorio, con il quale è<br />
importante interagire e collaborare nella crescita comune <strong>di</strong> una citta<strong>di</strong>nanza<br />
72
attiva e partecipe. Si <strong>di</strong>mostra, dunque, la necessità <strong>di</strong> riflettere sulle modalità<br />
opportune da applicare per giungere ai fini educativi. Potendo parlare della<br />
situazione regionale, dopo aver preso in esame questo contesto, si può<br />
considerare come elemento positivo la volontà e le attività ormai messe in atto<br />
dalle scuole, per aprirsi realmente alla comunità. Le scuole oggi hanno colto la<br />
necessità <strong>di</strong> una collaborazione attiva con altri enti locali, quin<strong>di</strong> vi è presente<br />
un Sistema Formativo Integrato, per riuscire nell’intento <strong>di</strong> educare alla<br />
sostenibilità e <strong>di</strong> fornire occasioni nuove <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento, non più legate<br />
esclusivamente all’aula e alla metodologia trasmissiva del sapere.<br />
Con i progetti considerati, inoltre, si mostra l’intento <strong>di</strong> promuovere con<br />
attività <strong>di</strong>verse corretti stili <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> comportamento in relazione alla<br />
comunità scolastica e alla sostenibilità dello spazio educativo; dunque oltre<br />
che un’attenzione alle relazioni esterne con il territorio, vi è la volontà <strong>di</strong><br />
riqualificare i luoghi interni dell’Istituto e le relazioni che ne fanno parte,<br />
portando l’ambiente a trasformarsi in spazio vissuto (Iori, 1996).<br />
Le emergenze ambientali del nostro paese, ma non solo, richiedono che si<br />
debba agire a livello educativo intervenendo sui modelli culturali <strong>di</strong><br />
riferimento, sugli stili <strong>di</strong> vita, sugli approcci <strong>di</strong> pensiero alla realtà, sull’etica<br />
per rendere le persone più sensibili rispetto alle questioni ambientali,<br />
<strong>di</strong>ffondendo capacità, valori e comportamenti nella prospettiva dello sviluppo<br />
sostenibile.<br />
La scuola, anche se non è la sola a doversi caricare <strong>di</strong> queste responsabilità, è<br />
l’attore per eccellenza dell’intervento formativo; questo non va <strong>di</strong>menticato in<br />
quanto risorsa. Come si è detto, però, essa in questa nuova sfida educativa,<br />
non può pensare <strong>di</strong> riuscire nell’intento senza cogliere ogni possibilità e<br />
occasione <strong>di</strong> collaborazione con esperti e con l’aiuto <strong>di</strong> competenze <strong>di</strong>verse<br />
dalle proprie. Si potrebbe inoltre aggiungere che non si può più prescindere<br />
dal far interagire conoscenze ed esperienze, riconoscendo lo scambio<br />
reciproco come crescita sia in<strong>di</strong>viduale che collettiva, in quanto è proprio<br />
73
questo scambio <strong>di</strong> idee e opinioni che si vuole trasmettere e insegnare alle<br />
nuove generazioni, creando occasioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo e <strong>di</strong> lavoro in rete essendo<br />
vera ed innegabile modalità idonea per arrivare ad una sostenibilità collettiva.<br />
Per questo motivo le Istituzioni scolastiche, ma anche amministrazioni, organi<br />
informativi ed enti locali devono <strong>di</strong>ventare e continuare ad essere l’esempio <strong>di</strong><br />
un modello da seguire.<br />
L’educazione ambientale è una <strong>di</strong>sciplina complessa in quanto comporta due<br />
ambiti: quello educativo e quello scientifico e nella pratica educativa<br />
sostenibile occorre una cooperazione <strong>di</strong> esperti e insegnanti per arrivare a<br />
trasmettere il sapere.<br />
È per questo che si sta cercando <strong>di</strong> aiutare la scuola ad aprirsi al territorio e ciò<br />
è necessario proprio perché l’educazione ambientale copre un contesto ampio<br />
che comprende l’educazione formale, non formale e informale.<br />
La risorsa del caso regionale <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>, sta nell’essere pronta a<br />
mettere in atto un significativo cambiamento organizzativo <strong>di</strong> enti locali e<br />
istituzioni, avendo dato vita e forma al consolidamento <strong>di</strong> un contesto <strong>di</strong><br />
rete a tema <strong>di</strong> educazione alla sostenibilità reale e riconosciuto dalla regione<br />
stessa, ma questo lo si approfon<strong>di</strong>rà tra qualche paragrafo.<br />
Riprendendo il <strong>di</strong>scorso scuola e i suoi processi <strong>di</strong> cambiamento in atto, si è<br />
visto come nella progettazione delle attività educative, presentate al Bando,<br />
vengono colte le occasioni che si ritrovano anche all’esterno dello spazio<br />
scuola, in cui è necessario produrre un cambiamento; vengono utilizzati,<br />
infatti, come elementi su cui in<strong>di</strong>rizzare la partecipazione dei ragazzi,<br />
consentendogli <strong>di</strong> riflettere, valutare e proporre soluzioni a problemi realmente<br />
esistenti all’interno della propria comunità. Ho ritrovato nei progetti attività<br />
legate allo stu<strong>di</strong>o e la formulazione <strong>di</strong> proposte <strong>di</strong> percorsi per una mobilità<br />
sostenibile; o anche il lavoro svolto dai ragazzi <strong>di</strong> informarsi e promuovere<br />
attività <strong>di</strong> riciclaggio/riutilizzo dei rifiuti e <strong>di</strong> risparmio energetico. Nella<br />
riorganizzazione dei curricula è fondamentale giungere all’integrazione reale<br />
74
tra una <strong>di</strong>dattica laboratoriale con quella contenutistica, poiché si riconosce<br />
l’inter<strong>di</strong>pendenza tra le due e la risorsa educativa che possono essere insieme.<br />
Il promuovere all’interno della scuola attività partecipative è importante<br />
poiché permette <strong>di</strong> creare occasioni <strong>di</strong> collaborazione, scambio <strong>di</strong> opinioni e<br />
riflessione su questi temi, lavorando in gruppo per uno scopo comune.<br />
Consente <strong>di</strong> comprendere la complessità che sta <strong>di</strong>etro alle scelte <strong>di</strong><br />
rinnovamento; <strong>di</strong> considerare tutti gli elementi che influenzano e interagiscono<br />
nella realtà delle cose; <strong>di</strong> fare esperienza sulle <strong>di</strong>fficoltà che si possono<br />
presentare per condurre un’azione; genera competenze <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo, <strong>di</strong> visione<br />
olistica e problematica, <strong>di</strong> responsabilità e capacità <strong>di</strong> risoluzione. I ragazzi<br />
trovandosi a progettare insieme una soluzione ad un problema reale fanno<br />
esperienza su quanto sia importante collaborare e partecipare per una comunità<br />
migliore: fanno esperienza su come ci si sente ad essere citta<strong>di</strong>ni attivi.<br />
Aspetto positivo che si riscopre sono anche i lavori svolti in partnership tra<br />
ragazzi <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse età, con attività anche <strong>di</strong> tutoraggio degli studenti più gran<strong>di</strong><br />
su quelli <strong>di</strong> primarie o secondarie <strong>di</strong> primo grado; sono stati dunque pensati sia<br />
percorsi intergenerazionali che rapporti educativi tra pari.<br />
L’attività <strong>di</strong>dattica, deve continuare a lavorare in questa <strong>di</strong>rezione e spostarsi<br />
sempre più dalla fase della conoscenza a quella <strong>di</strong> interpretazione e<br />
valutazione, «al fine <strong>di</strong> consolidare la fase d’intervento che lancia verso la<br />
partecipazione; i giovani sarebbero così spinti a cercare e promuovere<br />
soluzioni attraverso la progettazione partecipata» (Bonfanti, 2009: p. 117).<br />
Con la partecipazione è possibile far comprendere la complessità e gli<br />
elementi <strong>di</strong>versi che portano alla formazione e influenzano gli eventi sociali e<br />
ambientali. Ci si potrebbe, dunque, auspicare che la continuità <strong>di</strong> questa<br />
metodologia <strong>di</strong> lavoro, aiuti ad allontanare quell’in<strong>di</strong>vidualismo predominante,<br />
sostituendolo con personalità collaborative che comprendono l’importanza e la<br />
ricchezza <strong>di</strong> “lavorare insieme” per giungere ad un fine che interessa “l’io”,<br />
ma anche e soprattutto “il noi” in quanto comunità.<br />
75
Occorre quin<strong>di</strong> attribuire «maggior attenzione e potenziare attraverso la<br />
progettazione <strong>di</strong> percorsi <strong>di</strong> educazione ambientale che rafforzino la visione<br />
olistica, attraverso una <strong>di</strong>dattica che affronti i gran<strong>di</strong> temi, le gran<strong>di</strong> questioni<br />
dell’umanità e della sua sostenibilità; in questo modo verrebbero favoriti<br />
l’inter<strong>di</strong>sciplinarità e lo stimolo ad attività <strong>di</strong> intervento che prevedano fasi<br />
propositive sviluppate dagli studenti» (Bonfanti, 2009: p.116).<br />
4.2 Complessità <strong>di</strong> un’Educazione Sostenibile<br />
All’inizio del mio percorso <strong>di</strong> tesi mi ero posta una domanda principale a cui<br />
ho cercato <strong>di</strong> dare una risposta: capire quale idea <strong>di</strong> educazione alla<br />
sostenibilità fosse presente oggi nelle Istituzioni scolastiche.<br />
Attraverso le tematiche affrontate dalle scuole, emerse non solo dai progetti<br />
analizzati per questo bando, ma anche da ricerche promosse dalla regione<br />
negli anni scorsi, sono giunta a comprendere che vi è una sensibilità forte sui<br />
consumi energetici e idrici, all’educare quin<strong>di</strong> al risparmio ed al consumo<br />
responsabile delle risorse; oltre a questo è presente anche un'educazione sul<br />
riciclaggio ed il riutilizzo dei prodotti. La preoccupazione principale che<br />
emerge è dunque quella <strong>di</strong> trovare una soluzione al surriscaldamento globale.<br />
Poi c’è una volontà del voler trasmettere le capacità e l’interesse <strong>di</strong> intervenire<br />
sul territorio e <strong>di</strong> voler costruire una comunità partecipe e attiva sulle<br />
problematiche locali. Considererei queste delle buone pratiche da portare<br />
avanti all’interno delle istituzioni e che rispecchiano il tipo <strong>di</strong> insegnamento<br />
sostenibile trasmesso dalle scuole.<br />
Manca però ancora una cosa, forse quella che alla fine incide <strong>di</strong> più:<br />
un’educazione vera e forte sul consumo consapevole. È il consumo <strong>di</strong> merci<br />
secondarie che porta al maggior inquinamento, o meglio la loro produzione su<br />
grande scala data dalla forte richiesta. L’importanza e l’urgenza su questa sta<br />
nella <strong>di</strong>pendenza al consumo, che viene confuso con il benessere, confonde e<br />
modella personalità/identità non effettivamente responsabili e sensibili a<br />
76
tematiche ambientali o sociali, ma identità egoiste ed in<strong>di</strong>vidualiste che<br />
cercano ogni mezzo per ottenere “cose”. (Si ricava più piacere dalle cose che<br />
dalla compagnia e l’affetto degli altri). Quello che cerco <strong>di</strong> <strong>di</strong>re è che<br />
occorrerebbe una riflessione sul motivo che porta giovani, ma anche adulti, a<br />
costruire le proprie certezze e identità su degli oggetti, al materialismo<br />
esistente che guida e bilancia le relazioni. Perché siamo schiavi delle<br />
pubblicità e dei consumi? Perché si confonde il consumo con il benessere?<br />
Credo sia importante nel contesto educativo e formativo introdurre riflessioni<br />
che portino i soggetti a comprendere l’importanza <strong>di</strong> basare le proprie<br />
valutazioni personali sul “ciò che si è” e non sul “ciò che si ha”.<br />
Puntare su una citta<strong>di</strong>nanza attiva, dando la possibilità ai giovani e agli adulti<br />
<strong>di</strong> partecipare con le loro idee e iniziative, può aiutare anche sul fronte <strong>di</strong> certe<br />
problematiche sociali, poiché si riescono a costruire relazioni forti legate da un<br />
obiettivo comune su cui lavorare, ognuno comprende il rapporto positivo che<br />
può dare alla propria comunità e l’importanza che possono avere le sue azioni,<br />
si formano personalità responsabili e consapevoli della loro forza e non<br />
in<strong>di</strong>vidui insicuri, incapaci <strong>di</strong> intervenire e reagire ai primi ostacoli.<br />
La complessità che è insita nell’educazione alla sostenibilità, ma che riguarda<br />
anche tutti gli altri settori educativi, sta nel fatto che non è sufficiente<br />
informare sulle ripercussioni ambientali <strong>di</strong> un atteggiamento sbagliato per<br />
ottenere in risposta la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> un comportamento. Nel contesto <strong>Emilia</strong><br />
<strong>Romagna</strong> in cui ci troviamo, il settore politico regionale si interessa e si<br />
muove proponendo e promuovendo attività per la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> una<br />
consapevolezza ambientale, attività per lo più informativa volta a<br />
sensibilizzare i citta<strong>di</strong>ni. Questo ha permesso sì, come si è visto anche dalla<br />
ricerca “Educazione ambientale 10+” svolta nelle scuole, lo sviluppo <strong>di</strong> una<br />
sensibilità ed una conoscenza <strong>di</strong>ffusa sui fenomeni ambientali esistenti, come<br />
ad esempio conoscenze <strong>di</strong> tipo ecologico, ma si nota comunque una continuità<br />
ad assumere comportamenti e abitu<strong>di</strong>ni che vanno in opposizione a quanto si<br />
77
pensa. Non si è ancora compreso bene e non è ancora <strong>di</strong>ffusa la<br />
consapevolezza sul “come fare” nell’effettivo, con i propri comportamenti, ma<br />
anche atteggiamenti, ad essere dalla parte dell’ambiente, e aggiungerei anche<br />
dalla parte del sociale se si pensa all’ambito del sistema <strong>di</strong> produzione in atto<br />
nella nostra società consumistica.<br />
Nel tentativo <strong>di</strong> mostrare un quadro generale su quello che siamo noi oggi nel<br />
rapporto con l’ambiente, potrei <strong>di</strong>re che:<br />
«siamo sensibilizzati, vogliamo partecipare, vogliamo<br />
intervenire sulle tematiche ambientali, ma il nostro stile <strong>di</strong><br />
vita è completamente <strong>di</strong>verso e non è orientato verso la<br />
sostenibilità. I giovani sanno che cos’è lo sviluppo<br />
sostenibile, conoscono i comportamenti corretti e il<br />
risparmio delle risorse, desiderano tuttavia la <strong>di</strong>scoteca, il<br />
centro commerciale, i gran<strong>di</strong> magazzini…» (Bonfanti,<br />
2009: p. 117)<br />
Per cambiare abitu<strong>di</strong>ni e stili <strong>di</strong> vita non basta trasmettere informazioni e<br />
sensibilizzare, occorre trasmettere nell’effettivo un modello comportamentale<br />
possibile da seguire e imitare. La coerenza non deve essere solamente<br />
pre<strong>di</strong>cata, ma anche e soprattutto praticata. Le giovani generazioni come<br />
possono assumere comportamenti sostenibili se gli adulti della società, sono i<br />
primi che non si sforzano <strong>di</strong> dare un concreto esempio <strong>di</strong> come si può essere<br />
effettivamente responsabili verso l’ambiente, responsabili nelle proprie scelte,<br />
responsabili verso il sistema sociale. Io noto in questa società <strong>di</strong> oggi sì un<br />
forte in<strong>di</strong>vidualismo e per<strong>di</strong>ta d’identità delle nuove generazioni, ma<br />
soprattutto una forte ipocrisia in quelle adulte, che sono convinte <strong>di</strong> essere<br />
nella posizione <strong>di</strong> poter ormai solamente trasmettere a voce il modo giusto per<br />
comportarsi lasciando ai giovani il compito <strong>di</strong> rispondere alle problematiche,<br />
creando da soli un nuovo modo d’essere. Questa a mio parere non è per nulla<br />
78
una società educante, questa è una società che scarica sulle spalle dei giovani<br />
responsabilità e compiti che non gli appartengono, o meglio, gli appartengono<br />
solo in quella forma <strong>di</strong> collaborazione tra loro ed il mondo adulto. Se<br />
quest’ultimo desse una vera e concreta risposta al settore ambientale e nel<br />
modo <strong>di</strong> vivere con sostenibilità le nuove generazioni non potrebbero fare<br />
altro che seguire tale esempio, sia buone pratiche sociali che ambientali.<br />
Nella progettazione futura degli interventi educativi è necessario che emerga,<br />
con maggiore forza, la volontà <strong>di</strong> formare anche gli adulti sui temi della<br />
sostenibilità; questi possono <strong>di</strong>ventare un sostegno per l’educazione<br />
ambientale e accompagnare le nuove generazioni nella loro crescita.<br />
4.3 Educazione Degli Adulti<br />
Ciò che pensano i giovani è strettamente legato a ciò che pensiamo e facciamo<br />
noi adulti. L’educazione sostenibile è una sfida ed è per questo che dobbiamo<br />
cercare <strong>di</strong> trovare dei mo<strong>di</strong> per cambiare la realtà, cioè noi stessi. In un’era <strong>di</strong><br />
comunicazione <strong>di</strong> massa si può <strong>di</strong>re che il contesto socio-culturale influenzi le<br />
persone e i loro valori più dei programmi educativi formali.<br />
Nel corso <strong>di</strong> questa ricerca ho voluto verificare se erano state pensate,<br />
all’interno dei progetti, modalità con cui poter coinvolgere e far partecipare i<br />
genitori o le famiglie dei bambini e ragazzi. Sono rimasta piacevolmente<br />
colpita dal risultato emerso, la maggior parte dei progetti ha infatti inserito<br />
azioni volte a questo fine utilizzando un approccio educativo o<br />
comunicativo/informativo. Considerando questo, vorrei fare una nota <strong>di</strong><br />
merito, in quanto esempio <strong>di</strong> risorsa possibile da attuare, per quelli che hanno<br />
utilizzato e riflettuto soprattutto riguardo un’azione educativa verso le<br />
famiglie, ma anche verso docenti e personale ATA, comprendendo così il<br />
mondo adulto nell’attività, in quanto anche essi possibili citta<strong>di</strong>ni attivi<br />
consapevoli.<br />
79
Per la formazione <strong>di</strong> una società sostenibile, infatti, ritengo che non basti<br />
in<strong>di</strong>rizzare l’azione educativa su questo tema esclusivamente alle giovani<br />
generazioni. Per quanto tale attività sia importante e in<strong>di</strong>spensabile, occorre<br />
mantenere presente che un soggetto non riceve educazione solamente dalla<br />
scuola, ma anche e soprattutto dalla società <strong>di</strong> cui fa parte. Come <strong>di</strong>ce un<br />
proverbio africano “per educare un bambino ci vuole un villaggio”; se<br />
quin<strong>di</strong> ci si prospetta con la nostra attività educativa <strong>di</strong> promuovere e formare<br />
una citta<strong>di</strong>nanza attiva è opportuno considerare che è importante portare in<br />
essere una società ricca <strong>di</strong> buone pratiche e coerente con ciò che insegna:<br />
bisogna trasformare la società attuale in una “società educante”.<br />
Quando si parla <strong>di</strong> “formare” una società però bisogna fare molta attenzione,<br />
poiché sembra quasi che questa non possa mo<strong>di</strong>ficarsi, che gli adulti che la<br />
compongono non possano essere “ri-formati” e “ri-educati”, e che dunque<br />
occorra attendere la crescita delle nuove generazioni, le uniche ad essere<br />
educate più responsabilmente, in maniera più sostenibile, pronte a cambiare le<br />
cose sbagliate e a dare forma nuova alla realtà. Questo significa però far<br />
pesare le responsabilità solamente ai ragazzi e rimandare i cambiamenti<br />
urgenti a un altro tempo, alle prossime generazioni <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni, amministratori,<br />
impren<strong>di</strong>tori.<br />
È risolutivo per poter considerare un intervento educativo pedagogicamente<br />
fondato l’utilizzo del concetto <strong>di</strong> sistematicità.<br />
Riprendendo un pensiero <strong>di</strong> Bertolini, la sistematicità è la nostra <strong>di</strong>rezione<br />
intenzionale originaria, essa «è l’esito <strong>di</strong> una lettura <strong>di</strong> “senso” che possiede<br />
proprio la nozione <strong>di</strong> complessità», cioè considera le tante “variabili” che vi<br />
sono nell’esperienza educativa (Bertolini, 2002).<br />
Un evento educativo possiede sempre il carattere <strong>di</strong> storicità, ed è questo che<br />
deve far considerare sempre, a chi progetta e chi educa, l’elemento <strong>di</strong><br />
irreversibilità (il non poter tornare in<strong>di</strong>etro), implicito nell’esperienza.<br />
Per poter, dunque, realizzare un intervento educativo pedagogicamente<br />
fondato, non guidato semplicemente dalla casualità, ma sempre cosciente e<br />
80
esponsabile, è importante compiere un’analisi della situazione. Questo deve<br />
essere fatto utilizzando il concetto <strong>di</strong> sistematicità, valutando la complessità<br />
dell’esperienza formativa, mantenendo costante la consapevolezza delle<br />
variabili presenti: culturali, soggettive, strumentali e oggettive; queste sono<br />
sempre e comunque in continua influenza reciproca (Bertolini, 2002). Tale<br />
prospettiva acquista la sua importanza, poiché si propone <strong>di</strong> considerare tutto<br />
ciò che con<strong>di</strong>zionerà la nostra azione educativa; più si tende verso<br />
l’osservazione e la valutazione situazionale durante la fase iniziale <strong>di</strong><br />
progettazione, più si ridurrà il margine d’errore/<strong>di</strong> rischio. Educatore e<br />
educando si ritrovano nella loro esperienza relazionale in questo contesto; esso<br />
lo si può osservare come un sistema, composta da variabili <strong>di</strong>verse in costante<br />
relazione e reciproco con<strong>di</strong>zionamento, ed ognuna <strong>di</strong> queste va tenuta in<br />
considerazione e analizzata non isolatamente, poiché non è possibile, ma<br />
sempre come elemento inserito in un sistema unico e inscin<strong>di</strong>bile.<br />
È opportuno interrogarsi se l’azione educativa proveniente dalla scuola sia<br />
sufficiente per arrivare nel concreto a questa sfida del cambiamento dei<br />
comportamenti. Ritengo purtroppo che non basti, se lo fosse tutto sarebbe più<br />
semplice; nella realtà, i messaggi esterni alla scuola, dati dunque dalla società<br />
e i suoi me<strong>di</strong>a, sono più forti <strong>di</strong> quelli da essa veicolati e chi educa deve<br />
comprendere e mantenere costantemente in considerazione questo fatto. Si<br />
rifletta, per esempio, sul motivo per cui l’educazione ambientale ha una buona<br />
influenza nella scuola primaria, dove si sviluppano <strong>di</strong>verse attività su questo<br />
tema, ma poi i risultati ottenuti da queste regre<strong>di</strong>scono, poiché negli anni<br />
scolastici successivi non vengono più proposte ai ragazzi, anzi una <strong>di</strong>dattica<br />
laboratoriale scompare (Grassi, 2009). Sembra però che le cose stiano<br />
cambiando: nei risultati della mia ricerca è emerso una significativa attenzione<br />
nel promuovere attività <strong>di</strong> educazione alla sostenibilità proprio su questa fascia<br />
d’età, nella scuola secondaria <strong>di</strong> primo grado. Questo cambiamento è<br />
importante poiché bisogna promuovere una continuità educativa riguardante<br />
81
questi temi, che permetta <strong>di</strong> mantenere e consolidare sensibilità e<br />
consapevolezza emerse durante la scuola primaria. Se il contesto <strong>di</strong> vita è<br />
contrad<strong>di</strong>torio i giovani quando cominciano a capire come vanno le cose nella<br />
società attorno a loro, si chiedono: ma chi me lo fa fare? «Noi educatori,<br />
insegnanti, dobbiamo fare i conti con una società che, soprattutto in una fascia<br />
<strong>di</strong> età in cui i ragazzi cominciano a sperimentare l’autonomia, li spinge verso<br />
un consumismo esasperato» (Bertolini, 2009, p. 148).<br />
Diventa importante fare un ragionamento rispetto alla famiglia, che è uno dei<br />
luoghi <strong>di</strong> maggior produzione <strong>di</strong> esperienza concreta <strong>di</strong> attenzione<br />
all’ambiente. È per questo che occorre assolutamente sforzarsi e lavorare in<br />
maniera significativa sugli adulti, cercando <strong>di</strong> portarli ad essere esempio <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>ni partecipi e responsabili.<br />
In <strong>Regione</strong> vi è la presenza <strong>di</strong> “centri accre<strong>di</strong>tati” per fornire le garanzie<br />
necessarie a un’azione formativa non solo per i giovani, ma anche per gli<br />
adulti. Una delle problematiche legata alla loro educazione sta nel fatto che i<br />
centri a questa de<strong>di</strong>cati potrebbero essere luoghi competenti dove l’educazione<br />
ambientale può mantenere e aggiornare il livello conoscitivo come anche<br />
realizzare modalità partecipative, finalizzate ad affrontare i problemi del<br />
territorio e pervenire a decisioni appunto partecipate. «Un centro che lavora<br />
sulla formazione dell’età adulta è un buon punto <strong>di</strong> riferimento sia per i CEA<br />
sia per le istituzioni locali e le agenzie formative territoriali in genere»<br />
(Sacchi, 2009: p.145). Sarà proposta e approfon<strong>di</strong>ta in seguito una possibile<br />
iniziativa nuova che comprenda l’educazione agli adulti.<br />
4.4 Scuola e Politiche<br />
Parlando delle responsabilità degli adulti non si può non riflettere sulle azioni<br />
da compiere in campo amministrativo e politico.<br />
Un'educazione senza un contesto adeguato, senza politiche a lei convergenti, è<br />
un lavoro impossibile e inutile. Non può fare tutto la scuola: ci si può<br />
82
domandare però come questa possa muoversi per creare forme <strong>di</strong><br />
collaborazioni. Per cominciare, come poi sta effettivamente accadendo nel<br />
contesto regionale, una scuola che sente i problemi del territorio può stimolare<br />
negli allievi un forte senso <strong>di</strong> appartenenza, <strong>di</strong> attaccamento e <strong>di</strong><br />
responsabilità; ma per riuscire in questo c’è bisogno <strong>di</strong> un Sistema Formativo<br />
Integrato forte e funzionale.<br />
Si provi ad immaginare una realtà in cui politica, citta<strong>di</strong>nanza, educazione e<br />
informazione possano collaborare, coor<strong>di</strong>narsi e integrarsi.<br />
Mancano in Italia elaborazioni e in<strong>di</strong>cazioni istituzionali che conferiscano alla<br />
sostenibilità una <strong>di</strong>gnità culturale, il caso <strong>di</strong> alcune regioni come l’<strong>Emilia</strong><br />
<strong>Romagna</strong> è positivo, ma non riguarda il paese intero: si vede dunque<br />
maggiormente il reale risultato che si ottiene in seguito ad un'azione politica<br />
(regionale) attenta e consapevole.<br />
Alla luce dei risultati emersi dalla mia ricerca e lettura dei se<strong>di</strong>ci progetti<br />
vincitori al Bando Infea 2010, si può affermare che all’interno del contesto<br />
regionale è viva e presente una consapevolezza per quanto riguarda i<br />
cambiamenti che si devono verificare all’interno delle Istituzioni scolastiche, e<br />
non solo, per sviluppare e portare avanti un’educazione sostenibile. I fattori<br />
che mi portano a <strong>di</strong>re questo sono <strong>di</strong>versi.<br />
Per prima cosa si è visto nel riportare i <strong>di</strong>versi programmi triennali Infea, la<br />
preparazione che è stata fatta in questi anni <strong>di</strong> un contesto regionale fertile e<br />
ricco <strong>di</strong> risorse per portare avanti e sviluppare sempre più esperienze <strong>di</strong><br />
educazione alla sostenibilità tramite l’affermazione dei CEA e delle Scuole<br />
laboratorio, che si sono sviluppate soprattutto grazie ai fon<strong>di</strong> che hanno<br />
ricevuto, i quali hanno permesso la realizzazione <strong>di</strong> progetti e pratiche. Queste<br />
hanno reso possibile “il fare esperienza” e migliorare sempre più le buone<br />
pratiche comprendendo e analizzando, <strong>di</strong> volta in volta, gli errori o le<br />
possibilità e risorse presenti.<br />
83
Come afferma anche Pierluigi Bonfanti, valutando l’investimento che la<br />
<strong>Regione</strong> ha destinato al settore educativo e la qualità del lavoro svolto negli<br />
ultimi <strong>di</strong>eci anni, l’<strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> si trova al massimo livello.<br />
«La <strong>Regione</strong> ha a <strong>di</strong>sposizione una rete educativa notevole<br />
per ampiezza e articolazione, considerando tutti i centri <strong>di</strong><br />
esperienza, per accedere a una nuova e più incisiva fase<br />
con tutti i presupposti sicuramente positivi». In tale realtà<br />
si creano «le con<strong>di</strong>zioni più favorevoli per l’affermazione e<br />
il consolidamento <strong>di</strong> un’educazione ambientale rivolta<br />
all’intervento e alla ricerca <strong>di</strong> soluzioni per uno sviluppo<br />
realmente sostenibile» (Bonfanti, 2009: p. 115).<br />
Si è visto come oggi con l’ultimo Programma triennale 2008-10, l’In.F.E.A.<br />
regionale è arrivata a concentrare la sua attenzione e le sue risorse economiche<br />
sulle Istituzioni scolastiche e a spingere queste nel comprendere l’importanza<br />
del lavoro in rete con gli enti presenti nel territorio ed il loro adeguamento per<br />
rispondere alle pratiche <strong>di</strong> Agenda 21 scolastica.<br />
Nel caso specifico del Bando In.F.E.A. 2010 <strong>di</strong> cui ho trattato e analizzato con<br />
la mia lettura dei progetti, si è in particolar modo cercato <strong>di</strong> incentivare le<br />
scuole, ma soprattutto aiutarle attraverso dei finanziamenti regionali, per la<br />
revisione degli spazi educativi in un’ottica sostenibile, proprio per<br />
sensibilizzarle a trasformarsi in istituzioni sostenibili. Se si concepisce lo<br />
spazio come elemento imprescin<strong>di</strong>bile dell’accadere educativo, che aiuta<br />
anche nel qualificare l’esperienza, allora esso deve essere pensato e strutturato<br />
secondo intenzionalità pedagogiche. Per educare le giovani generazioni fin<br />
dalla più piccola età, per fargli introiettare e assorbire un senso <strong>di</strong> sostenibilità<br />
possibile e piacevole alimentata dall’amore per l’ambiente, è in<strong>di</strong>spensabile<br />
una riflessione sullo spazio educativo e far in modo che questo possa<br />
84
trasformarsi in spazio vissuto, sia in<strong>di</strong>vidualmente ma anche collettivamente. I<br />
luoghi educativi svolgono un ruolo fondamentale per sottoporre l’ambiente,<br />
inteso non solo come ambiente naturale ma anche come spazio <strong>di</strong> relazioni e<br />
incontri, ad una trasformazione culturale e sociale in un tempo in cui<br />
sembrano state <strong>di</strong>menticate le pratiche collettive in grado <strong>di</strong> rendere i luoghi<br />
comuni in luoghi con<strong>di</strong>visi, personali, simbolici.<br />
Considerando anche le esperienze che in questi anni sono state promosse dal<br />
Sistema Infea regionale, emerge come queste hanno voluto valorizzare,<br />
stimolare e riqualificare quelle attività realizzate da <strong>di</strong>versi enti e associazioni<br />
sensibili riguardo tematiche dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Si è<br />
dunque andata a creare, come si è detto in precedenza, «un originale<br />
laboratorio <strong>di</strong> cooperazione tra istituzioni politiche e formative, ricerca e<br />
associazionismo» (DGR N°1217/2008).<br />
E’ proprio questo il “terreno fertile” che ho citato prima, <strong>di</strong>mostrazione<br />
dell’importanza <strong>di</strong> un'attività politica partecipe, pronto per fare spazio ad<br />
esperienze significative che <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> ogni mezzo, istituzionale, politico e<br />
locale, grazie alle varie competenze che interagiscono e vengono messe in atto<br />
per lo stesso fine sostenibile ed educativo. Nel contesto regionale si è andato a<br />
consolidare un Sistema Formativo Integrato ricco <strong>di</strong> esperienze.<br />
Se prima le esperienze in campo ambientale partivano da singoli enti o singole<br />
associazioni e potevano riuscire ad avere un impatto poco incisivo sull’intera<br />
comunità (essendo progettazioni occasionali), oggi si è formata quella sinergia<br />
tra i <strong>di</strong>versi soggetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse competenze e <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi contesti formativi<br />
(Università, politiche regionali, enti locali), soprattutto considerando il settore<br />
scuola e la collaborazione che questa crea con il territorio per giungere ad un<br />
fine educativo, che ci si può auspicare una vera e propria <strong>di</strong>ffusione della<br />
consapevolezza ambientale e <strong>di</strong> un'educazione sostenibile nella pratica.<br />
Per fare in modo che un’educazione alla sostenibilità riesca a giungere agli<br />
obiettivi che ci si è prefissati a livello internazionale, nazionale e locale, è<br />
necessaria la collaborazione tra <strong>di</strong>versi fattori, al fine che non si <strong>di</strong>mostri vano<br />
85
ogni tentativo <strong>di</strong> cambiamento, come: politiche, i politici, i tecnici dell’ambito,<br />
le organizzazioni, le strutture e le procedure. Se uno <strong>di</strong> questi contrasta e<br />
contrad<strong>di</strong>ce con quanto si <strong>di</strong>chiara e si insegna attraverso l’educazione, il<br />
prodotto finale ambiente/sostenibilità/citta<strong>di</strong>nanza attiva <strong>di</strong>minuisce poiché<br />
<strong>di</strong>minuisce la fiducia nell’istituzione, <strong>di</strong>minuisce quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> conseguenza la<br />
<strong>di</strong>sponibilità a collaborare, a partecipare; questa mancanza <strong>di</strong> fiducia e<br />
partecipazione induce ad un <strong>di</strong>stacco tra istituzioni e citta<strong>di</strong>ni, che incrementa<br />
ancora <strong>di</strong> più la sfiducia.<br />
Non dobbiamo <strong>di</strong>menticare che le cose cominceranno a cambiare realmente il<br />
giorno in cui i governi si muoveranno tutti insieme con azioni concrete volte a<br />
fare qualcosa per <strong>di</strong>minuire il riscaldamento globale e l’impatto ambientale in<br />
tutti i suoi aspetti. I governi negli ultimi venti anni hanno continuato a<br />
cambiare ed ognuno ha perdurato nel fare i suoi interessi senza assumersi la<br />
responsabilità <strong>di</strong> spingere ad un cambiamento che rendesse possibile l’arresto<br />
della crisi climatica. Ma questa consapevolezza non ci deve bloccare e far<br />
pensare che ogni nostra azione sia inutile in quanto ognuno <strong>di</strong> noi non si deve<br />
considerare una semplice goccia nel mare, senza possibilità <strong>di</strong> incidere, ma<br />
una parte <strong>di</strong> esso che contribuisce a creare una quantità…<br />
E la quantità ha il potere <strong>di</strong> incidere e <strong>di</strong> contribuire al cambiamento.<br />
4.5 Proposta per una Progettazione Futura<br />
In queste pagine ho ripetuto spesso la parola “complessità” e, nella mia parte<br />
conclusiva, vorrei cercare <strong>di</strong> proporre le mie idee a riguardo, per cercare <strong>di</strong><br />
fornire spunti utili ai fini <strong>di</strong> trovare soluzioni nuove ed incisive in questo<br />
settore educativo ormai inconfutabile dell’educazione alla sostenibilità.<br />
Si è affrontata la tematica degli adulti e <strong>di</strong> quanto i loro stili <strong>di</strong> vita influenzino<br />
i ragazzi nella loro formazione identitaria. Dunque si è riflettuto su quanto sia<br />
importante introdurre e creare iniziative volte ad educare, e trasformare,<br />
famiglie e genitori al fine <strong>di</strong> poter rendere consolidate attività che sono svolte<br />
86
nelle Istituzioni scolastiche da bambini e ragazzi, invece <strong>di</strong> contrastarla con<br />
abitu<strong>di</strong>ni sbagliate. Pensando a quanto i genitori incidono sulla formazione dei<br />
propri figli, ho riflettuto anche sul fatto <strong>di</strong> quanto spesso un figlio sia in grado,<br />
il più delle volte in modo inconsapevole, <strong>di</strong> cambiare e far crescere una<br />
persona. Fino ad oggi si sono portati avanti progetti nel mondo della scuola ai<br />
fini <strong>di</strong> responsabilizzare i bambini ed i ragazzi nei confronti del proprio<br />
territorio e della propria società; si è pensato per questo anche a come poter<br />
educare gli adulti per poterli far <strong>di</strong>ventare collaboratori della scuola nell’atto<br />
educativo.<br />
Io credo che vada incluso un elemento importante, che può aiutare a dare il via<br />
ad un processo ricco <strong>di</strong> possibilità: responsabilizziamo i ragazzi ad educare i<br />
propri genitori, a <strong>di</strong>ventare sponsor <strong>di</strong> buone pratiche e a pretenderle.<br />
Mostriamo loro che non devono cambiare da soli il mondo, ma che devono<br />
spingere le proprie famiglie affinché si apprenda l’importanza delle proprie<br />
decisioni e delle proprie abitu<strong>di</strong>ni a livello ambientale e sociale. Insegniamo a<br />
scuola ad educare i “gran<strong>di</strong>”, a trasmettere e pretendere tutti i comportamenti<br />
eco-sostenibili.<br />
Per realizzare questo sarebbe utile nelle prossime iniziative promuovere lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> progetti che richiedano attività da parte dei ragazzi nei confronti<br />
delle famiglie: si potrebbe richiedere loro <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are e analizzare gli stili <strong>di</strong><br />
vita dei propri genitori, <strong>di</strong> trovare i <strong>di</strong>fetti anti ecologici nella loro quoti<strong>di</strong>anità;<br />
<strong>di</strong> riflettere insieme in laboratori <strong>di</strong> gruppo sulle abitu<strong>di</strong>ni sbagliate più<br />
frequenti e <strong>di</strong> proporre soluzioni alternative sostenibili proprio agli adulti loro<br />
vicini. Tutto questo si può realizzare se la scuola sostiene questo processo<br />
d’analisi e trasmette ai ragazzi gli strumenti necessari, ai fini <strong>di</strong> formare gli<br />
adulti <strong>di</strong> oggi proiettati verso il futuro.<br />
La complessità <strong>di</strong> riflettere su un’educazione appropriata del mondo dei<br />
“gran<strong>di</strong>” sta proprio nel fatto che è <strong>di</strong>fficile inserire delle iniziative, sia<br />
comunicative che educative, all’interno della loro quoti<strong>di</strong>anità poiché, come si<br />
è visto anche nei progetti che ho esaminato nel mio percorso, sono emerse sì<br />
87
attività pensate anche per i genitori, ma sempre e comunque facoltative, a<br />
<strong>di</strong>screzione quin<strong>di</strong> delle famiglie e della loro <strong>di</strong>sponibilità a collaborare a certe<br />
tematiche. Pensare, invece, a un progetto che ingloba il mondo adulto<br />
nell’attività dei ragazzi, ritengo sia una scelta propositiva per cercare <strong>di</strong> far<br />
comprendere anche ai genitori che oggi l’educazione esige anche da parte loro<br />
l’acquisizione <strong>di</strong> una nuova consapevolezza. Purtroppo vi è il pregiu<strong>di</strong>zio che<br />
la scuola sia un “parcheggio”, dove si lasciano i propri figli per un periodo<br />
della giornata, e con cui si interagisce solo nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> u<strong>di</strong>enza da parte<br />
dell’istituzione stessa, che informa sulle valutazioni raccolte sugli<br />
alunni/studenti; un luogo dunque che a loro non appartiene più. Oltre a questo<br />
si aggiunge l’idea, ancora più grave, che qualsiasi atteggiamento o<br />
comportamento negativo assunto dai bambini/ragazzi, sia dato dal mal<br />
funzionamento della scuola e dell’insegnamento, senza quin<strong>di</strong> domandarsi su<br />
possibili mancate attenzioni proprie nei confronti dei figli. Rendendo i ragazzi<br />
dei formatori alla sostenibilità, volendo o nolendo, potremmo riuscire a far<br />
tornare le generazioni adulte sui banchi <strong>di</strong> scuola, grazie ad un insegnamento<br />
continuativo proprio durante tutti i momenti <strong>di</strong> attività familiare comune. Il far<br />
fare un lavoro d’analisi sul proprio ambiente <strong>di</strong> casa ai ragazzi, darebbe ai<br />
genitori l’opportunità <strong>di</strong> guardare le proprie abitu<strong>di</strong>ni e loro stessi attraverso<br />
gli occhi dei propri figli.<br />
Immaginiamo un progetto realizzato con questo fine: i giovani analizzano gli<br />
adulti, li mettono in <strong>di</strong>scussione, trovano modo <strong>di</strong> correggere lo stile <strong>di</strong> vita e<br />
<strong>di</strong> consumo della famiglia e <strong>di</strong> adeguarli alle loro esigenze future. Con questo<br />
si potrebbe provare a compiere quin<strong>di</strong> un'inversione <strong>di</strong> tendenza: passare, cioè,<br />
da educare gli adulti alla sostenibilità per far sì che la scuola riceva un aiuto da<br />
questi nell’educare le giovani generazioni ad uno sviluppo sostenibile; a<br />
spingere le giovani generazioni ad educare gli adulti a fargli cambiare le loro<br />
abitu<strong>di</strong>ni sbagliate in buone pratiche.<br />
Grazie a questo doppio sistema educativo, con cui viene affrontato lo stesso<br />
problema da due <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong>rezioni (dagli adulti ai ragazzi e viceversa), si<br />
88
può ottenere un aumento esponenziale <strong>di</strong> soggetti attivi ed educativi per la<br />
sostenibilità, avendo un enorme guadagno anche in termini temporali sulla<br />
<strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> una consapevolezza nuova e partecipe.<br />
89
Appen<strong>di</strong>ce<br />
Strumenti del mio lavoro<br />
Griglia 1 Principali tematiche affrontate dalle scuole<br />
NOME PROGETTO<br />
Rifiuti, risparmio<br />
energetico<br />
(comportamenti e<br />
consumi sostenibili)<br />
Bio<strong>di</strong>versità. Aree<br />
protette<br />
Territorio, storia e<br />
turismo sostenibile<br />
Sostenibilità e qualità<br />
ambientale urbana,<br />
mobilità sostenibile<br />
Qualità ambientale<br />
scolastica (e<strong>di</strong>ficio,<br />
relazioni..)<br />
Verde urbano e giar<strong>di</strong>ni<br />
scolastici<br />
Agenda 21 a scuola<br />
Impronta ecologica e<br />
in<strong>di</strong>catori ambientali<br />
Letteratura,<br />
intercultura, danza,<br />
pittura e ambiente<br />
Agricoltura,<br />
alimentazione e salute<br />
90
Griglia 2 Coinvolgimento <strong>di</strong> genitori o famiglie nel progetto<br />
Progetto<br />
Genitori / Famiglie<br />
Coinvolti (si/no)<br />
Griglia 3 Età dei soggetti coinvolti nelle attività<br />
Progetto Età dei soggetti<br />
Come<br />
Attività adattate in base<br />
all’età <strong>di</strong>versa dei soggetti<br />
(si/no, criticità/risorsa)<br />
Griglia 4 Educazione “sul”, “nel” o “per” l’ambiente<br />
Progetto Educazione<br />
“sull’ambiente”<br />
Educazione<br />
“nell’ambiente”<br />
Griglia 5 Area Informazione e Educazione ambientale<br />
Nome<br />
Progetti<br />
Area Informazione Ambientale<br />
a) Quali interlocutori<br />
b) Quali azioni<br />
Educazione<br />
“per l’ambiente”<br />
Area Educazione Ambientale<br />
a) Quali interlocutori<br />
b) Quali azioni<br />
91
Bibliografia<br />
Aa. Vv., (2005), L’Europa sostenibile ha bisogno <strong>di</strong> educazione.<br />
Bologna, Quaderni INFEA <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> 6, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> –<br />
<strong>Romagna</strong>.<br />
Angelini A. & Pizzuto P., (2007), Manuale <strong>di</strong> ecologia, sostenibilità ed<br />
educazione ambientale, Milano, FrancoAngeli.<br />
Bardulla E., (1998), Pedagogia ambiente società sostenibile, Roma,<br />
Anicia.<br />
Bateson G., (1990), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.<br />
Beccastrini S. & Cipparone M. (Ed.), (2005), Tutto è connesso. Voci,<br />
idee, esperienze per l’educazione, l’ambiente, la sostenibilità, Palermo,<br />
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome,<br />
Ministero dell’<strong>Ambiente</strong>, ARPA Sicilia.<br />
Bertolini P., (2002), L’esistere pedagogico : ragioni e limiti <strong>di</strong> una<br />
pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, Firenze, La<br />
Nuova Italia.<br />
Bertolini P, (2006), Per un lessico <strong>di</strong> pedagogia fenomenologica,<br />
Gardolo, Erickson.<br />
Bertolini S. (Ed.), (2005), Nuovi educatori ambientali/1, Il concorso dei<br />
saperi al Master in Educazione Ambientale, Bologna, Quaderni INFEA<br />
<strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> 3, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>.<br />
Bertolini S. (Ed.), (2005), Nuovi educatori ambientali/2, Esperienze<br />
seminariali nel Master in Educazione Ambientale, Bologna, Quaderni<br />
INFEA <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> 4, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>.<br />
Bertolini S., Una riflessione a più voci tra docenti e operatori. In<br />
Guerra L., Petazzini M., Tamburini P. (Ed), (2009), Educazione<br />
ambientale 10+ : cosa ne sanno e cosa sono <strong>di</strong>sposte a fare le giovani<br />
generazioni: il caso <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, Gardolo, Erickson.<br />
92
Bonfanti P., Un osservatore esterno valuta il sistema INFEA emiliano-<br />
romagnolo. In Guerra L., Petazzini M., Tamburini P. (Ed), (2009),<br />
Educazione ambientale 10+ : cosa ne sanno e cosa sono <strong>di</strong>sposte a fare<br />
le giovani generazioni: il caso <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, Gardolo, Erickson.<br />
Danisi A. (Ed.), (2005), Agenda 21. Formazione tra scienza ed etica<br />
per una società sostenibile, Bari, Villaggio Globale.<br />
Farné R., Pedagogia Verde: l’importanza della natura nella storia<br />
dell’educazione moderna e contemporanea. In Bertolini P., (1991),<br />
Pedagogia al passato-prossimo, Firenze, La Nuova Italia, pp.105-138.<br />
Goleman D., (2009), Intelligenza ecologica, Milano, Rizzoli.<br />
Grassi R., Le nuove identità sociali e culturali dei ragazzi e l’ambiente.<br />
In Guerra L., Petazzini M., Tamburini P. (Ed), (2009), Educazione<br />
ambientale 10+ : cosa ne sanno e cosa sono <strong>di</strong>sposte a fare le giovani<br />
generazioni: il caso <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, Gardolo, Erickson.<br />
Guerra L., Petazzini M., Tamburini P. (Ed), (2009), Educazione<br />
ambientale 10+ : cosa ne sanno e cosa sono <strong>di</strong>sposte a fare le giovani<br />
generazioni: il caso <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, Gardolo, Erickson.<br />
Iori V., (1996), Lo spazio vissuto : luoghi educativi e soggettivi,<br />
Firenze, La nuova Italia.<br />
Lipari D., (1995), Progettazione e valutazione nei processi formativi,<br />
Roma, Ed. Lavoro.<br />
Malavasi P., (2008), Pedagogia Verde. Educare tra ecologia<br />
dell’ambiente e ecologia umana, Brescia, La Scuola.<br />
Mayer M., Criteri <strong>di</strong> qualità per i centri <strong>di</strong> educazione ambientale. In<br />
Aa. Vv., (2005), L’Europa sostenibile ha bisogno <strong>di</strong> educazione,<br />
Bologna, Quaderni INFEA <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong> 6, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong> –<br />
<strong>Romagna</strong>.<br />
Morin E., (2000), La testa ben fatta: riforma dell'insegnamento e<br />
riforma del pensiero, Milano, R. Cortina.<br />
93
Mortari L., (1999), Natura e… : Esplorazione polifonica <strong>di</strong> un’idea,<br />
Milano, FrancoAngeli.<br />
Nora E., Sviluppo sostenibile, Agenda 21 locale e Piano <strong>di</strong> Azione<br />
Ambientale. In Bertolini S. (Ed.), (2005), Nuovi educatori ambientali/2,<br />
Esperienze seminariali nel Master in Educazione Ambientale, Bologna,<br />
Quaderni INFEA <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong> 4, <strong>Regione</strong> <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>.<br />
Report 1, (2009), I numeri dell’Educazione Ambientale: le risorse negli<br />
ultimi <strong>di</strong>eci anni in <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>. INFEA <strong>Emilia</strong> <strong>Romagna</strong>.<br />
Sacchi G. C., I saperi ambientali e i processi formativi. In Guerra L.,<br />
Petazzini M., Tamburini P. (Ed), (2009), Educazione ambientale 10+ :<br />
cosa ne sanno e cosa sono <strong>di</strong>sposte a fare le giovani generazioni: il<br />
caso <strong>Emilia</strong>-<strong>Romagna</strong>, Gardolo, Erickson.<br />
Soprano P., Nascita dell’INFEA e sua prima fase. Il ruolo delle<br />
politiche <strong>di</strong> Governo in questo settore. In Beccastrini S. & Cipparone<br />
M. (Ed.), (2005), Tutto è connesso. Voci, idee, esperienze per<br />
l’educazione, l’ambiente, la sostenibilità, Palermo, Conferenza dei<br />
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Ministero<br />
dell’<strong>Ambiente</strong>, ARPA Sicilia.<br />
Tamburini P., (2007), Dall’educazione ambientale all’educazione alla<br />
sostenibilità, Infanzia, 2007, Novembre, 451 – 456.<br />
Bando Infea 2010 (DGR N°683/2010): “bando per la concessione <strong>di</strong><br />
contributi a reti <strong>di</strong> istituti scolastici della regione dell’emilia romagna<br />
per progetti e azioni nel campo dell’educazione all’ambiente e alla<br />
sostenibilità - a.s. 2010/2011 - (L.R. 15/96)”.<br />
Legge Regionale del 29 <strong>di</strong>cembre 2009 n° 27: “Promozione,<br />
organizzazione e sviluppo delle attività d’informazione ed educazione<br />
alla sostenibilità” (L.R. 29 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 27).<br />
94
Delibera della Giunta Regionale n. 1217 del 28 luglio 2008:<br />
“Programma Regionale Di Informazione E Educazione Ambientale<br />
(Infea) 2008-10” (DGR N°1217/2008).<br />
Sitografia<br />
1. http://www.moodle.unibo.it/course/view.php?id=196<br />
2. http://www.ermesambiente.it/wcm/infea/news/2010/05maggio/BandoI<br />
NFEAscuole.htm<br />
3. http://www.ermesambiente.it/wcm/infea/sezioni_laterali/chisiamo/stori<br />
a.htm<br />
4. http://www.educazionesostenibile.it/portale/leducazione-<br />
sostenibile.html<br />
5. http://www.arpa.fvg.it/ea/index.php?id=52<br />
6. http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/infea/progettoinfea.ht<br />
ml<br />
7. http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/infea/progettoinfea.ht<br />
ml<br />
8. http://www.crea.puglia.it/index.php<br />
9. http://www.scuolaer.it<br />
10. http://www.cadnet.marche.it/postprogrammando/2/<strong>di</strong>ritti%20naturali.ht<br />
m<br />
95