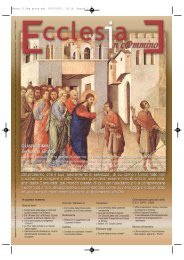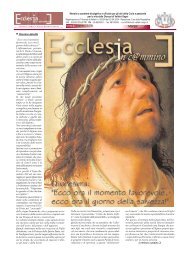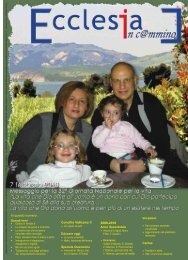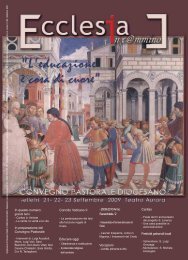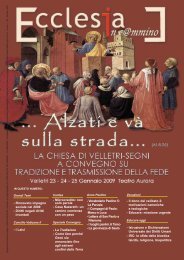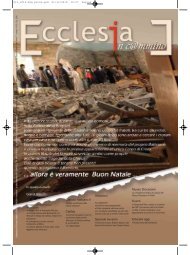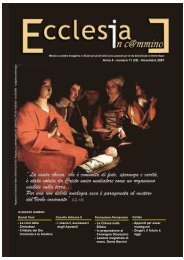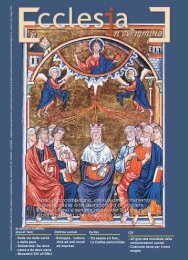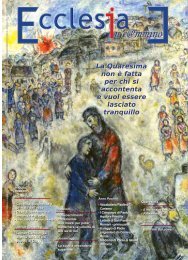giugno_13:Pag prova.qxd.qxd - Diocesi Velletri-Segni
giugno_13:Pag prova.qxd.qxd - Diocesi Velletri-Segni
giugno_13:Pag prova.qxd.qxd - Diocesi Velletri-Segni
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Giugno<br />
20<strong>13</strong><br />
7<br />
don Antonio Galati<br />
La Chiesa ha sempre conosciuto il<br />
sacramento della penitenza, anche se<br />
nel corso della storia questo ha conosciuto<br />
diverse forme di celebrazione. Ripercorrere<br />
brevemente lo sviluppo storico di questo sacramento<br />
permette di individuare quell’elemento che<br />
si è mantenuto costante nel corso dello sviluppo<br />
e che, quindi, permette di individuare il nucleo<br />
centrale di questo sacramento.<br />
La celebrazione penitenziale<br />
fino al VI secolo<br />
La forma della penitenza nella Chiesa antica era<br />
pubblica e irripetibile. Pubblica nel senso che<br />
il rito sacramentale avveniva davanti l’assemblea<br />
liturgica, con riti più o meno prestabiliti nel<br />
corso della storia: l’ingresso nel gruppo dei penitenti<br />
e l’imposizione della penitenza, stabiliti dal<br />
vescovo dopo un colloquio privato con il peccatore<br />
attraverso il quale confessava i propri peccati.<br />
L’ingresso nell’ordine dei penitenti era, di<br />
norma, un atto liturgico in cui il peccatore veniva<br />
messo fuori dalla comunità affinché si manifestasse<br />
a lui lo stato in cui si trovava già spiritualmente<br />
e perché la comunità pregasse per<br />
la sua conversione.<br />
Insieme con l’ingresso nell’ordine dei penitenti,<br />
il vescovo dava al penitente una penitenza<br />
che doveva soddisfare durante questo periodo<br />
che, in genere, consisteva in digiuni e pratiche<br />
di carità, comunque molto esigenti; la riconciliazione,<br />
che sancisce la fine del periodo penitenziale,<br />
in cui il vescovo impone le mani al penitente<br />
donandogli l’assoluzione e la riammissione<br />
piena all’interno della comunità.<br />
Da questo momento il riconciliato poteva partecipare,<br />
di nuovo, pienamente alla celebrazione<br />
eucaristica. Inoltre essa era irripetibile, cioè si<br />
poteva celebrare una sola volta nella vita.<br />
La celebrazione del sacramento<br />
della penitenza dopo il VI secolo<br />
Probabilmente in Gran Bretagna si inizia a sviluppare,<br />
a partire dal VI secolo, una nuova forma<br />
rituale del sacramento della penitenza, che<br />
diventa privata, reiterabile e tariffata.<br />
Riguardo alla sua celebrazione, tutto si svolgeva<br />
in privato:<br />
- il penitente si rivolgeva al confessore, che ordinariamente<br />
era un presbitero, e non più solo il<br />
vescovo, e si accusava dei suoi peccati, oppure<br />
rispondeva alle domande fatte dal confessore;<br />
- il confessore, ascoltata la penitenza, dava al<br />
penitente la penitenza (normalmente periodi di<br />
digiuno e pellegrinaggi) secondo delle tariffe prestabilite;<br />
- dopo che il penitente aveva assolto i suoi obblighi<br />
penitenziali ritornava dal sacerdote per ricevere<br />
l’assoluzione dai peccati.<br />
Rispetto alla penitenza antica, questa nuova forma<br />
mantiene, di quella antica, la durezza delle<br />
penitenze, per cui la somma delle penitenze<br />
per i peccati, spesso, superava l’aspettativa<br />
di vita del penitente.<br />
Per questo motivo si ammise la possibilità di<br />
commutare i lunghi periodi di penitenza “accumulati”<br />
con periodi più brevi, ma più intensi. Accanto<br />
a questo sorse anche la possibilità di sostituire<br />
le penitenze con il far celebrare un determinato<br />
numero di messe. Inoltre si affiancò la possibilità<br />
di far scontare le proprie penitenze a un<br />
numero di sostituti dividendo su di loro il periodo<br />
di tempo di penitenza del singolo penitente.<br />
Queste due ultime possibilità di assolvere<br />
il periodo penitenziale avvenivano sempre sotto<br />
compenso economico, il che fece sorgere degli<br />
abusi che videro la Chiesa obbligata a ritirare<br />
la forma della penitenza tariffata.<br />
Dal IX secolo circa convivevano, quindi, la forma<br />
della penitenza pubblica e quella privata che,<br />
dalla Gran Bretagna, si estese per tutta<br />
l’Europa. Inoltre, il forte impulso dell’espansione<br />
della forma privata e reiterabile della confessione<br />
portò presto, tutta la Chiesa, ad ammettere<br />
la reiterabilità del sacramento della penitenza.<br />
Infine, nel XII secolo, tutte le forme della<br />
penitenza si ridussero alla penitenza privata<br />
che assunse la struttura rituale che è in vigore<br />
ancora oggi, per cui il penitente si accusa<br />
dei suoi peccati e riceve la penitenza e, insieme<br />
con questa, l’assoluzione del sacerdote.<br />
La prassi della penitenza privata e auricolare<br />
(cioè di dire al sacerdote i propri peccati) non<br />
fu esente essa stessa da abusi, questa volta<br />
dovuti al forte peso dato dalla Chiesa al momento<br />
della confessione dei peccati. In alcuni periodi<br />
del medioevo, infatti, si sottolineò molto questo<br />
momento del sacramento della penitenza,<br />
che si pensava che fosse l’unico elemento necessario<br />
per ricevere il perdono. Ciò portò i penitenti,<br />
specie se in fin di vita, a confessare i propri<br />
peccati a chiunque, anche se non erano sacerdoti<br />
e, delle volte, anche a cose o ad animali,<br />
perché l’importante non era ricevere l’assoluzione,<br />
ma dire i peccati. Comunque, escludendo<br />
queste esagerazioni, che comunque rivelano la<br />
necessità per il cristiano di voler morire sapendo<br />
di essere stato riconciliato con Dio, a partire<br />
dal XII secolo l’attenzione della Chiesa non<br />
si pone più sul rito del sacramento, ormai stabilito<br />
e accettato, ma sulla sua teologia e sulle<br />
implicazioni dottrinali e pastorali.<br />
In conclusione<br />
Anche se molto velocemente, si è tentato di descrivere<br />
le due forme principali con cui questo sacramento<br />
veniva celebrato nella storia. Ciò che emerge<br />
è, sostanzialmente, l’importanza del ruolo del<br />
presbitero nell’ascoltare la confessione dei peccati<br />
e nel dare l’assoluzione, e nel compito del<br />
penitente di confessare a voce i propri peccati,<br />
elemento maggiormente sottolineato, e nel<br />
soddisfare la penitenza data dal sacerdote.<br />
Nell’immagine:<br />
La confessione, di Giuseppe Molteni<br />
segue da pag. 6<br />
gestanti assistite 72 e quello delle non gestanti 104 (in totale 60.000 assistite).<br />
Oltre il 3 per cento delle gravide ha potuto usufruire anche dell’ospitalità<br />
e dell’assistenza nelle Case-Famiglia del MpV. Tutti questi dati<br />
sono stati ricavati dalla relazione annua comparsa sul numero di maggio<br />
di “Sì alla Vita”, la bella rivista mensile del Movimento per la Vita, unica<br />
pubblicazione in Italia (e forse in Europa) che tratta con ampiezza, compiutezza<br />
di materiali e con specifica competenza la materia della difesa<br />
e della promozione della vita soprattutto al suo inizio e alla sua fine, sotto<br />
i vari profili: la cronaca, le scienze, il diritto, la politica, l’etica, la cultura,<br />
a livello nazionale, europeo e mondiale.<br />
La redazione di “Sì alla vita” è a Roma, presso la sede del<br />
Movimento per la Vita, in Lungotevere dei Vallati 2, cap 00186.<br />
Telefono 06.6831.1121, fax 06.686.5725;<br />
e-mail: siallavita@mpv.org.<br />
Abbonamento annuale € 18,00; sostenitore € 50,00.