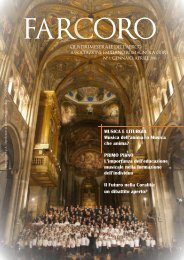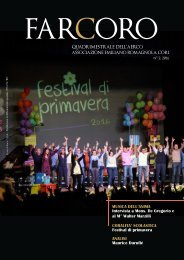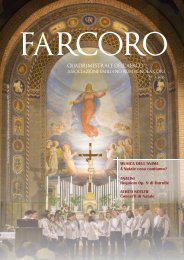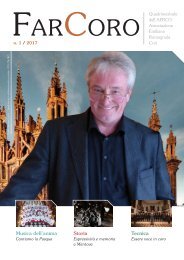e-FARCORO 2-2017
FARCORO è la Rivista Musicale di AERCO, l'Associazione Emiliano Romagnola Cori
FARCORO è la Rivista Musicale di AERCO, l'Associazione Emiliano Romagnola Cori
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
una strana sorta di snobismo in troppi non hanno il coraggio di ammetterlo, assai sovente<br />
quei tozzi volumi dalla copertina color lambrusco lasciano gli scaffali delle biblioteche<br />
per servire ai direttori più intransigenti, ai continuisti più ortodossi, al cantore più esperto<br />
nella prassi informata: un fenomeno che di certo non si fermerà in questo anno di festa,<br />
nonostante le auguste edizioni critiche confezionate nell’arco temporale tra Malipiero e<br />
noi.<br />
Non dimentichiamo poi che il componimento di Monteverdi è un ottimo esercizio di stile<br />
e in quanto tale è contenuto in qualche vecchia (ma sempre efficace) antologia corale:<br />
il madrigale e il mottetto insegnano a pronunciare, a respirare, a intonare come pochi<br />
riescono a fare; ecco quindi che diventa il pallino di un direttore o di qualche corista<br />
entusiasta, un po’ per i motivi che abbiamo già enunciato, un po’ perché è difficile e fa<br />
crescere. Si indica come brano d’obbligo a un concorso. Si registra per l’ennesima volta su<br />
CD.<br />
Ma il maestro cremonese, la cui produzione è totalmente consacrata alle voci, non<br />
pensava certo al coro nell’accezione a cui oggi siamo più abituati. Ai suoi tempi, nel suo<br />
periodo di attività un compositore della sua categoria doveva avere dimestichezza con<br />
una multiforme casistica dei gruppi vocali, variabili per luogo e situazione e soprattutto a<br />
seconda della funzione che gli si attribuiva. Egli ebbe la fortuna di lavorare in contingenze<br />
in cui la macchina a disposizione era efficiente, alquanto versatile e senz’altro di lusso;<br />
accanto a queste c’era sempre e comunque il coro più astratto, quello ideale: trasmesso<br />
dall’eredità dei maestri come prototipo assoluto di scrittura e poi immortalato su un<br />
foglio di carta dagli attrezzi del tipografo.<br />
Della produzione monteverdiana oggi conosciuta, il madrigale è entrato nel repertorio<br />
corale suo malgrado, ma a beneficio di una certa fruizione didattica e storiografica cui<br />
abbiamo già accennato. Perciò non è del tutto legittimo trattarne in queste righe, ma che<br />
un prodotto concepito ‘per pochi intimi’ si sia potuto estendere a una compagnia assai più<br />
nutrita sarebbe senz’altro un fatto degno di essere osservato nel suo percorso storico ed<br />
estetico. Non tutti i brani di questa forma si prestano a un simile uso, si noterà infatti che<br />
solitamente la scelta cade su una limitata casistica.<br />
Riproporre oggi un’immagine così circostanziata della produzione madrigalistica è però una<br />
professione di differenti valori, non soltanto legati alla rappresentazione di un contesto<br />
che, come quello mantovano, si avvaleva delle maestranze più acclamate del tempo. Il<br />
recupero di quel suono che è origine di ogni parola ci permette l’accesso a un gioco in<br />
cui molti sono i percorsi possibili e in cui ognuno di noi può soffermarsi a osservare la<br />
pianificazione strutturale delle voci, la resa mimetica di ogni affetto, o ancora confrontare<br />
le scelte dei diversi musici che hanno adottato le stesse linee. O semplicemente<br />
abbandonarsi a una ricezione incondizionata, dettata dalla semplice reazione emotiva.<br />
Non si distaccano da questa concezione formale gli interventi corali dell’Orfeo, che anche<br />
quando vi prevale l’andatura omoritmica sono autentici ‘calchi madrigaleschi’ 3 . Questi,<br />
sotto il peso del progetto narrativo si differenziano nel tessuto, nella scrittura, nelle scelte<br />
timbriche. Nella tragedia (che la sera di quel 24 febbraio 1607 si definiva ‘favola’) il coro è<br />
un’entità drammaturgica che ottempera a una regola antica: che sia intonato da spiriti o<br />
pastori, che costituisca un commento morale o un grido di compassione, esso è sempre<br />
l’elemento di mediazione fra noi e i personaggi della favola, che si assume il compito della<br />
suddivisione temporale del racconto, l’articolazione del dramma, il respiro della storia.<br />
Non cinque voci, ma una soltanto che si rifrange in cinque dimensioni.<br />
Durante il suo magistero mantovano, Claudio otterrà solo nel 1601 di estendere la<br />
propria autorità direttoriale dalle stanze di palazzo alla basilica di Santa Barbara. Assai<br />
probabilmente aveva già partecipato all’intonazione di messe, salmi e mottetti e condiviso<br />
una certa maniera gonzaghesca di concepire la musica devota che portava avanti un ideale<br />
sapientemente costruito dal duca Guglielmo, morto nel 1587. Guglielmo, oltre a ordinare<br />
3 Claudio Gallico, Monteverdi, Torino, Einaudi 1979, p. 65.<br />
‘Il maestro<br />
cremonese, la<br />
cui produzione<br />
è totalmente<br />
consacrata alle<br />
voci, non pensava<br />
certo al coro<br />
nell’accezione a<br />
cui oggi siamo più<br />
abituati’<br />
CLAUDIO MONTEVERDI E IL SUO VESPRO | 7