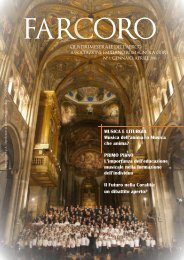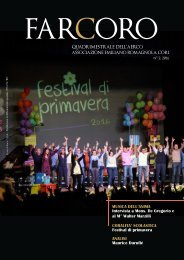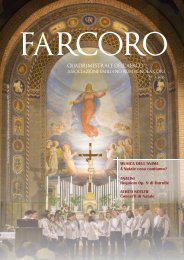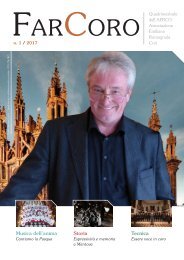e-FARCORO 2-2017
FARCORO è la Rivista Musicale di AERCO, l'Associazione Emiliano Romagnola Cori
FARCORO è la Rivista Musicale di AERCO, l'Associazione Emiliano Romagnola Cori
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
canto fermo di una litania d’uso mantovano.<br />
Questa pubblicazione rappresenta un punto di svolta nella<br />
carriera del compositore, tant’è che per molti studiosi è da<br />
intendersi quale parziale e sottile risposta alle invettive del<br />
teorico Giovanni Maria Artusi, che dieci anni prima aveva<br />
segnalato al mondo dei curiosi alcuni errori d’ortografia<br />
contenuti in diverse composizioni di Monteverdi 6 . Perché<br />
proprio qui, e non altrove? Ma soprattutto, perché in un<br />
diverso campo tematico rispetto a quello del madrigale?<br />
Monteverdi sceglie anzitutto di rappresentare un modello<br />
perfetto di scansione liturgica così come si articolava<br />
ai suoi tempi. Infatti, i Vespri si alternavano alla Messa<br />
secondo una ritmica successione chiamata a scandire<br />
il tempo di ogni uomo di fede: la liturgia eucaristica era<br />
anticipata, la sera precedente, dai Primi Vespri e seguita,<br />
la sera stessa, dai Secondi. Ed è in questa accezione che<br />
potremmo ricercare uno dei significati più affascinanti<br />
del termine funzione applicato alla cerimonia religiosa:<br />
derivato dal latino functio, rinvia a un adempimento, al<br />
compimento di un bisogno individuale o collettivo.<br />
Nella disposizione degli eventi essa non segue un<br />
ordine romano, né uno lombardo e nello stesso tempo<br />
potrebbe funzionare per entrambi, avendo il suo autore<br />
opportunamente organizzato le proprie idee al fine<br />
di lasciare un certo margine di adattabilità. Non sarà<br />
quindi azzardato considerare la presenza di più cori per<br />
un solo Vespro: quantomeno uno per il canto fermo,<br />
uno (ben nutrito) per quello figurato, uno per la ‘Litania’<br />
della Sonata, altri gruppi di pochi cantori per i mottetti.<br />
Questo dato, unitamente alle infinite variabili offerte<br />
dalle discipline legate alla prassi esecutiva, ci permette<br />
di formulare un bilancio di tutti i Vespri ascoltati fino a<br />
oggi: nessuno è (o mai sarà) uguale all’altro, ma nonostante<br />
questo saranno tutti veri e plausibili; e non parliamo<br />
semplicemente di interpretazione, bensì di ricomposizione<br />
liturgica, perché quello edito a stampa nel 1610 non è<br />
un Vespro verosimilmente conforme all’uso pratico, ma<br />
un iper-Vespro, un modello paradigmatico frutto di una<br />
conoscenza immensa, di una straordinaria immaginazione<br />
creativa.<br />
Il carattere più esaminato e contemplato dagli studiosi<br />
di questa raccolta è tuttavia offerto dalla perfetta<br />
compresenza di stile antico e stile moderno. Monteverdi,<br />
infatti, pare guardare continuamente sia avanti, sia indietro,<br />
tanto che a volte non è possibile sapere se stia adottando<br />
l’uno o l’altro atteggiamento. Inoltre, sembra guardare alle<br />
diverse tipologie di sonorizzazione che caratterizzano le<br />
maggiori lingue musicali del suo tempo, primo fra tutti<br />
quell’idioma veneziano che da lì a poco diventerà la<br />
sua nuova casa musicale. Una dimora ancora una volta<br />
6 Giovanni Maria Artusi, L’Artusi, overo delle imperfettioni della moderna<br />
musica, Venezia, Vincenti 1600.<br />
Claudio Monteverdi<br />
d’ambito esclusivo: la cappella privata del Doge, che<br />
Claudio dirigerà fino alla fine della sua vita, già da mezzo<br />
secolo aveva raggiunto una significativa espansione e<br />
quella disposizione di corpi sonori che la rendeva eccelsa<br />
in tutta Europa 7 .<br />
Solo da uno sguardo superficiale si potrebbe giudicare<br />
antica la Messa e moderno il Vespro: a pensarci bene si<br />
potrebbe affermare anche il contrario, già che la Messa è<br />
un perfetto esempio di ordinato esercizio polifonico posttridentino<br />
e il Vespro è pervaso di accenni alla tradizione<br />
più remota, alle leggi più imperturbabili del canto cristiano.<br />
Nelle studiate trame di questo monumento sonoro si<br />
affaccia, come ulteriore artificio narrativo, anche il silenzio.<br />
Monteverdi ne fa un uso funzionale e poeticamente<br />
diversificato: nella ricerca di particolari effetti di risonanza,<br />
nell’impiego quale figura retorica, come elemento del<br />
discorso ben distribuito nelle parti con il fine di far<br />
respirare ordinatamente ogni cantore coinvolto in questa<br />
festa. La prima raccolta di musica sacra di Monteverdi è<br />
dunque una musica che tende all’infinito, non solo in senso<br />
puramente spirituale, ma anche perché ci ha regalato e ci<br />
regalerà infinite possibilità di realizzazione.<br />
7 David Bryant, Una cappella musicale di stato: la Basilica di San<br />
Marco, in La cappella musicale nell’italia della controriforma, a cura<br />
di Oscar Mischiati e Paolo Russo, Firenze, Olschki 1993, pp. 67-74.<br />
CLAUDIO MONTEVERDI E IL SUO VESPRO | 9