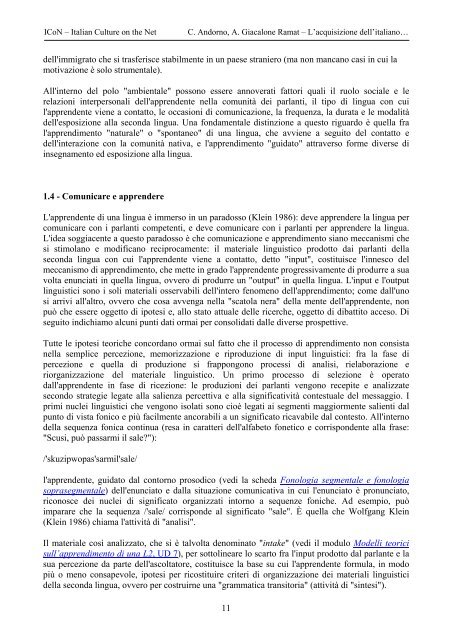L'acquisizione dell'italiano come lingua seconda - Master in ...
L'acquisizione dell'italiano come lingua seconda - Master in ...
L'acquisizione dell'italiano come lingua seconda - Master in ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ICoN – Italian Culture on the Net C. Andorno, A. Giacalone Ramat – L’acquisizione dell’italiano…<br />
dell'immigrato che si trasferisce stabilmente <strong>in</strong> un paese straniero (ma non mancano casi <strong>in</strong> cui la<br />
motivazione è solo strumentale).<br />
All'<strong>in</strong>terno del polo "ambientale" possono essere annoverati fattori quali il ruolo sociale e le<br />
relazioni <strong>in</strong>terpersonali dell'apprendente nella comunità dei parlanti, il tipo di <strong>l<strong>in</strong>gua</strong> con cui<br />
l'apprendente viene a contatto, le occasioni di comunicazione, la frequenza, la durata e le modalità<br />
dell'esposizione alla <strong>seconda</strong> <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>. Una fondamentale dist<strong>in</strong>zione a questo riguardo è quella fra<br />
l'apprendimento "naturale" o "spontaneo" di una <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>, che avviene a seguito del contatto e<br />
dell'<strong>in</strong>terazione con la comunità nativa, e l'apprendimento "guidato" attraverso forme diverse di<br />
<strong>in</strong>segnamento ed esposizione alla <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>.<br />
1.4 - Comunicare e apprendere<br />
L'apprendente di una <strong>l<strong>in</strong>gua</strong> è immerso <strong>in</strong> un paradosso (Kle<strong>in</strong> 1986): deve apprendere la <strong>l<strong>in</strong>gua</strong> per<br />
comunicare con i parlanti competenti, e deve comunicare con i parlanti per apprendere la <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>.<br />
L'idea soggiacente a questo paradosso è che comunicazione e apprendimento siano meccanismi che<br />
si stimolano e modificano reciprocamente: il materiale l<strong>in</strong>guistico prodotto dai parlanti della<br />
<strong>seconda</strong> <strong>l<strong>in</strong>gua</strong> con cui l'apprendente viene a contatto, detto "<strong>in</strong>put", costituisce l'<strong>in</strong>nesco del<br />
meccanismo di apprendimento, che mette <strong>in</strong> grado l'apprendente progressivamente di produrre a sua<br />
volta enunciati <strong>in</strong> quella <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>, ovvero di produrre un "output" <strong>in</strong> quella <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>. L'<strong>in</strong>put e l'output<br />
l<strong>in</strong>guistici sono i soli materiali osservabili dell'<strong>in</strong>tero fenomeno dell'apprendimento; <strong>come</strong> dall'uno<br />
si arrivi all'altro, ovvero che cosa avvenga nella "scatola nera" della mente dell'apprendente, non<br />
può che essere oggetto di ipotesi e, allo stato attuale delle ricerche, oggetto di dibattito acceso. Di<br />
seguito <strong>in</strong>dichiamo alcuni punti dati ormai per consolidati dalle diverse prospettive.<br />
Tutte le ipotesi teoriche concordano ormai sul fatto che il processo di apprendimento non consista<br />
nella semplice percezione, memorizzazione e riproduzione di <strong>in</strong>put l<strong>in</strong>guistici: fra la fase di<br />
percezione e quella di produzione si frappongono processi di analisi, rielaborazione e<br />
riorganizzazione del materiale l<strong>in</strong>guistico. Un primo processo di selezione è operato<br />
dall'apprendente <strong>in</strong> fase di ricezione: le produzioni dei parlanti vengono recepite e analizzate<br />
secondo strategie legate alla salienza percettiva e alla significatività contestuale del messaggio. I<br />
primi nuclei l<strong>in</strong>guistici che vengono isolati sono cioè legati ai segmenti maggiormente salienti dal<br />
punto di vista fonico e più facilmente ancorabili a un significato ricavabile dal contesto. All'<strong>in</strong>terno<br />
della sequenza fonica cont<strong>in</strong>ua (resa <strong>in</strong> caratteri dell'alfabeto fonetico e corrispondente alla frase:<br />
"Scusi, può passarmi il sale?"):<br />
/'skuzipwopas'sarmil'sale/<br />
l'apprendente, guidato dal contorno prosodico (vedi la scheda Fonologia segmentale e fonologia<br />
soprasegmentale) dell'enunciato e dalla situazione comunicativa <strong>in</strong> cui l'enunciato è pronunciato,<br />
riconosce dei nuclei di significato organizzati <strong>in</strong>torno a sequenze foniche. Ad esempio, può<br />
imparare che la sequenza /'sale/ corrisponde al significato "sale". È quella che Wolfgang Kle<strong>in</strong><br />
(Kle<strong>in</strong> 1986) chiama l'attività di "analisi".<br />
Il materiale così analizzato, che si è talvolta denom<strong>in</strong>ato "<strong>in</strong>take" (vedi il modulo Modelli teorici<br />
sull’apprendimento di una L2, UD 7), per sottol<strong>in</strong>eare lo scarto fra l'<strong>in</strong>put prodotto dal parlante e la<br />
sua percezione da parte dell'ascoltatore, costituisce la base su cui l'apprendente formula, <strong>in</strong> modo<br />
più o meno consapevole, ipotesi per ricostituire criteri di organizzazione dei materiali l<strong>in</strong>guistici<br />
della <strong>seconda</strong> <strong>l<strong>in</strong>gua</strong>, ovvero per costruirne una "grammatica transitoria" (attività di "s<strong>in</strong>tesi").<br />
11