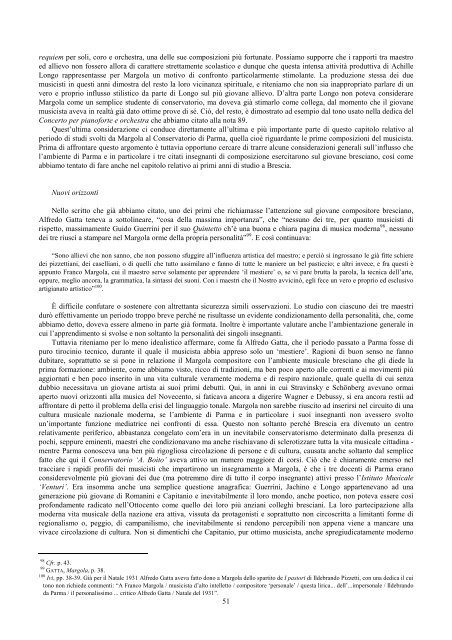Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
equiem per soli, coro e orchestra, una <strong>de</strong>lle sue composizioni più fortunate. Possiamo supporre che i rapporti tra maestro<br />
ed allievo non fossero allora <strong>di</strong> carattere strettamente scolastico e dunque che questa intensa attività produttiva <strong>di</strong> Achille<br />
Longo rappresentasse per Margola un motivo <strong>di</strong> confronto particolarmente stimolante. La produzione stessa <strong>de</strong>i due<br />
musicisti in questi <strong>anni</strong> <strong>di</strong>mostra <strong>de</strong>l resto la loro vicinanza spirituale, e riteniamo che non sia inappropriato parlare <strong>di</strong> un<br />
vero e proprio influsso stilistico da parte <strong>di</strong> Longo sul più giovane allievo. D’altra parte Longo non poteva consi<strong>de</strong>rare<br />
Margola come un semplice stu<strong>de</strong>nte <strong>di</strong> conservatorio, ma doveva già stimarlo come collega, dal momento che il giovane<br />
musicista aveva in realtà già dato ottime prove <strong>di</strong> sé. Ciò, <strong>de</strong>l resto, è <strong>di</strong>mostrato ad esempio dal tono usato nella <strong>de</strong><strong>di</strong>ca <strong>de</strong>l<br />
Concerto per pianoforte e orchestra che abbiamo citato alla nota 89.<br />
Quest’ultima consi<strong>de</strong>razione ci conduce <strong>di</strong>rettamente all’ultima e più importante parte <strong>di</strong> questo capitolo relativo al<br />
periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> svolti da Margola al Conservatorio <strong>di</strong> <strong>Parma</strong>, quella cioè riguardante le prime composizioni <strong>de</strong>l musicista.<br />
Prima <strong>di</strong> affrontare questo argomento è tuttavia opportuno cercare <strong>di</strong> trarre alcune consi<strong>de</strong>razioni generali sull’influsso che<br />
l’ambiente <strong>di</strong> <strong>Parma</strong> e in particolare i tre citati insegnanti <strong>di</strong> composizione esercitarono sul giovane bresciano, così come<br />
abbiamo tentato <strong>di</strong> fare anche nel capitolo relativo ai primi <strong>anni</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a Brescia.<br />
Nuovi orizzonti<br />
Nello scritto che già abbiamo citato, uno <strong>de</strong>i primi che richiamasse l’attenzione sul giovane compositore bresciano,<br />
Alfredo Gatta teneva a sottolineare, “cosa <strong>de</strong>lla massima importanza”, che “nessuno <strong>de</strong>i tre, per quanto musicisti <strong>di</strong><br />
rispetto, massimamente Guido Guerrini per il suo Quintetto ch’è una buona e chiara pagina <strong>di</strong> musica mo<strong>de</strong>rna 98 , nessuno<br />
<strong>de</strong>i tre riuscì a stampare nel Margola orme <strong>de</strong>lla propria personalità” 99 . E così continuava:<br />
“Sono allievi che non sanno, che non possono sfuggire all’influenza artistica <strong>de</strong>l maestro; e perciò si ingrossano le già fitte schiere<br />
<strong>de</strong>i pizzettiani, <strong>de</strong>i caselliani, o <strong>di</strong> quelli che tutto assimilano e fanno <strong>di</strong> tutte le maniere un bel pasticcio; e altri invece, e fra questi è<br />
appunto Franco Margola, cui il maestro serve solamente per appren<strong>de</strong>re ‘il mestiere’ o, se vi pare brutta la parola, la tecnica <strong>de</strong>ll’arte,<br />
oppure, meglio ancora, la grammatica, la sintassi <strong>de</strong>i suoni. Con i maestri che il Nostro avvicinò, egli fece un vero e proprio ed esclusivo<br />
artigianato artistico” 100 .<br />
È <strong>di</strong>fficile confutare o sostenere con altrettanta sicurezza simili osservazioni. Lo stu<strong>di</strong>o con ciascuno <strong>de</strong>i tre maestri<br />
durò effettivamente un periodo troppo breve perché ne risultasse un evi<strong>de</strong>nte con<strong>di</strong>zionamento <strong>de</strong>lla personalità, che, come<br />
abbiamo <strong>de</strong>tto, doveva essere almeno in parte già formata. Inoltre è importante valutare anche l’ambientazione generale in<br />
cui l’appren<strong>di</strong>mento si svolse e non soltanto la personalità <strong>de</strong>i singoli insegnanti.<br />
Tuttavia riteniamo per lo meno i<strong>de</strong>alistico affermare, come fa Alfredo Gatta, che il periodo passato a <strong>Parma</strong> fosse <strong>di</strong><br />
puro tirocinio tecnico, durante il quale il musicista abbia appreso solo un ‘mestiere’. Ragioni <strong>di</strong> buon senso ne fanno<br />
dubitare, soprattutto se si pone in relazione il Margola compositore con l’ambiente musicale bresciano che gli <strong>di</strong>e<strong>de</strong> la<br />
prima formazione: ambiente, come abbiamo visto, ricco <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni, ma ben poco aperto alle correnti e ai movimenti più<br />
aggiornati e ben poco inserito in una vita culturale veramente mo<strong>de</strong>rna e <strong>di</strong> respiro nazionale, quale quella <strong>di</strong> cui senza<br />
dubbio necessitava un giovane artista ai suoi primi <strong>de</strong>butti. Qui, in <strong>anni</strong> in cui Stravinsky e Schönberg avevano ormai<br />
aperto nuovi orizzonti alla musica <strong>de</strong>l Novecento, si faticava ancora a <strong>di</strong>gerire Wagner e Debussy, si era ancora restii ad<br />
affrontare <strong>di</strong> petto il problema <strong>de</strong>lla crisi <strong>de</strong>l linguaggio tonale. Margola non sarebbe riuscito ad inserirsi nel circuito <strong>di</strong> una<br />
cultura musicale nazionale mo<strong>de</strong>rna, se l’ambiente <strong>di</strong> <strong>Parma</strong> e in particolare i suoi insegnanti non avessero svolto<br />
un’importante funzione me<strong>di</strong>atrice nei confronti <strong>di</strong> essa. Questo non soltanto perché Brescia era <strong>di</strong>venuto un centro<br />
relativamente periferico, abbastanza congelato com’era in un inevitabile conservatorismo <strong>de</strong>terminato dalla presenza <strong>di</strong><br />
pochi, seppure eminenti, maestri che con<strong>di</strong>zionavano ma anche rischiavano <strong>di</strong> sclerotizzare tutta la vita musicale citta<strong>di</strong>na -<br />
mentre <strong>Parma</strong> conosceva una ben più rigogliosa circolazione <strong>di</strong> persone e <strong>di</strong> cultura, causata anche soltanto dal semplice<br />
fatto che qui il Conservatorio ‘A. Boito’ aveva attivo un numero maggiore <strong>di</strong> corsi. Ciò che è chiaramente emerso nel<br />
tracciare i rapi<strong>di</strong> profili <strong>de</strong>i musicisti che impartirono un insegnamento a Margola, è che i tre docenti <strong>di</strong> <strong>Parma</strong> erano<br />
consi<strong>de</strong>revolmente più giovani <strong>de</strong>i due (ma potremmo <strong>di</strong>re <strong>di</strong> tutto il corpo insegnante) attivi presso l’Istituto Musicale<br />
‘Venturi’. Era insomma anche una semplice questione anagrafica: Guerrini, Jachino e Longo appartenevano ad una<br />
generazione più giovane <strong>di</strong> Romanini e Capitanio e inevitabilmente il loro mondo, anche poetico, non poteva essere così<br />
profondamente ra<strong>di</strong>cato nell’Ottocento come quello <strong>de</strong>i loro più anziani colleghi bresciani. La loro partecipazione alla<br />
mo<strong>de</strong>rna vita musicale <strong>de</strong>lla nazione era attiva, vissuta da protagonisti e soprattutto non circoscritta a limitanti forme <strong>di</strong><br />
regionalismo o, peggio, <strong>di</strong> campanilismo, che inevitabilmente si rendono percepibili non appena viene a mancare una<br />
vivace circolazione <strong>di</strong> cultura. Non si <strong>di</strong>mentichi che Capitanio, pur ottimo musicista, anche spregiu<strong>di</strong>catamente mo<strong>de</strong>rno<br />
51<br />
98 Cfr. p. 43.<br />
99 GATTA, Margola, p. 38.<br />
100<br />
Ivi, pp. 38-39. Già per il Natale 1931 Alfredo Gatta aveva fatto dono a Margola <strong>de</strong>llo spartito <strong>de</strong> I pastori <strong>di</strong> Il<strong>de</strong>brando Pizzetti, con una <strong>de</strong><strong>di</strong>ca il cui<br />
tono non richie<strong>de</strong> commenti: “A Franco Margola / musicista d’alto intelletto / compositore ‘personale’ / questa lirica... <strong>de</strong>ll’...impersonale / Il<strong>de</strong>brando<br />
da <strong>Parma</strong> / il personalissimo ... critico Alfredo Gatta / Natale <strong>de</strong>l 1931”.