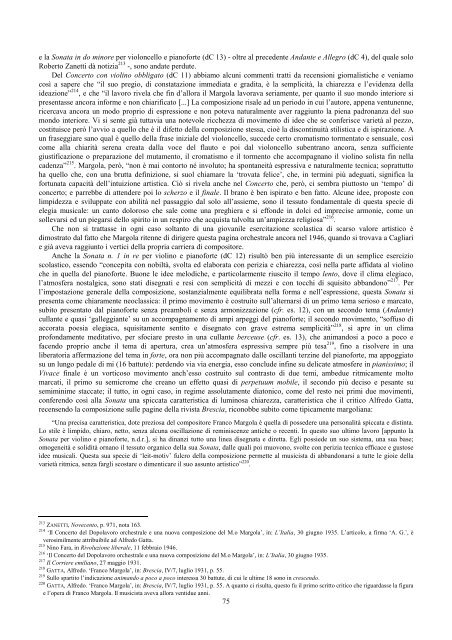Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
e la Sonata in do minore per violoncello e pianoforte (dC 13) - oltre al prece<strong>de</strong>nte Andante e Allegro (dC 4), <strong>de</strong>l quale solo<br />
Roberto Zanetti dà notizia 213 -, sono andate perdute.<br />
Del Concerto con violino obbligato (dC 11) abbiamo alcuni commenti tratti da recensioni giornalistiche e veniamo<br />
così a sapere che “il suo pregio, <strong>di</strong> constatazione imme<strong>di</strong>ata e gra<strong>di</strong>ta, è la semplicità, la chiarezza e l’evi<strong>de</strong>nza <strong>de</strong>lla<br />
i<strong>de</strong>azione” 214 , e che “il lavoro rivela che fin d’allora il Margola lavorava seriamente, per quanto il suo mondo interiore si<br />
presentasse ancora informe e non chiarificato [...] La composizione risale ad un periodo in cui l’autore, appena ventunenne,<br />
ricercava ancora un modo proprio <strong>di</strong> espressione e non poteva naturalmente aver raggiunto la piena padronanza <strong>de</strong>l suo<br />
mondo interiore. Vi si sente già tuttavia una notevole ricchezza <strong>di</strong> movimento <strong>di</strong> i<strong>de</strong>e che se conferisce varietà al pezzo,<br />
costituisce però l’avvio a quello che è il <strong>di</strong>fetto <strong>de</strong>lla composizione stessa, cioè la <strong>di</strong>scontinuità stilistica e <strong>di</strong> ispirazione. A<br />
un fraseggiare sano qual è quello <strong>de</strong>lla frase iniziale <strong>de</strong>l violoncello, succe<strong>de</strong> certo cromatismo tormentato e sensuale, così<br />
come alla chiarità serena creata dalla voce <strong>de</strong>l flauto e poi dal violoncello subentrano ancora, senza sufficiente<br />
giustificazione o preparazione <strong>de</strong>l mutamento, il cromatismo e il tormento che accompagnano il violino solista fin nella<br />
ca<strong>de</strong>nza” 215 . Margola, però, “non è mai contorto né involuto; ha spontaneità espressiva e naturalmente tecnica; soprattutto<br />
ha quello che, con una brutta <strong>de</strong>finizione, si suol chiamare la ‘trovata felice’, che, in termini più a<strong>de</strong>guati, significa la<br />
fortunata capacità <strong>de</strong>ll’intuizione artistica. Ciò si rivela anche nel Concerto che, però, ci sembra piuttosto un ‘tempo’ <strong>di</strong><br />
concerto; e parrebbe <strong>di</strong> atten<strong>de</strong>re poi lo scherzo e il finale. Il brano è ben ispirato e ben fatto. Alcune i<strong>de</strong>e, proposte con<br />
limpi<strong>de</strong>zza e sviluppate con abilità nel passaggio dal solo all’assieme, sono il tessuto fondamentale <strong>di</strong> questa specie <strong>di</strong><br />
elegia musicale: un canto doloroso che sale come una preghiera e si effon<strong>de</strong> in dolci ed imprecise armonie, come un<br />
sollevarsi ed un piegarsi <strong>de</strong>llo spirito in un respiro che acquista talvolta un’ampiezza religiosa” 216 .<br />
Che non si trattasse in ogni caso soltanto <strong>di</strong> una giovanile esercitazione scolastica <strong>di</strong> scarso valore artistico è<br />
<strong>di</strong>mostrato dal fatto che Margola ritenne <strong>di</strong> <strong>di</strong>rigere questa pagina orchestrale ancora nel 1946, quando si trovava a Cagliari<br />
e già aveva raggiunto i vertici <strong>de</strong>lla propria carriera <strong>di</strong> compositore.<br />
Anche la Sonata n. 1 in re per violino e pianoforte (dC 12) risultò ben più interessante <strong>di</strong> un semplice esercizio<br />
scolastico, essendo “concepita con nobiltà, svolta ed elaborata con perizia e chiarezza, così nella parte affidata al violino<br />
che in quella <strong>de</strong>l pianoforte. Buone le i<strong>de</strong>e melo<strong>di</strong>che, e particolarmente riuscito il tempo lento, dove il clima elegiaco,<br />
l’atmosfera nostalgica, sono stati <strong>di</strong>segnati e resi con semplicità <strong>di</strong> mezzi e con tocchi <strong>di</strong> squisito abbandono” 217 . Per<br />
l’impostazione generale <strong>de</strong>lla composizione, sostanzialmente equilibrata nella forma e nell’espressione, questa Sonata si<br />
presenta come chiaramente neoclassica: il primo movimento è costruito sull’alternarsi <strong>di</strong> un primo tema serioso e marcato,<br />
subito presentato dal pianoforte senza preamboli e senza armonizzazione (cfr. es. 12), con un secondo tema (Andante)<br />
cullante e quasi ‘galleggiante’ su un accompagnamento <strong>di</strong> ampi arpeggi <strong>de</strong>l pianoforte; il secondo movimento, “soffuso <strong>di</strong><br />
accorata poesia elegiaca, squisitamente sentito e <strong>di</strong>segnato con grave estrema semplicità” 218 , si apre in un clima<br />
profondamente me<strong>di</strong>tativo, per sfociare presto in una cullante berceuse (cfr. es. 13), che animandosi a poco a poco e<br />
facendo proprio anche il tema <strong>di</strong> apertura, crea un’atmosfera espressiva sempre più tesa 219 , fino a risolvere in una<br />
liberatoria affermazione <strong>de</strong>l tema in forte, ora non più accompagnato dalle oscillanti terzine <strong>de</strong>l pianoforte, ma appoggiato<br />
su un lungo pedale <strong>di</strong> mi (16 battute): per<strong>de</strong>ndo via via energia, esso conclu<strong>de</strong> infine su <strong>de</strong>licate atmosfere in pianissimo; il<br />
Vivace finale è un vorticoso movimento anch’esso costruito sul contrasto <strong>di</strong> due temi, ambedue ritmicamente molto<br />
marcati, il primo su semicrome che creano un effetto quasi <strong>di</strong> perpetuum mobile, il secondo più <strong>de</strong>ciso e pesante su<br />
semiminime staccate; il tutto, in ogni caso, in regime assolutamente <strong>di</strong>atonico, come <strong>de</strong>l resto nei primi due movimenti,<br />
conferendo così alla Sonata una spiccata caratteristica <strong>di</strong> luminosa chiarezza, caratteristica che il critico Alfredo Gatta,<br />
recensendo la composizione sulle pagine <strong>de</strong>lla rivista Brescia, riconobbe subito come tipicamente margoliana:<br />
“Una precisa caratteristica, dote preziosa <strong>de</strong>l compositore Franco Margola è quella <strong>di</strong> posse<strong>de</strong>re una personalità spiccata e <strong>di</strong>stinta.<br />
Lo stile è limpido, chiaro, netto, senza alcuna oscillazione <strong>di</strong> reminiscenze antiche o recenti. In questo suo ultimo lavoro [appunto la<br />
Sonata per violino e pianoforte, n.d.r.], si ha <strong>di</strong>nanzi tutto una linea <strong>di</strong>segnata e <strong>di</strong>retta. Egli possie<strong>de</strong> un suo sistema, una sua base;<br />
omogeneità e soli<strong>di</strong>tà ornano il tessuto organico <strong>de</strong>lla sua Sonata, dalle quali poi muovono, svolte con perizia tecnica efficace e gustose<br />
i<strong>de</strong>e musicali. Questa sua specie <strong>di</strong> ‘leit-motiv’ fulcro <strong>de</strong>lla composizione permette al musicista <strong>di</strong> abbandonarsi a tutte le gioie <strong>de</strong>lla<br />
varietà ritmica, senza fargli scostare o <strong>di</strong>menticare il suo assunto artistico” 220 .<br />
213<br />
ZANETTI, Novecento, p. 971, nota 163.<br />
214<br />
‘Il Concerto <strong>de</strong>l Dopolavoro orchestrale e una nuova composizione <strong>de</strong>l M.o Margola’, in: L’Italia, 30 giugno 1935. L’articolo, a firma ‘A. G.’, è<br />
verosimilmente attribuibile ad Alfredo Gatta.<br />
215<br />
Nino Fara, in Rivoluzione liberale, 11 febbraio 1946.<br />
216<br />
‘Il Concerto <strong>de</strong>l Dopolavoro orchestrale e una nuova composizione <strong>de</strong>l M.o Margola’, in: L’Italia, 30 giugno 1935.<br />
217<br />
Il Corriere emiliano, 27 maggio 1931.<br />
218<br />
GATTA, Alfredo. ‘Franco Margola’, in: Brescia, IV/7, luglio 1931, p. 55.<br />
219<br />
Sullo spartito l’in<strong>di</strong>cazione animando a poco a poco interessa 30 battute, <strong>di</strong> cui le ultime 18 sono in crescendo.<br />
220<br />
GATTA, Alfredo. ‘Franco Margola’, in: Brescia, IV/7, luglio 1931, p. 55. A quanto ci risulta, questo fu il primo scritto critico che riguardasse la figura<br />
e l’opera <strong>di</strong> Franco Margola. Il musicista aveva allora ventidue <strong>anni</strong>.<br />
75