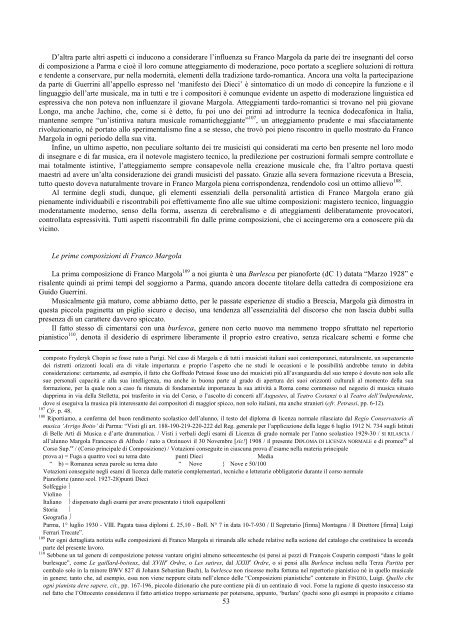Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
Monografia Capitolo II - Gli anni di studio a Parma - Ottavio de Carli
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
D’altra parte altri aspetti ci inducono a consi<strong>de</strong>rare l’influenza su Franco Margola da parte <strong>de</strong>i tre insegnanti <strong>de</strong>l corso<br />
<strong>di</strong> composizione a <strong>Parma</strong> e cioè il loro comune atteggiamento <strong>di</strong> mo<strong>de</strong>razione, poco portato a scegliere soluzioni <strong>di</strong> rottura<br />
e ten<strong>de</strong>nte a conservare, pur nella mo<strong>de</strong>rnità, elementi <strong>de</strong>lla tra<strong>di</strong>zione tardo-romantica. Ancora una volta la partecipazione<br />
da parte <strong>di</strong> Guerrini all’appello espresso nel ‘manifesto <strong>de</strong>i Dieci’ è sintomatico <strong>di</strong> un modo <strong>di</strong> concepire la funzione e il<br />
linguaggio <strong>de</strong>ll’arte musicale, ma in tutti e tre i compositori è comunque evi<strong>de</strong>nte un aspetto <strong>di</strong> mo<strong>de</strong>razione linguistica ed<br />
espressiva che non poteva non influenzare il giovane Margola. Atteggiamenti tardo-romantici si trovano nel più giovane<br />
Longo, ma anche Jachino, che, come si è <strong>de</strong>tto, fu poi uno <strong>de</strong>i primi ad introdurre la tecnica do<strong>de</strong>cafonica in Italia,<br />
mantenne sempre “un’istintiva natura musicale romanticheggiante” 107 , un atteggiamento pru<strong>de</strong>nte e mai sfacciatamente<br />
rivoluzionario, né portato allo sperimentalismo fine a se stesso, che trovò poi pieno riscontro in quello mostrato da Franco<br />
Margola in ogni periodo <strong>de</strong>lla sua vita.<br />
Infine, un ultimo aspetto, non peculiare soltanto <strong>de</strong>i tre musicisti qui consi<strong>de</strong>rati ma certo ben presente nel loro modo<br />
<strong>di</strong> insegnare e <strong>di</strong> far musica, era il notevole magistero tecnico, la pre<strong>di</strong>lezione per costruzioni formali sempre controllate e<br />
mai totalmente istintive, l’atteggiamento sempre consapevole nella creazione musicale che, fra l’altro portava questi<br />
maestri ad avere un’alta consi<strong>de</strong>razione <strong>de</strong>i gran<strong>di</strong> musicisti <strong>de</strong>l passato. Grazie alla severa formazione ricevuta a Brescia,<br />
tutto questo doveva naturalmente trovare in Franco Margola piena corrispon<strong>de</strong>nza, ren<strong>de</strong>ndolo così un ottimo allievo 108 .<br />
Al termine <strong>de</strong>gli stu<strong>di</strong>, dunque, gli elementi essenziali <strong>de</strong>lla personalità artistica <strong>di</strong> Franco Margola erano già<br />
pienamente in<strong>di</strong>viduabili e riscontrabili poi effettivamente fino alle sue ultime composizioni: magistero tecnico, linguaggio<br />
mo<strong>de</strong>ratamente mo<strong>de</strong>rno, senso <strong>de</strong>lla forma, assenza <strong>di</strong> cerebralismo e <strong>di</strong> atteggiamenti <strong>de</strong>liberatamente provocatori,<br />
controllata espressività. Tutti aspetti riscontrabili fin dalle prime composizioni, che ci accingeremo ora a conoscere più da<br />
vicino.<br />
Le prime composizioni <strong>di</strong> Franco Margola<br />
La prima composizione <strong>di</strong> Franco Margola 109 a noi giunta è una Burlesca per pianoforte (dC 1) datata “Marzo 1928” e<br />
risalente quin<strong>di</strong> ai primi tempi <strong>de</strong>l soggiorno a <strong>Parma</strong>, quando ancora docente titolare <strong>de</strong>lla cattedra <strong>di</strong> composizione era<br />
Guido Guerrini.<br />
Musicalmente già maturo, come abbiamo <strong>de</strong>tto, per le passate esperienze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a Brescia, Margola già <strong>di</strong>mostra in<br />
questa piccola paginetta un piglio sicuro e <strong>de</strong>ciso, una ten<strong>de</strong>nza all’essenzialità <strong>de</strong>l <strong>di</strong>scorso che non lascia dubbi sulla<br />
presenza <strong>di</strong> un carattere davvero spiccato.<br />
Il fatto stesso <strong>di</strong> cimentarsi con una burlesca, genere non certo nuovo ma nemmeno troppo sfruttato nel repertorio<br />
pianistico 110 , <strong>de</strong>nota il <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rio <strong>di</strong> esprimere liberamente il proprio estro creativo, senza ricalcare schemi e forme che<br />
composto Fry<strong>de</strong>ryk Chopin se fosse nato a Parigi. Nel caso <strong>di</strong> Margola e <strong>di</strong> tutti i musicisti italiani suoi contemporanei, naturalmente, un superamento<br />
<strong>de</strong>i ristretti orizzonti locali era <strong>di</strong> vitale importanza e proprio l’aspetto che ne stu<strong>di</strong> le occasioni e le possibilità andrebbe tenuto in <strong>de</strong>bita<br />
consi<strong>de</strong>razione: certamente, ad esempio, il fatto che Goffredo Petrassi fosse uno <strong>de</strong>i musicisti più all’avanguar<strong>di</strong>a <strong>de</strong>l suo tempo è dovuto non solo alle<br />
sue personali capacità e alla sua intelligenza, ma anche in buona parte al grado <strong>di</strong> apertura <strong>de</strong>i suoi orizzonti culturali al momento <strong>de</strong>lla sua<br />
formazione, per la quale non a caso fu ritenuta <strong>di</strong> fondamentale importanza la sua attività a Roma come commesso nel negozio <strong>di</strong> musica situato<br />
dapprima in via <strong>de</strong>lla Stelletta, poi trasferito in via <strong>de</strong>l Corso, o l’ascolto <strong>di</strong> concerti all’Augusteo, al Teatro Costanzi o al Teatro <strong>de</strong>ll’In<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nte,<br />
dove si eseguiva la musica più interessante <strong>de</strong>i compositori <strong>di</strong> maggior spicco, non solo italiani, ma anche stranieri (cfr. Petrassi, pp. 6-12).<br />
107<br />
Cfr. p. 48.<br />
108<br />
Riportiamo, a conferma <strong>de</strong>l buon ren<strong>di</strong>mento scolastico <strong>de</strong>ll’alunno, il testo <strong>de</strong>l <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> licenza normale rilasciato dal Regio Conservatorio <strong>di</strong><br />
musica ‘Arrigo Boito’ <strong>di</strong> <strong>Parma</strong>: “Visti gli art. 188-190-219-220-222 <strong>de</strong>l Reg. generale per l’applicazione <strong>de</strong>lla legge 6 luglio 1912 N. 734 sugli Istituti<br />
<strong>di</strong> Belle Arti <strong>di</strong> Musica e d’arte drammatica. / Visti i verbali <strong>de</strong>gli esami <strong>di</strong> Licenza <strong>di</strong> grado normale per l’anno scolastico 1929-30 / SI RILASCIA /<br />
all’alunno Margola Francesco <strong>di</strong> Alfredo / nato a Orzinuovi il 30 Novembre [sic!] 1908 / il presente DIPLOMA DI LICENZA NORMALE e <strong>di</strong> promoz<br />
53<br />
ne al<br />
Corso Sup. re / (Corso principale <strong>di</strong> Composizione) / Votazioni conseguite in ciascuna prova d’esame nella materia principale<br />
prova a) = Fuga a quattro voci su tema dato punti Dieci Me<strong>di</strong>a<br />
“ b) = Romanza senza parole su tema dato “ Nove } Nove e 50/100<br />
Votazioni conseguite negli esami <strong>di</strong> licenza dalle materie complementari, tecniche e letterarie obbligatorie durante il corso normale<br />
Pianoforte (anno scol. 1927-28)punti Dieci<br />
Solfeggio ⎫<br />
Violino ⎪<br />
Italiano ⎬ <strong>di</strong>spensato dagli esami per avere presentato i titoli equipollenti<br />
Storia ⎪<br />
Geografia ⎭<br />
<strong>Parma</strong>, 1° luglio 1930 - V<strong>II</strong>I. Pagata tassa <strong>di</strong>plomi £. 25,10 - Boll. N° 7 in data 10-7-930 / Il Segretario [firma] Montagna / Il Direttore [firma] Luigi<br />
Ferrari Trecate”.<br />
109<br />
Per ogni <strong>de</strong>ttagliata notizia sulle composizioni <strong>di</strong> Franco Margola si rimanda alle sche<strong>de</strong> relative nella sezione <strong>de</strong>l catalogo che costituisce la seconda<br />
parte <strong>de</strong>l presente lavoro.<br />
110<br />
Sebbene un tal genere <strong>di</strong> composizione potesse vantare origini almeno settecentesche (si pensi ai pezzi <strong>di</strong> François Couperin composti “dans le goût<br />
burlesque”, come Le gaillard-boiteux, dal XV<strong>II</strong>I e Ordre, o Les satires, dal XX<strong>II</strong>I e Ordre, o si pensi alla Burlesca inclusa nella Terza Partita per<br />
cembalo solo in la minore BWV 827 <strong>di</strong> Johann Sebastian Bach), la burlesca non riscosse molta fortuna nel repertorio pianistico né in quello musicale<br />
in genere; tanto che, ad esempio, essa non viene neppure citata nell’elenco <strong>de</strong>lle “Composizioni pianistiche” contenuto in FINIZIO, Luigi. Quello che<br />
ogni pianista <strong>de</strong>ve sapere, cit., pp. 167-196, piccolo <strong>di</strong>zionario che pure contiene più <strong>di</strong> un centinaio <strong>di</strong> voci. Forse la ragione <strong>di</strong> questo insuccesso sta<br />
nel fatto che l’Ottocento consi<strong>de</strong>rava il fatto artistico troppo seriamente per potersene, appunto, ‘burlare’ (pochi sono gli esempi in proposito e citiamo