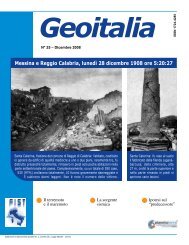Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
acqua, mentre non lo sono i composti di ferro trivalente, che<br />
si possono produrre solo in ambiente altamente ossidante.<br />
Per tale motivo, oggi il ferro liberato dalle rocce sottoposte<br />
ad idrolisi nei continenti precipita in gran prevalenza sotto<br />
forma di ossidi insolubili come l’ematite, misti eventualmente<br />
ad idrossidi. Nei climi temperati si originano in tal<br />
modo la “limonite’’ e le “terre rosse’’, mentre sono del tutto<br />
marginali, perché tipici di ambienti riducenti, i depositi sotto<br />
forma di solfuri o di carbonati. Nei climi intertropicali il<br />
prodotto più caratteristico dell’attacco alle rocce silicatiche<br />
è invece la “laterite’’, dal caratteristico colore rosso cupo, talora<br />
presente su aree estesissime sotto forma di veri crostoni<br />
di sali ferrici <strong>della</strong> potenza di decine di metri, in cui spesso si<br />
concentra anche l’alluminio (quando è prevalente, precipitato<br />
sotto forma di idrossido insolubile, si hanno le “bauxiti’’).<br />
Il poco ferro che sfugge a questo destino fi nisce, pare<br />
soprattutto sotto forma di complessi colloidali, negli oceani,<br />
dove a contatto con l’acqua salata avverrebbero fenomeni di<br />
fl occulazione, comuni anche ai minerali argillosi. Lo stato<br />
di ossidazione sotto cui si conserverà il ferro nei sedimenti<br />
dipenderà, in parte dall’ambiente chimico-fi sico che caratterizza<br />
l’interfaccia acqua-sedimento, in parte da quello che<br />
domina nel corso <strong>della</strong> diagenesi precoce, nei pochi centimetri<br />
o decimetri al disotto dell’interfaccia deposizionale.<br />
Oggi in questo ambiente, che prelude all’infossamento<br />
defi nitivo dei depositi, dominano situazioni caratterizzate da<br />
scarsità di ossigeno (anossiche): tutto l’ossigeno disponibile<br />
viene consumato nell’ambito dei pochi centimetri o decimetri<br />
di sedimento fresco superfi ciale ad opera del mondo<br />
microscopico aerobio, nel corso <strong>della</strong> demolizione <strong>della</strong> sostanza<br />
organica.<br />
Al disotto è il campo di azione degli anaerobi, per cui<br />
vi dominano soprattutto ammoniaca e acido solfi drico. Se<br />
poi i fondali sono già anossici, questa situazione è già presente<br />
all’interfaccia deposizionale. In entrambi i casi, il ferro<br />
proveniente dai continenti ha molte probabilità di essere<br />
conservato nei sedimenti marini sotto forma di fi ni pigmenti<br />
di solfuri dal colore bluastro-nerastro (e questo spiega ad<br />
esempio il colore grigiastro o plumbeo di moltissimi depositi<br />
argillosi e argilloso-arenacei, ben noti agli stratigrafi di<br />
tutto il mondo).<br />
Contrasta in modo stridente con questa situazione il record<br />
geologico, che non registra depositi continentali arrossati<br />
dalle rocce più antiche fi no al Precambriano medio,<br />
diciamo fi no ad un paio di miliardi di anni fa, e riscontra invece<br />
fi no ad allora una presenza massiccia di ferro rosso (in<br />
genere sotto forma di sottili alternanze di ematite e di silice,<br />
note come banded ironstone), nei più antichi depositi marini<br />
conservati fossili un po’ in tutti continenti. Formazioni di<br />
“ferro a strisce” di questo tipo non si ritrovano più da allora.<br />
C’è quindi un momento nella storia <strong>della</strong> Terra in cui il<br />
ferro ha iniziato a venire bloccato sui continenti sotto forma<br />
di ossido e idrossido ferrico, e questo non poteva avvenire<br />
che in presenza di una atmosfera ossidante.<br />
La storia che si ricostruisce dei primordi <strong>della</strong> Terra vede<br />
l’habitat marino occupato, a partire da almeno 3,2 miliardi<br />
di anni fa, da organismi a metabolismo fotosintetico che<br />
prosperavano in un ambiente acqueo gradualmente arricchito<br />
di sali vari trasportati in soluzione da torrenti e fi umi.<br />
L’ossigeno prodotto nel corso <strong>della</strong> fotosintesi costituiva<br />
molto probabilmente un sottoprodotto velenoso, ma il<br />
ferro trasportato al mare sotto forma bivalente lo asportava<br />
dall’acqua, trasformandosi in ossidi trivalenti che precipitavano<br />
sul fondo. Se da un lato questo processo chimico provvedeva<br />
effi cacemente a rimuovere dall’ambiente acqueo<br />
l’ossigeno e quindi ad abbassarne il livello di tossicità per<br />
gli organismi viventi, ne impediva dall’altra la diffusione<br />
verso l’atmosfera. Nell’effi cace sintesi di Vittori (1980) “il<br />
meccanismo che produceva ossigeno (la fotosintesi) e quello<br />
che lo rimuoveva (precipitazione di ossido di ferro) davano<br />
luogo ad una specie di cortocircuito, nel senso che agivano<br />
nello stesso luogo e l’uno contemporaneamente all’altro.<br />
Le strisce alternate ricche e povere di ferro che si osservano<br />
nei depositi sono considerate indicative di periodi in cui<br />
variava la domanda (da più pressante a meno pressante) di<br />
rimozione da parte dell’habitat vitale. In defi nitiva l’ossigeno<br />
che la vita produceva liberandolo nell’ambiente non<br />
cambiava apprezzabilmente 1’atmosfera del pianeta. Se si fa<br />
risalire l’inizio <strong>della</strong> fotosintesi a 3,2 miliardi di anni fa, si<br />
può dedurre che l’ossigeno non apparve al di fuori dell’habitat<br />
marino per altri 1,2 miliardi di anni. Veniva infatti rimosso<br />
dal ferro solubile per precipitazione là dove esso si<br />
formava. Quando gli organismi furono in grado di adattarsi<br />
all’ambiente con l’acquisizione di mezzi autonomi per disintossicarsi<br />
dall’ossigeno ambientale (fu necessario più di<br />
un quarto <strong>della</strong> vita attuale del pianeta) allora l’ossigeno non<br />
rappresentò più un pericolo per la loro sopravvivenza. Si<br />
moltiplicarono e la quantità di ossigeno che veniva immessa<br />
nell’ambiente aumentò in crescendo con il loro sviluppo.<br />
L’ossigeno cominciò così a sfuggire dal ristretto ambiente<br />
che lo produceva per entrare nell’atmosfera. Ed è in questa<br />
fase dell’evoluzione del pianeta che il “ferro a strisce’’<br />
scompare dai ricordi per far posto al “ferro rosso’’ dei depositi<br />
continentali”.<br />
Ricordiamo che quando l’ossigeno accumulatosi nell’atmosfera<br />
raggiunse appena 1’1 % <strong>della</strong> concentrazione attuale,<br />
iniziò a formarsi lo scudo di ozono con i suoi effetti<br />
di difesa, già esaminati, dal letale ultravioletto. Con un<br />
tale scudo embrionale a disposizione, lo spessore di acqua<br />
necessario per difendersi dalle radiazioni si ridusse ad un<br />
centimetro: nulla impediva a questo punto agli organismi<br />
di occupare la distesa dagli oceani e di crescere ed evolvere<br />
all’interno di questo immenso orizzonte. E lo sviluppo stesso<br />
liberò ancor più ossigeno. Quando la concentrazione di<br />
Geoitalia 36, 2011 17