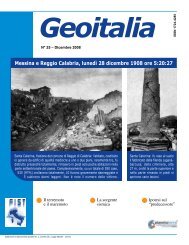Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ossigeno raggiunse il 10% di quella attuale, la protezione<br />
divenne simile a quella di oggi e anche i (continenti con la<br />
loro varietà di situazioni ambientali furono aperti all’invasione<br />
degli organismi viventi.<br />
Facciamo presente che l’attività fotosintetica unita all’accumulo<br />
nei sedimenti dei primi carbonati marini, derivanti<br />
dall’idrolisi continentale dei silicati calcici, avrebbe in breve<br />
tempo ridotto drasticamente il tenore di anidride carbonica<br />
presente <strong>sulla</strong> Terra (tra l’altro con conseguenze nefaste<br />
sull’effetto serra, indispensabile per mantenersi al di sopra<br />
<strong>della</strong> temperatura di congelamento dell’acqua) se non fossero<br />
intervenuti i meccanismi già esaminati di autoregolazione<br />
del tenore in CO 2 a breve e lungo termine. Anidride carbonica,<br />
acqua liquida, ossigeno, ozono, vita, geodinamica <strong>della</strong><br />
litosfera appaiono in questo quadro strettamente allacciati<br />
ed interdipendenti.<br />
Equilibrare la temperatura sul pianeta<br />
La Terra ha altri due problemi: come ridistribuire su tutta<br />
la superfi cie, in modo relativamente uniforme, l’energia che<br />
riceve dal Sole; come liberarsi gradualmente, senza crisi catastrofi<br />
che, dell’energia in eccesso nel sottosuolo.<br />
L’energia che proviene in media dal Sole corrisponde a<br />
circa 340 watt/metro quadro, di cui i1 30% circa viene subito<br />
rifl esso nello spazio. I 240 watt/metro quadro che rimangono<br />
non sono distribuiti in modo uniforme sul pianeta:<br />
all’equatore la radiazione è molto più intensa che ai poli. Da<br />
qui un eccesso di energia <strong>nelle</strong> regioni tropicali e un defi -<br />
cit <strong>nelle</strong> regioni artiche. Ovviamente ce ne accorgiamo, ma<br />
l’effetto è fortemente limitato da una serie di meccanismi<br />
di autoregolazione che fanno sì che ai poli il freddo non sia<br />
così intenso come potrebbe in realtà essere, e ai tropici non<br />
si raggiungano temperature inaccettabili per la vita.<br />
Il più noto di tali meccanismi è il movimento delle grandi<br />
masse d’aria, organizzato in sistemi a grandi celle di circolazione<br />
ben defi nite che agiscono come un colossale sistema<br />
di aerazione, trasferendo il calore da un punto all’altro <strong>della</strong><br />
Terra. Fiumi d’aria scorrono senza interruzione nell’atmosfera<br />
fi no a 50 km di altezza, muovendosi secondo direzioni<br />
praticamente costanti.<br />
È stato tuttavia calcolato che il movimento dell’aria, anche<br />
se andasse a velocità molto più elevate di quelle raggiunte<br />
oggi, non sarebbe suffi ciente per ridistribuire l’energia del<br />
Sole <strong>sulla</strong> Terra. In realtà c’è all’opera un condizionatore ad<br />
acqua più lento ma molto più effi ciente, solo in parte attivato<br />
dalla circolazione atmosferica stessa, che agisce <strong>sulla</strong> superfi<br />
cie delle acque creando importanti correnti superfi ciali e<br />
alimentando il ciclo delle piogge.<br />
Gli oceani sono infatti attraversati da enormi fi umi d’acqua<br />
di portata venti volte superiore a quella di tutti i fi umi<br />
<strong>della</strong> Terra messi assieme, la cui funzione è quella di riequilibrare<br />
temperatura e salinità attraverso un circuito la<br />
cui durata complessiva è di circa 500 anni. Così la descrive<br />
un grande esperto di circolazione oceanica, W.S. Broecker<br />
(1996):<br />
“Celle convettive giganti, simili a immani nastri trasportatori,<br />
si estendono per l’intera lunghezza degli oceani.<br />
Nell’Atlantico le acque calde superfi ciali fl uiscono verso<br />
Nord fi no alle vicinanze <strong>della</strong> Groenlandia, dove l’aria artica<br />
le raffredda permettendo loro di affondare e di fl uire<br />
lungo tutto l’Atlantico fi no all’Oceano australe, <strong>nelle</strong> immediate<br />
adiacenze dell’Antartide. Qui queste acque risultano<br />
relativamente più calde, e quindi meno dense, delle gelide<br />
acque superfi ciali, cosicché la corrente risale di nuovo,<br />
viene raffreddata fi no al punto di congelamento e riaffonda<br />
verso gli abissi. Lingue di acque antartiche di fondo, le più<br />
dense che esistano, fi niscono verso nord negli oceani Atlantico,<br />
Pacifi co e Indiano, e alla fi ne risalgono di nuovo per<br />
chiudere il ciclo.<br />
Queste cosiddette acque profonde si formano nell’Atlantico<br />
settentrionale, ma non nel Pacifi co perché le acque superfi<br />
ciali dell’Atlantico hanno un contenuto percentuale di sali<br />
disciolti molto più elevato di quelle del Pacifi co. La posizione<br />
delle grandi catene montuose <strong>nelle</strong> Americhe, in Europa e in<br />
Asia porta a confi gurazioni meteorologiche tali che l’aria che<br />
lascia il bacino dell’Atlantico è più umida di quella che vi<br />
entra; la perdita netta di acqua superfi ciale che ne risulta conduce<br />
ad un eccesso di salinità. Il sale rende più densi gli strati<br />
superiori dell’oceano; questi allora affondano nell’Atlantico<br />
settentrionale e danno inizio a un andamento <strong>della</strong> circolazione<br />
globale che tende a ridistribuire il sale in tutti gli oceani<br />
del pianeta.<br />
La circolazione dell’Atlantico, che ha una portata pari<br />
a circa 100 volte quella del Rio delle Amazzoni, provoca il<br />
trasporto verso Nord di un’enorme quantità di calore (calcolato<br />
in 30 miliardi di kilowatt di energia, N.d.A.). L’acqua<br />
che scorre in superfi cie verso Nord è, in media, di otto gradi<br />
centigradi più calda di quella che fl uisce in profondità verso<br />
sud. Il clima relativamente caldo di cui gode l’Europa è<br />
dovuto al trasferimento di questo calore alle masse d’aria<br />
artica che sovrastano l’Atlantico settentrionale.<br />
<strong>Un</strong> qualunque intoppo del sistema di trasporto tenderebbe<br />
a perpetuarsi e, se mai il nastro trasportatore dovesse<br />
arrestarsi, le temperature invernali nell’Atlantico settentrionale<br />
e <strong>nelle</strong> zone circostanti scenderebbero bruscamente di<br />
almeno cinque gradi centigradi. A Dublino si instaurerebbe<br />
così il clima delle Isole Svalbard, che si trovano 1.000 km a<br />
nord del circolo polare artico. Inoltre questo mutamento climatico<br />
avverrebbe probabilmente in meno di un decennio”.<br />
Broecker sottolinea che a causare tale intoppo basterebbe<br />
un eccessivo affl usso di acqua dolce nell’Atlantico settentrionale.<br />
<strong>Un</strong> aumento sensibile delle precipitazioni, lo svuotamento<br />
improvviso di grandi bacini lacustri o la fusione di grandi<br />
Geoitalia 36, 2011 19