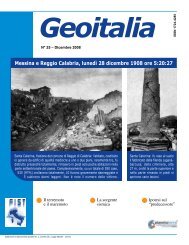Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
si presta a testare la validità dell’utilizzo delle deformazioni<br />
interne ai corpi di slump come indicatori cinematici, in<br />
particolare quando questi sono gli unici dati a disposizione<br />
per le ricostruzioni paleogeografi che (Moretti & Morsilli, in<br />
preparazione). Infi ne, nel caso degli slumps garganici, oltre<br />
al puro valore “geoestetico” e come test dei modelli esistenti,<br />
un altro possibile utilizzo è quello di verifi care se la<br />
relativa frequenza di fenomeni di instabilità sia da mettere<br />
in relazione alla tettonica sinsedimentaria (terremoti o sollevamenti<br />
tettonici del bacino) o a variazioni eustatiche e/o<br />
relative del livello marino.<br />
Geometrie deposizionali e processi di formazione<br />
In Sedimentologia con il termine slump viene indicata<br />
comunemente una successione sedimentaria stratifi cata<br />
deformata internamente durante un movimento gravitativo<br />
verso il basso. Infatti, secondo Stow (1986), uno slump può<br />
essere defi nito come: “a laterally displaced sediment masses<br />
bounded by a basal shear plane and with evident contortion<br />
and rotation of contained strata”. In pratica si tratta di una<br />
frana sottomarina, con una superfi cie di scivolamento basale<br />
concava verso l’alto, che si muove con un movimento rotazionale<br />
e con deformazione duttile dei materiali coinvolti,<br />
La marcata deformazione interna al corpo di frana è il<br />
carattere distintivo che lo differenzia rispetto alle semplici<br />
frane da scivolamento (slide). Le dimensioni degli slumps<br />
sono estremamente variabili con spessori da pochi decimetri<br />
a decine o centinaia di metri ed estensione areale in alcuni<br />
casi di decine o centinaia di chilometri quadrati (Lucente &<br />
Pini, 2003; Micallef et al., 2008).<br />
<strong>Un</strong>a caratteristica che permette di distinguere gli slump<br />
da deformazioni post-deposizionali di tipo tettonico sono<br />
la presenza alla base e al tetto di successioni non deformate.<br />
In questo modo l’intervallo deformato, imballato nella<br />
successione normalmente stratifi cata, può essere paragonato<br />
ad un classico sandwich. <strong>Un</strong>o slump mostra tipicamente<br />
una serie di pieghe legate alla deformazione degli strati di<br />
sedimento non ancora del tutto litifi cati. Queste strutture<br />
deformative comprendono piegamenti sinformi e antiformi<br />
simmetrici e asimmetrici, pieghe coricate e anche pieghe/<br />
faglie da sovrascorrimento. Le pieghe simmetriche e asimmetriche<br />
presentano un ispessimento <strong>della</strong> zona di cerniera<br />
e un assottigliamento dei fi anchi. Generalmente, l’asse delle<br />
pieghe è orientato parallelamente alla direzione (strike) <strong>della</strong><br />
scarpata e la direzione del trasporto è perpendicolare. In<br />
questo modo misurando le direzioni degli assi delle pieghe è<br />
possibile ricostruire la direzione di movimento dello slump<br />
e di conseguenza riconoscere la presenza di paleoscarpate<br />
(Woodcock, 1979).<br />
Gli slumping sottomarini si formano attraverso un complesso<br />
processo di deformazione duttile eterogenea durante<br />
tutte le fasi di sviluppo dello slump, inclusa la fase di inizio,<br />
traslazione e arresto. In particolare, come sostengono<br />
Strachan & Alsop (2006), durante la fase iniziale si possono<br />
formare pieghe con asse parallelo, obliquo o anche normale<br />
rispetto all’orientazione <strong>della</strong> scarpata. Durante la traslazione<br />
lo sforzo di taglio applicato produce la progressiva deformazione<br />
delle pieghe formate nella fase iniziale e può creare<br />
ulteriori pieghe.<br />
Variazioni nello sforzo di taglio sono il risultato di cambi<br />
di velocità, proprietà reologiche dei materiali coinvolti<br />
nella deformazione, pressioni interstiziali e variazioni <strong>nelle</strong><br />
caratteristiche morfologiche <strong>della</strong> scarpata e del substrato.<br />
La complessa interazione tra queste variabili spiega perché<br />
ogni singolo orizzonte di slump sia unico nel suo stile e solo<br />
simile ad altri, a parità di materiali coinvolti e di dimensioni.<br />
Per analogia con le opere d’arte gli slumps non sono delle<br />
“litografi e” ma pezzi unici fi rmati dallo stesso “autore”.<br />
Gli slumping sottomarini sono ritenuti una parte del continuo<br />
dei processi di trasporto indotti dalla gravità, lungo le<br />
scarpate e <strong>nelle</strong> aree di transizione al bacino, in cui un tipo di<br />
trasporto può evolvere e trasformarsi in numerosi altri tipi di<br />
fl ussi gravitativi (es. Hampton, 1972; Nemec, 1990; Mulder<br />
& Alexander, 2001; Dasgupta, 2003).<br />
Infatti, molti autori ritengono che numerose torbiditi<br />
possano originarsi da degli slump precursori che si trasformano<br />
in debris fl ows e successivamente in correnti di torbida<br />
(Hampton, 1972; Piper et al., 1999; Strachan, 2008 e<br />
numerosi altri).<br />
Meccanismi d’innesco<br />
Le deformazioni nei sedimenti inconsolidati e saturi<br />
come gli slumps avvengono in seguito a due processi fondamentali<br />
(Owen, 1987): un sistema di forze agenti che “guida”<br />
e rende visibile la deformazione nel record geologico<br />
(driving force system) ed un meccanismo di innesco (trigger<br />
mechanism). Negli slump il driving force system è univoco<br />
ed è connesso alla presenza di un pendio e quindi alla componente<br />
<strong>della</strong> forza peso lungo lo stesso (gravitational body<br />
force di Owen, 1987).<br />
I meccanismi di innesco delle deformazioni nei sedimenti<br />
inconsolidati sono rappresentati da quei processi che sono<br />
in grado di diminuire o annullare la resistenza al taglio dei<br />
sedimenti coinvolti (tipicamente rappresentati da processi<br />
di liquefazione e/o fl uidifi cazione). I meccanismi di innesco<br />
degli slump sono stati analizzati in letteratura da molti autori,<br />
ma la natura del processo di slumping implica episodi<br />
più o meno estesi di “risedimentazione” e stabilire la causa<br />
di innesco in questi casi può risultare quantomai complesso.<br />
In generale, l’instabilità di un pendio sottomarino è connessa<br />
sia a processi “interni” all’ambiente sedimentario (autogenic<br />
triggers di Owen & Moretti, 2011) che a processi<br />
“esterni” (allogenic triggers di Owen & Moretti, 2011).<br />
I meccanismi interni di innesco sono legati essenzialmente<br />
ai processi sedimentari ed al superamento dell’angolo di<br />
attrito interno del materiale; tale evenienza sarà connessa<br />
alla natura del pendio (gradiente ed estensione areale dello<br />
stesso) e ai caratteri dei processi sedimentari ed erosivi attivi<br />
nell’ambiente di sedimentazione (tasso di sedimentazione,<br />
caratteri strutturali e tessiturali dei depositi, eventuale pre-<br />
Geoitalia 36, 2011 49