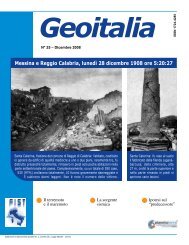Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
decreto legislativo 13 novembre 1859<br />
n. 3725 del Regno di Sardegna, entrato<br />
in vigore nel 1860 e successivamente<br />
esteso, con l’unifi cazione a tutta l’Italia.<br />
La Legge Casati prevedeva che<br />
alle Facoltà di <strong>Scienze</strong> MFN fossero<br />
annesse Scuole di applicazione di Ingegneria,<br />
affi dando a queste scuole la<br />
preparazione dei tecnici per l’industria.<br />
Dalla applicazione <strong>della</strong> Legge<br />
Casati sono sorti i primi Politecnici di<br />
Torino e Milano e quindi le Facoltà di<br />
Ingegneria.<br />
Incidentalmente sembra opportuno<br />
ricordare che i due Politecnici conferivano<br />
le due lauree in Ingegneria civile<br />
e in Ingegneria industriale e che<br />
nel Politecnico di Torino a queste due<br />
lauree si affi ancava la laurea in Ingegneria<br />
mineraria. Anche in questo<br />
caso le <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong> Terra erano ben<br />
rappresentate.<br />
Dalla impostazione <strong>della</strong> legge<br />
Casati è derivata la preminenza degli<br />
Ingegneri sulle altre fi gure tecniche, e<br />
quindi anche sui geologi, nel mondo<br />
del lavoro.<br />
Solo la costituzione dell’Ordine<br />
dei Geologi ha permesso di modifi care<br />
sostanzialmente questa situazione.<br />
Risposte alla seconda domanda<br />
La domanda è intrigante, perché la<br />
risposta presuppone una certa capacità<br />
di preveggenza. Nell’accezione scientifi<br />
ca del termine, la previsione consiste<br />
nella applicazione ad un fenomeno<br />
di una regola, espressa in una qualche<br />
forma quantitativa.<br />
Qui siamo di fronte ad un processo<br />
che, a mio parere, negli ultimi<br />
anni è apparso come una progressiva<br />
riduzione del peso delle <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong><br />
Terra nell’ambito universitario: diminuzione<br />
degli studenti immatricolati,<br />
conseguente riduzione del numero dei<br />
docenti e fragilità <strong>della</strong> maggior parte<br />
dei Dipartimenti di <strong>Scienze</strong> <strong>della</strong><br />
Terra destinati ad essere travolti dalla<br />
applicazione di una norma di legge<br />
fondata sull’erroneo assunto che nel<br />
mondo <strong>della</strong> ricerca la parola “razionalizzazione”<br />
abbia il solo signifi cato<br />
di “economie di scala”. Ḕ un assunto<br />
dimostratosi non sempre vero neppure<br />
<strong>nelle</strong> attività produttive, fi guriamoci<br />
se può essere sempre vero in una attività<br />
come la ricerca.<br />
Le <strong>Un</strong>iversità non hanno saputo<br />
difendere la loro Autonomia, tanto<br />
conclamata, rispetto ad una legge regolamento<br />
che, oltre a fi ssare principi<br />
e criteri, si arroga anche il diritto di<br />
regolamentare nei dettagli le modalità<br />
organizzative delle <strong>Un</strong>iversità. Poi i<br />
singoli Rettori hanno spesso aggiunto<br />
del loro.<br />
Per tornare alla geologia, prima<br />
di parlare di prospettive a me sembra<br />
necessario delineare le caratteristiche<br />
del geologo ricercatore e professionista<br />
del futuro. E qui torna in gioco un<br />
giudizio del tutto soggettivo: identità e<br />
competenze disciplinari non sono qualità<br />
statiche conseguite una volta per<br />
tutte, ma processi che si costruiscono<br />
nel tempo per progredire e per aderire<br />
con successo alla evoluzione del contesto.<br />
Io penso che gli Scienziati ed i<br />
Professionisti che si occuperanno in<br />
futuro del Sistema Terra: non possano<br />
prescindere da una solida preparazione<br />
di base fi sico-matematica.<br />
Debbono anche sapere collocare i<br />
fenomeni in un contesto di tempi lunghi,<br />
costruendo regole di estrapolazione<br />
dalla superfi cie al sottosuolo e dal<br />
passato geologico al futuro.<br />
Infi ne debbono elaborare un codice<br />
etico che preveda la conservazione e<br />
la pubblica fruizione dei dati e delle<br />
conoscenze.<br />
È in grado l’<strong>Un</strong>iversità di muoversi<br />
in questa direzione? Io nutro forti dubbi.<br />
La mia fi ducia va piuttosto verso<br />
quelle istituzioni che negli ultimi anni<br />
hanno dimostrato di essere più capaci<br />
di cogliere le occasioni e di non farsi<br />
cogliere impreparate. Mi riferisco al<br />
Consiglio Nazionale dei Geologi, agli<br />
Enti di Ricerca e soprattutto ad una<br />
istituzione come la FIST che ha dimostrato<br />
di essere in grado di svolgere<br />
una funzione di aggregazione <strong>della</strong><br />
comunità accademica e professionale<br />
e di diffusione <strong>della</strong> cultura di <strong>Scienze</strong><br />
<strong>della</strong> Terra.<br />
Marco Sertorio<br />
Risposte alla prima domanda<br />
Essendo un giurista, non avrei titolo<br />
per rispondere a domande che riguardano<br />
il mondo <strong>della</strong> geologia.<br />
Tuttavia, avendo versato parte dei<br />
miei studi e <strong>della</strong> mia professionalità<br />
al campo minerario, sono in grado di<br />
svolgere un percorso parallelo.<br />
Questo è il lato positivo ed interessante<br />
nell’affrontare un tema con<br />
visione multidisciplinare.<br />
L’unità d’Italia non è coincisa con<br />
la creazione del diritto minerario unitario.<br />
Ciò è dipeso dal fatto che i regni<br />
preunitari prevedevano, in materia, il<br />
regime fondiario (le miniere ricadevano<br />
nella proprietà del proprietario del<br />
suolo).<br />
L’eliminazione del regime fondiario<br />
richiese tempo e comportò di superare<br />
diritti precostituiti a privilegio<br />
del proprietario fondiario, diffi cili da<br />
eliminare.<br />
La “demanializzazione” delle miniere<br />
apparve per la prima volta <strong>nelle</strong><br />
legislazioni speciali del periodo<br />
bellico e post bellico (primo confl itto<br />
mondiale), intendendosi per demanializzazione<br />
il riconoscimento e l’affermazione<br />
del diritto dello Stato di intervenire<br />
a disciplinare rapporti attribuiti<br />
al proprietario del suolo e a promuovere<br />
la migliore utilizzazione dei beni di<br />
interesse <strong>della</strong> collettività, sottraendoli<br />
al proprietario, per dare in concessione<br />
la coltivazione a chi avesse i requisiti<br />
ed i mezzi per attuarla.<br />
Solo, quindi, con il R.D. 29 luglio<br />
1927 n. 1443 si ebbe la disciplina unitaria<br />
in materia di miniere e cave.<br />
Per quanto riguarda la proprietà<br />
dei beni minerari, il ciclo si concluse<br />
con il codice civile, che ha incluso le<br />
miniere nel patrimonio indisponibile<br />
Geoitalia 36, 2011 35