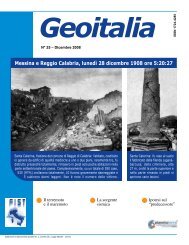Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>della</strong> quale può succedere che eventi eliminati nella stesura di<br />
un catalogo ricompaiano poi in uno successivo, semplicemente<br />
perché viene recuperata l’informazione mendace mentre manca<br />
la dimostrazione <strong>della</strong> sua fallacità. Questo aspetto viene<br />
trattato nella documentazione di base di un catalogo.<br />
Tipologie di cataloghi di terremoti<br />
I cataloghi di terremoti si suddividono in due grandi<br />
famiglie: quelli di tipo descrittivo e quelli di tipo parametrico.<br />
I cataloghi descrittivi, il cui primo esempio per l’Italia è<br />
probabilmente “Terra tremante” scritto dal Bonito nel 1691,<br />
ma il cui esempio più famoso è il già ricordato volume del<br />
Baratta, riportano la descrizione di tutte le notizie relative<br />
all’evento. Queste informazioni, almeno per i sismi adeguatamente<br />
documentati, vengono rappresentate nel caso del<br />
Baratta con una mappa degli effetti provocati dal sisma. Recentemente,<br />
oltre alle informazioni relative al terremoto, i<br />
cataloghi descrittivi riportano anche un commento sulle fonti<br />
utilizzate e <strong>sulla</strong> loro attendibilità insieme ad informazioni<br />
atte ad inserire l’evento nel contesto politico, sociale ed economico<br />
<strong>della</strong> regione interessata. L’Italia ha espresso in questo<br />
senso esempi importanti di cataloghi di terremoti, quali<br />
“Il catalogo dei forti terremoti in Italia”, preparato nel 1995<br />
da Boschi, Ferrari, Gasperini, Guidoboni, Smriglio e Valensise.<br />
Questo catalogo ha avuto nel tempo aggiornamenti ed<br />
integrazioni ed è attualmente disponibile sul sito dell’Ingv<br />
(http://portale.ingv.it/servizi-e-risorse/pagine-ponte/catalogo-dei-forti-terremoti-461-a-c-1997-cfti).<br />
I cataloghi parametrici, invece, riassumono in una semplice<br />
stringa le informazioni relative alla sorgente del terremoto,<br />
tralasciando i suoi effetti sul territorio. I parametri riportati<br />
sono, pertanto, la data e l’ora d’origine, le coordinate spaziali<br />
(latitudine, longitudine e profondità, quando disponibile) e la<br />
magnitudo, talvolta insieme anche all’intensità macrosismica<br />
epicentrale. A tutti questi parametri sono poi associate stime<br />
di attendibilità e informazioni relative alla provenienza <strong>della</strong><br />
informazione. Il primo catalogo parametrico di terremoti italiani<br />
è stato quello curato da Carrozzo, De Visentini, Giorgetti<br />
e Iaccarino nel 1973: esso riporta i dati di 10.604 terremoti<br />
avvenuti dall’inizio dell’era cristiana al marzo 1971. Il catalogo<br />
parametrico più recente è, invece, il “Catalogo Parametrico<br />
dei Terremoti Italiani”, contenente 2550 eventi, curato<br />
dal Gruppo di Lavoro CPTI nel 1999 e aggiornato ed integrato<br />
nel 2004. Attualmente è disponibile sul sito dell’INGV<br />
(http://emidius.mi.ingv.it/CPTI/home.html).<br />
Ma è il risultato fi nale del PFG, curato da Daniele Postpischl<br />
nel 1985, che può essere considerato il documento padre<br />
dei moderni cataloghi italiani, sia descrittivi che parametrici.<br />
Questo risultato è stato documentato in un catalogo<br />
parametrico contenente 37.211 eventi, utilizzabile per ogni<br />
tipo di elaborazione automatica <strong>della</strong> sismicità. Esso è accompagnato<br />
da un atlante, dove ogni terremoto, per cui era<br />
stato possibile raccogliere informazioni suffi cienti, viene<br />
descritto ampiamente e le stime di intensità macrosismica<br />
sono rappresentate in mappa.<br />
Lo studio <strong>della</strong> sismicità storica in Europa<br />
L’Italia è stata l’apripista dello studio <strong>della</strong> sismicità storica<br />
con metodi moderni (approccio PFG) in Europa e questo<br />
suo ruolo si è materializzato con la leadership di diversi progetti<br />
europei fi nalizzati alla costruzione di un catalogo europeo<br />
omogeneo e costruito con una metodologia codifi cata.<br />
Il primo esempio in questo senso è dato dal progetto “Basic<br />
European Earthquake Catalogue and Database”, sviluppato<br />
tra il 1995 e il 1997 da un gruppo di esperti europei che ha<br />
prodotto un catalogo europeo per il periodo 1400-1899. In<br />
questo catalogo gli eventi sono stati studiati in maniera coordinata<br />
raccogliendo le informazioni recuperabili dai vari<br />
cataloghi europei ed è stata redatta la relativa carta delle intensità<br />
macrosismiche avvertite. Altri progetti europei sono<br />
seguiti negli anni successivi e continuano nei giorni d’oggi.<br />
Questi progetti hanno sviluppato interesse e sensibilità<br />
nella comunità scientifi ca relativamente alla sismologia storica<br />
ed è ormai acquisita convinzione che nessuno studio<br />
di rischio sismico può prescindere dalla precisa conoscenza<br />
dei principali terremoti del passato.<br />
A livello europeo, diverse nazioni, anche se interessate<br />
solo da sismicità minore come il Regno <strong>Un</strong>ito, la Francia,<br />
la Spagna, il Portogallo, la Svizzera e la Germania hanno<br />
affrontato lo studio <strong>della</strong> sismicità storica anche con risultati<br />
eccellenti. È questo, per esempio, il caso del Regno <strong>Un</strong>ito,<br />
dove i rarissimi terremoti che hanno provocato danno sono<br />
documentati in maniera eccellente. Non sempre, però, lo<br />
studio dei forti terremoti del passato ha seguito l’approccio<br />
storico formalizzato dal PFG, alcune volte è stato privilegiato<br />
un approccio di tipo geologico-sismotettonico, altre<br />
volte uno di tipo ingegneristico. A prescindere dalla validità<br />
indubbia di tali approcci, è sentimento comune pensare che<br />
l’approccio storico sia indispensabile per una conoscenza<br />
precisa di cosa è avvenuto tanto tempo fa.<br />
Bisogna ricordare, infi ne, che un forte stimolo allo studio<br />
dei terremoti di grande magnitudo viene dato dalla costruzione<br />
di centrali nucleari: la conoscenza dettagliata del potenziale<br />
sismogenetico è fondamentale per i siti interessati attualmente<br />
o nel possibile futuro dalla presenza di una centrale.<br />
Le zone a maggiore sismicità d’Europa sono raccolte in<br />
una fascia ubicata lungo l’Appennino e che poi individua<br />
il fronte attuale di deformazione lungo le Alpi orientali, le<br />
Dinaridi e le Ellenidi. Varie situazioni non hanno favorito lo<br />
studio <strong>della</strong> sismologia storica nei Balcani ma due progetti<br />
internazionali hanno interessato quei territori già a partire<br />
dagli anni Settanta. Lo studio dei terremoti storici trova, invece,<br />
grande diffusione in Grecia, in perfetta sintonia con<br />
quanto fatto in Italia.<br />
Geoitalia 36, 2011 39