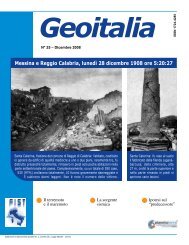Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lo studio <strong>della</strong> sismicità<br />
storica per conoscere<br />
il rischio sismico<br />
DARIO SLEJKO<br />
OGS Istituto Nazionale di Oceanografi a<br />
e Geofi sica Sperimentale<br />
Caratteristiche <strong>della</strong> sismologia storica<br />
Sismicità storica e sismicità strumentale contribuiscono<br />
con pari dignità alla conoscenza delle caratteristiche sismiche<br />
di una regione. La sismicità storica, tramite il recupero di informazioni<br />
macrosismiche sui sismi avvenuti prima del 1900,<br />
inizio delle registrazioni sismografi che nel mondo, contribuisce<br />
in maniera determinante alla costruzione di un catalogo di<br />
terremoti, fonte principale per tutte le analisi di sismicità regionale.<br />
La sismicità strumentale, d’altra parte, rappresenta la<br />
fonte più precisa per lo studio delle caratteristiche sismotettoniche<br />
di una regione in quanto permette, talvolta, associazioni<br />
tra terremoti e faglie. Sismicità storica e strumentale sono,<br />
dunque, due facce molto diverse del processo sismogenetico,<br />
ma nessuno studio fi nalizzato a comprendere la sismicità di<br />
una regione può prescindere da una delle due.<br />
La sismologia storica si basa strettamente su due componenti:<br />
quella sismologica e quella storica. L’esperto storico,<br />
meglio addirittura se specializzato sul periodo storico<br />
nel quale il sisma è avvenuto, è capace di individuare gli<br />
archivi, e negli archivi i repertori da cui è possibile attingere<br />
informazioni sull’evento studiato. Allo storico, ancora,<br />
è richiesta la capacità di tradurre in informazioni attuali le<br />
descrizioni lasciate da testimoni lontani nel passato e di contestualizzarle<br />
in funzione degli avvenimenti di quel tempo.<br />
A titolo di esempio, possiamo dire che l’entità del danno<br />
causato da un terremoto può essere dedotta dalla lettura di<br />
documenti disparati quali i verbali dell’autorità comunale<br />
preposta alla ricostruzione dell’edifi cato, mentre l’impatto<br />
sociale può essere ricavato anche dal libro parrocchiale dei<br />
morti. Ma l’individuazione delle fonti utili per descrivere un<br />
terremoto possono essere le più svariate e, talvolta, il loro<br />
reperimento risulta del tutto casuale. Chi potrebbe andare a<br />
cercare, per esempio, notizie di un terremoto in un libro sacro?<br />
Ed invece, in una Bibbia è stata trovata la nota di un ecclesiastico<br />
che, avvertendo il terremoto del 1511 a Cividale,<br />
ha scritto quanto accadeva intorno a lui. Anche da capitelli<br />
e lapidi è possibile avere notizie. La ricostruzione di edifi ci<br />
monumentali viene spesso testimoniata da una lapide che<br />
ricorda ai posteri l’opera compiuta e le motivazioni dell’intervento,<br />
con ampio riconoscimento all’esecutore.<br />
Lo studio dei terremoti del passato richiede metodologie di indagine particolari<br />
che necessitano l’esperienza di esperti storici, oltre che quella<br />
di sismologi. Sono studi piuttosto onerosi sia in termini di tempo che in<br />
termini di fondi da destinare. Il risultato è spesso importantissimo per<br />
la conoscenza <strong>della</strong> sismicità regionale, poiché regioni come l’Italia sono<br />
caratterizzate da sismi forti con un periodo di ritorno molto lungo, anche<br />
diversi secoli. Tali eventi sono raramente corredati da registrazioni<br />
strumentali, che in Italia sono iniziate solo alla fi ne del diciannovesimo<br />
secolo, e solo lo studio macrosismico può aiutare nell’individuazione dei<br />
parametri focali del terremoto, informazione di base per qualsiasi studio<br />
fi nalizzato alla conoscenza del rischio sismico.<br />
Oltre a tutto questo, il terremoto lascia tracce talvolta nei<br />
manufatti stessi. Ecco, allora, che la ricostruzione dell’evento<br />
non può prescindere dalla consulenza di architetti ed ingegneri,<br />
che sono in grado di riconoscere gli interventi di<br />
ricostruzione o restauro e di datare le diverse parti dell’edifi<br />
cio. Questa operazione permette talvolta di evidenziare i<br />
probabili danni subiti in un certo periodo: ne può derivare<br />
l’associazione con un fenomeno sismico, sempre tenendo in<br />
giusta considerazione i margini di errore insiti in un’operazione<br />
di questo tipo.<br />
Figura 1 – Veduta <strong>della</strong> Tor Grande di fronte al porto di Trieste (tratta<br />
da Scussa e Kandler, 1863). Sulla lapide sotto l’orologio si legge: ”MA-<br />
XIMILLIANVS CAESAR TVRRIM VENETIS PRIUS MACHINIS CONCVSSAM<br />
TERRAEMOTV DEINDE HORRIBILI PENE DESTRVCTAM CIVITATI BENEME-<br />
RENTI RESTAVRARI IVSSIT. ANNO SALVTIS MDXVII”.<br />
<strong>Un</strong> esempio in tal senso è relativo al forte terremoto che<br />
nel 1117 sconvolse gran parte <strong>della</strong> Pianura Padana. Per esso è<br />
Geoitalia 36, 2011 37