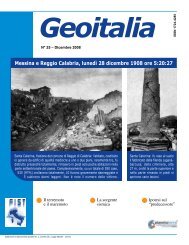Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
Un discorso epistemologico sulla complessità nelle Scienze della
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Orologi chimici<br />
Il <strong>discorso</strong> va gradatamente più in là quando si osserva il<br />
comportamento di certe reazioni chimiche. Anche qui, sempre<br />
in condizioni lontane dall’equilibrio, oltre certe soglie<br />
critiche di instabilità chimica si osservano comportamenti<br />
totalmente inaspettati, che vanno oltre la semplice autoorganizzazione.<br />
Si pensi ad esempio ai cosiddetti “orologi<br />
chimici’’: semplici reazioni spesso auto catalizzate (nel senso<br />
che il prodotto di una reazione chimica è coinvolto nella<br />
sua propria sintesi), che evolvono verso uno stato stazionario<br />
stabile fi nché non venga superato un certo valore-soglia<br />
<strong>della</strong> concentrazione di uno dei componenti, nel qual caso lo<br />
stato stazionario diviene un fuoco instabile ed il sistema lo<br />
abbandona per dirigersi verso un ciclo-limite. Invece di rimanere<br />
stazionarie in un nuovo equilibrio, le concentrazioni<br />
dei componenti principali cominciano ad oscillare con un<br />
periodo di oscillazione ben defi nito.<br />
Il comportamento periodico adottato dal sistema è stabile,<br />
è un vero orologio chimico.<br />
Supponiamo, come esemplifi cano Prigogine e Stengers<br />
(1981), di avere due tipi di molecole coinvolte in un recipiente<br />
nella reazione, “rosse” e “blu’’.A causa del moto caotico<br />
delle molecole, ci aspetteremmo che in un dato momento<br />
ci possano essere più molecole rosse in una parte del<br />
recipiente, per esempio quella di sinistra. Ma poco dopo<br />
compariranno più molecole blu, e così via. Il recipiente dovrebbe<br />
sembrarci “violetto’’ con lampi irregolari di rosso o<br />
di blu. Ma questo non succede con un orologio chimico; il<br />
sistema è tutto blu, poi improvvisamente il suo colore diventa<br />
rosso, poi ancora blu. E tutti questi cambiamenti avvengono<br />
ad intervalli di tempo regolari: siamo di fronte ad un<br />
processo coerente.<br />
Questo sembra incredibile ed infatti, se gli orologi chimici<br />
non fossero stati effettivamente osservati, nessuno ci<br />
crederebbe. Per cambiare colore tutte in una volta le molecole<br />
hanno bisogno di comunicare. Il sistema deve agire<br />
come un tutto. Siamo qui in presenza di uno dei più semplici<br />
meccanismi chimici di comunicazione.<br />
Ad un livello un po’ più elevato possiamo collocare la<br />
recente realizzazione da parte dei chimici di sequenze relazionali<br />
“spontanee’’, che conducono da sistemi semplici a<br />
sistemi complessi attraverso la catalisi di coordinazione e<br />
soprattutto attraverso l’autoassemblaggio, che presuppone<br />
un elevato grado di riconoscimento molecolare, e la trasmissione<br />
di informazioni estremamente dettagliate e specifi<br />
che per costruire e poi replicare le molecole organiche (si<br />
veda ad esempio Chiusoli, 1995).<br />
Innumerevoli meccanismi chimici di questo tipo, sempre<br />
più complicati, caratterizzano infi ne i processi di comunicazione<br />
chimica ben noti ai biologi e ai neurofi siologi, e fanno<br />
già parte in modo essenziale dell’insieme di proprietà che<br />
defi niscono la vita.<br />
Processi irreversibili<br />
Ma torniamo al <strong>discorso</strong> di fondo. Sembra evidente che,<br />
indipendentemente dal campo in cui un sistema sta operando,<br />
e ben prima di giungere ai livelli biologici, non appena<br />
ci si sposta dallo stato di equilibrio a condizioni lontane da<br />
esso, entrano in gioco in modo sempre più decisivo i processi<br />
irreversibili, che sembrano costituire la base di molti<br />
processi di organizzazione spontanea e di comunicazione.<br />
Quanto più il sistema si sposta dallo stato di equilibrio, tanto<br />
più si sposta dal ripetitivo e dall’universale verso lo specifi<br />
co e l’unico.<br />
In termini antropomorfi ci, in condizioni di lontananza<br />
dall’equilibrio la materia comincia ad essere capace di percepire<br />
differenze nel mondo esterno, scambia messaggi, si<br />
auto-organizza, può reagire con grandi effetti a piccole cause,<br />
può trovarsi di fronte a biforcazioni: una piccola fl uttuazione<br />
potrà allora dare inizio ad una nuova evoluzione che<br />
cambierà drasticamente l’intero comportamento del sistema<br />
macroscopico.<br />
Possiamo resistere alla tentazione di estendere il <strong>discorso</strong><br />
a tutto il cosmo, ben lontano dall’equilibrio nel suo complesso,<br />
o addirittura ai sistemi sociali, alla storia umana?<br />
Noi ci dovremmo invece chiedere, a questo punto, se non<br />
esistano gradi diversi di <strong>complessità</strong>, e quali siano i parametri-base<br />
per defi nirli. Senza addentrarci troppo in disquisizioni<br />
fi losofi che o nominalistiche, il comportamento del<br />
Sistema Terra, tanto per entrare nel vivo <strong>della</strong> nostra discussione,<br />
ha degli aspetti tali da richiamare i concetti-base <strong>della</strong><br />
<strong>complessità</strong>, così come sono emersi fi nora?<br />
Informazione mancante o proprietà intrinseca<br />
Nel dibattito tra chi sosteneva che la <strong>complessità</strong> di un<br />
sistema fosse solo l’informazione mancante sul suo funzionamento,<br />
e chi invece la riteneva un elemento essenziale,<br />
una proprietà intrinseca che non scompare anche quando il<br />
funzionamento del sistema può essere ricostruito completamente<br />
a partire dai suoi elementi semplici, i geologi non<br />
presero posizione. Erano semplicemente assenti.<br />
Nel 1996 si è tenuto a Santa Fe (New Mexico) il primo<br />
congresso internazionale sui sistemi complessi <strong>nelle</strong> <strong>Scienze</strong><br />
<strong>della</strong> Terra, ma fi no a quindici-venti anni prima la cosa<br />
sarebbe apparsa incomprensibile. Era come se il problema<br />
non interessasse più di tanto, che riguardasse altri, mentre<br />
l’approccio riduzionista continuava a dominare sia nella formazione<br />
del geologo che <strong>nelle</strong> metodologie di studio, un po’<br />
in tutto il mondo.<br />
E così lo stesso dibattito su Gaia, che in qualche modo<br />
appassionò una gran parte del mondo scientifi co, non trovò<br />
grande eco proprio tra i più diretti interessati, gli studiosi<br />
<strong>della</strong> Terra. Né il nascente dibattito sul costruttivismo attirò<br />
più di una occhiata distratta.<br />
Era invece giunto il momento in cui, svanite le antiche<br />
Geoitalia 36, 2011 9