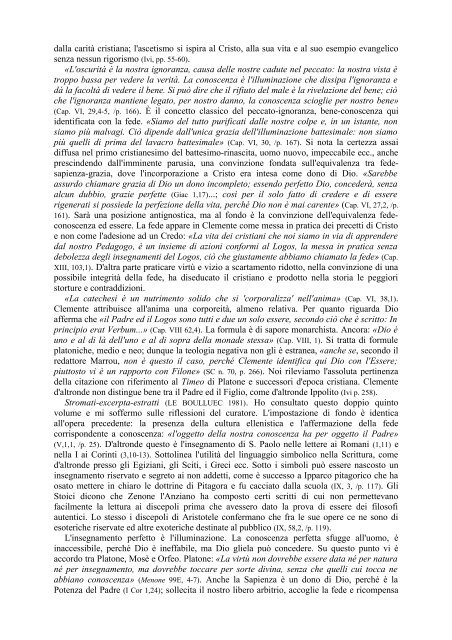L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dalla carità cristiana; l'ascetismo si ispira al Cristo, alla sua vita e al suo esempio evangelico<br />
senza nessun rigorismo (Ivi, pp. 55-60).<br />
«L'oscurità è la nostra ignoranza, causa <strong>delle</strong> nostre cadute <strong>nel</strong> peccato: la nostra vista è<br />
troppo bassa per vedere la verità. La conoscenza è l'illuminazione che <strong>di</strong>ssipa l'ignoranza e<br />
dà la facoltà <strong>di</strong> vedere il bene. Si può <strong>di</strong>re che il rifiuto del male è la rivelazione del bene; ciò<br />
che l'ignoranza mantiene legato, per nostro danno, la conoscenza scioglie per nostro bene»<br />
(Cap. VI, 29,4-5, /p. 166). È il concetto classico del peccato-ignoranza, bene-conoscenza qui<br />
identificata con la fede. «Siamo del tutto purificati dalle nostre colpe e, in un istante, non<br />
siamo più malvagi. Ciò <strong>di</strong>pende dall'unica grazia dell'illuminazione battesimale: non siamo<br />
più quelli <strong>di</strong> prima del lavacro battesimale» (Cap. VI, 30, /p. 167). Si nota la certezza assai<br />
<strong>di</strong>ffusa <strong>nel</strong> primo cristianesimo del battesimo-rinascita, uomo nuovo, impeccabile ecc., anche<br />
prescindendo dall'imminente parusia, una convinzione fondata sull'equivalenza tra fedesapienza-grazia,<br />
dove l'incorporazione a Cristo era intesa come dono <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>. «Sarebbe<br />
assurdo chiamare grazia <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> un dono incompleto; essendo perfetto <strong>Dio</strong>, concederà, senza<br />
alcun dubbio, grazie perfette (Giac 1,17)...; così per il solo fatto <strong>di</strong> credere e <strong>di</strong> essere<br />
rigenerati si possiede la perfezione della vita, perché <strong>Dio</strong> non è mai carente» (Cap. VI, 27,2, /p.<br />
161). Sarà una posizione antignostica, ma al fondo è la convinzione dell'equivalenza fedeconoscenza<br />
ed essere. La fede appare in Clemente come messa in pratica dei precetti <strong>di</strong> Cristo<br />
e non come l'adesione ad un Credo: «La vita dei cristiani che noi siamo in via <strong>di</strong> apprendere<br />
dal nostro Pedagogo, è un insieme <strong>di</strong> azioni conformi al Logos, la messa in pratica senza<br />
debolezza degli insegnamenti del Logos, ciò che giustamente abbiamo chiamato la fede» (Cap.<br />
XIII, 103,1). D'altra parte praticare virtù e vizio a scartamento ridotto, <strong>nel</strong>la convinzione <strong>di</strong> una<br />
possibile integrità della fede, ha <strong>di</strong>seducato il cristiano e prodotto <strong>nel</strong>la storia le peggiori<br />
storture e contrad<strong>di</strong>zioni.<br />
«La catechesi è un nutrimento solido che si 'corporalizza' <strong>nel</strong>l'anima» (Cap. VI, 38,1).<br />
Clemente attribuisce all'anima una corporeità, almeno relativa. Per quanto riguarda <strong>Dio</strong><br />
afferma che «il Padre ed il Logos sono tutti e due un solo essere, secondo ciò che è scritto: In<br />
principio erat Verbum...» (Cap. VIII 62,4). La formula è <strong>di</strong> sapore monarchista. Ancora: «<strong>Dio</strong> è<br />
uno e al <strong>di</strong> là dell'uno e al <strong>di</strong> sopra della monade stessa» (Cap. VIII, 1). Si tratta <strong>di</strong> formule<br />
platoniche, me<strong>di</strong>o e neo; dunque la teologia negativa non gli è estranea, «anche se, secondo il<br />
redattore Marrou, non è questo il caso, perché Clemente identifica qui <strong>Dio</strong> con l'Essere;<br />
piuttosto vi è un rapporto con Filone» (SC n. 70, p. 266). Noi rileviamo l'assoluta pertinenza<br />
della citazione con riferimento al Timeo <strong>di</strong> Platone e successori d'epoca cristiana. Clemente<br />
d'altronde non <strong>di</strong>stingue bene tra il Padre ed il Figlio, come d'altronde Ippolito (Ivi p. 258).<br />
Stromati-excerpta-estratti (LE BOULLUEC 1981). Ho consultato questo doppio quinto<br />
volume e mi soffermo sulle riflessioni del curatore. L'impostazione <strong>di</strong> fondo è identica<br />
all'opera precedente: la presenza della cultura ellenistica e l'affermazione della fede<br />
corrispondente a conoscenza: «l'oggetto della nostra conoscenza ha per oggetto il Padre»<br />
(V,1,1, /p. 25). D'altronde questo è l'insegnamento <strong>di</strong> S. Paolo <strong>nel</strong>le lettere ai Romani (1,11) e<br />
<strong>nel</strong>la I ai Corinti (3,10-13). Sottolinea l'utilità del linguaggio simbolico <strong>nel</strong>la Scrittura, come<br />
d'altronde presso gli Egiziani, gli Sciti, i Greci ecc. Sotto i simboli può essere nascosto un<br />
insegnamento riservato e segreto ai non addetti, come è successo a Ipparco pitagorico che ha<br />
osato mettere in chiaro le dottrine <strong>di</strong> Pitagora e fu cacciato dalla scuola (IX, 3, /p. 117). Gli<br />
Stoici <strong>di</strong>cono che Zenone l'Anziano ha composto certi scritti <strong>di</strong> cui non permettevano<br />
facilmente la lettura ai <strong>di</strong>scepoli prima che avessero dato la prova <strong>di</strong> essere dei filosofi<br />
autentici. Lo stesso i <strong>di</strong>scepoli <strong>di</strong> Aristotele confermano che fra le sue opere ce ne sono <strong>di</strong><br />
esoteriche riservate ed altre exoteriche destinate al pubblico (IX, 58,2, /p. 119).<br />
L'insegnamento perfetto è l'illuminazione. La conoscenza perfetta sfugge all'uomo, è<br />
inaccessibile, perché <strong>Dio</strong> è ineffabile, ma <strong>Dio</strong> gliela può concedere. Su questo punto vi è<br />
accordo tra Platone, Mosè e Orfeo. Platone: «La virtù non dovrebbe essere data né per natura<br />
né per insegnamento, ma dovrebbe toccare per sorte <strong>di</strong>vina, senza che quelli cui tocca ne<br />
abbiano conoscenza» (Menone 99E, 4-7). Anche la Sapienza è un dono <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>, perché è la<br />
Potenza del Padre (I Cor 1,24); sollecita il nostro libero arbitrio, accoglie la fede e ricompensa