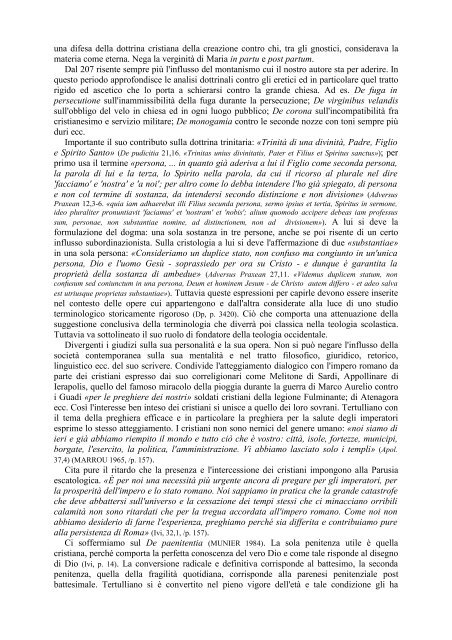L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
una <strong>di</strong>fesa della dottrina cristiana della creazione contro chi, tra gli gnostici, considerava la<br />
materia come eterna. Nega la verginità <strong>di</strong> Maria in partu e post partum.<br />
Dal 207 risente sempre più l'influsso del montanismo cui il nostro autore sta per aderire. In<br />
questo periodo approfon<strong>di</strong>sce le analisi dottrinali contro gli eretici ed in particolare quel tratto<br />
rigido ed ascetico che lo porta a schierarsi contro la grande chiesa. Ad es. De fuga in<br />
persecutione sull'inammissibilità della fuga durante la persecuzione; De virginibus velan<strong>di</strong>s<br />
sull'obbligo del velo in chiesa ed in ogni luogo pubblico; De corona sull'incompatibilità fra<br />
cristianesimo e servizio militare; De monogamia contro le seconde nozze con toni sempre più<br />
duri ecc.<br />
Importante il suo contributo sulla dottrina trinitaria: «Trinità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>vinità, Padre, Figlio<br />
e Spirito Santo» (De pu<strong>di</strong>citia 21,16. «Trinitas unius <strong>di</strong>vinitatis, Pater et Filius et Spiritus sanctus»); per<br />
primo usa il termine «persona, ... in quanto già aderiva a lui il Figlio come seconda persona,<br />
la parola <strong>di</strong> lui e la terza, lo Spirito <strong>nel</strong>la parola, da cui il ricorso al plurale <strong>nel</strong> <strong>di</strong>re<br />
'facciamo' e 'nostra' e 'a noi'; per altro come lo debba intendere l'ho già spiegato, <strong>di</strong> persona<br />
e non col termine <strong>di</strong> sostanza, da intendersi secondo <strong>di</strong>stinzione e non <strong>di</strong>visione» (Adversus<br />
Praxean 12,3-6. «quia iam adhaerebat illi Filius secunda persona, sermo ipsius et tertia, Spiritus in sermone,<br />
ideo pluraliter pronuntiavit 'faciamus' et 'nostram' et 'nobis'; alium quomodo accipere debeas iam professus<br />
sum, personae, non substantiae nomine, ad <strong>di</strong>stinctionem, non ad <strong>di</strong>visionem»). A lui si deve la<br />
formulazione del dogma: una sola sostanza in tre persone, anche se poi risente <strong>di</strong> un certo<br />
influsso subor<strong>di</strong>nazionista. Sulla cristologia a lui si deve l'affermazione <strong>di</strong> due «substantiae»<br />
in una sola persona: «Consideriamo un duplice stato, non confuso ma congiunto in un'unica<br />
persona, <strong>Dio</strong> e l'uomo Gesù - soprassiedo per ora su Cristo - e dunque è garantita la<br />
proprietà della sostanza <strong>di</strong> ambedue» (Adversus Praxean 27,11. «Videmus duplicem statum, non<br />
confusum sed coniunctum in una persona, Deum et hominem Jesum - de Christo autem <strong>di</strong>ffero - et adeo salva<br />
est utriusque proprietas substantiae»). Tuttavia queste espressioni per capirle devono essere inserite<br />
<strong>nel</strong> contesto <strong>delle</strong> opere cui appartengono e dall'altra considerate alla luce <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o<br />
terminologico storicamente rigoroso (Dp, p. 3420). Ciò che comporta una attenuazione della<br />
suggestione conclusiva della terminologia che <strong>di</strong>verrà poi classica <strong>nel</strong>la teologia scolastica.<br />
Tuttavia va sottolineato il suo ruolo <strong>di</strong> fondatore della teologia occidentale.<br />
Divergenti i giu<strong>di</strong>zi sulla sua personalità e la sua opera. Non si può negare l'influsso della<br />
società contemporanea sulla sua mentalità e <strong>nel</strong> tratto filosofico, giuri<strong>di</strong>co, retorico,<br />
linguistico ecc. del suo scrivere. Con<strong>di</strong>vide l'atteggiamento <strong>di</strong>alogico con l'impero romano da<br />
parte dei cristiani espresso dai suo correligionari come Melitone <strong>di</strong> Sar<strong>di</strong>, Appollinare <strong>di</strong><br />
Ierapolis, quello del famoso miracolo della pioggia durante la guerra <strong>di</strong> Marco Aurelio contro<br />
i Gua<strong>di</strong> «per le preghiere dei nostri» soldati cristiani della legione Fulminante; <strong>di</strong> Atenagora<br />
ecc. Così l'interesse ben inteso dei cristiani si unisce a quello dei loro sovrani. Tertulliano con<br />
il tema della preghiera efficace e in particolare la preghiera per la salute degli imperatori<br />
esprime lo stesso atteggiamento. I cristiani non sono nemici del genere umano: «noi siamo <strong>di</strong><br />
ieri e già abbiamo riempito il mondo e tutto ciò che è vostro: città, isole, fortezze, municipi,<br />
borgate, l'esercito, la politica, l'amministrazione. Vi abbiamo lasciato solo i templi» (Apol.<br />
37,4) (MARROU 1965, /p. 157).<br />
Cita pure il ritardo che la presenza e l'intercessione dei cristiani impongono alla Parusia<br />
escatologica. «È per noi una necessità più urgente ancora <strong>di</strong> pregare per gli imperatori, per<br />
la prosperità dell'impero e lo stato romano. Noi sappiamo in pratica che la grande catastrofe<br />
che deve abbattersi sull'universo e la cessazione dei tempi stessi che ci minacciano orribili<br />
calamità non sono ritardati che per la tregua accordata all'impero romano. Come noi non<br />
abbiamo desiderio <strong>di</strong> farne l'esperienza, preghiamo perché sia <strong>di</strong>fferita e contribuiamo pure<br />
alla persistenza <strong>di</strong> Roma» (Ivi, 32,1, /p. 157).<br />
Ci soffermiamo sul De paenitentia (MUNIER 1984). La sola penitenza utile è quella<br />
cristiana, perché comporta la perfetta conoscenza del vero <strong>Dio</strong> e come tale risponde al <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong> <strong>Dio</strong> (Ivi, p. 14). La conversione ra<strong>di</strong>cale e definitiva corrisponde al battesimo, la seconda<br />
penitenza, quella della fragilità quoti<strong>di</strong>ana, corrisponde alla parenesi penitenziale post<br />
battesimale. Tertulliano si è convertito <strong>nel</strong> pieno vigore dell'età e tale con<strong>di</strong>zione gli ha