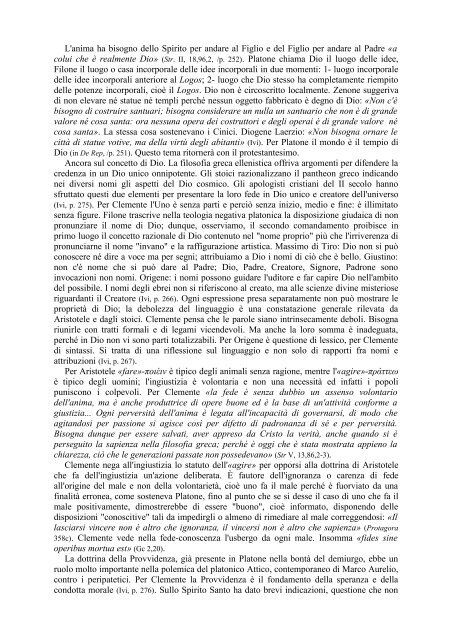L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L'anima ha bisogno dello Spirito per andare al Figlio e del Figlio per andare al Padre «a<br />
colui che è realmente <strong>Dio</strong>» (Str. II, 18,96,2, /p. 252). Platone chiama <strong>Dio</strong> il luogo <strong>delle</strong> idee,<br />
Filone il luogo o casa incorporale <strong>delle</strong> idee incorporali in due momenti: 1- luogo incorporale<br />
<strong>delle</strong> idee incorporali anteriore al Logos; 2- luogo che <strong>Dio</strong> stesso ha completamente riempito<br />
<strong>delle</strong> potenze incorporali, cioè il Logos. <strong>Dio</strong> non è circoscritto localmente. Zenone suggeriva<br />
<strong>di</strong> non elevare né statue né templi perché nessun oggetto fabbricato è degno <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>: «Non c'è<br />
bisogno <strong>di</strong> costruire santuari; bisogna considerare un nulla un santuario che non è <strong>di</strong> grande<br />
valore né cosa santa: ora nessuna opera dei costruttori e degli operai è <strong>di</strong> grande valore né<br />
cosa santa». La stessa cosa sostenevano i Cinici. <strong>Dio</strong>gene Laerzio: «Non bisogna ornare le<br />
città <strong>di</strong> statue votive, ma della virtù degli abitanti» (Ivi). Per Platone il mondo è il tempio <strong>di</strong><br />
<strong>Dio</strong> (in De Rep, /p. 251). Questo tema ritornerà con il protestantesimo.<br />
Ancora sul concetto <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>. La filosofia greca ellenistica offriva argomenti per <strong>di</strong>fendere la<br />
credenza in un <strong>Dio</strong> unico onnipotente. Gli stoici razionalizzano il pantheon greco in<strong>di</strong>cando<br />
nei <strong>di</strong>versi nomi gli aspetti del <strong>Dio</strong> cosmico. Gli apologisti cristiani del II secolo hanno<br />
sfruttato questi due elementi per presentare la loro fede in <strong>Dio</strong> unico e creatore dell'universo<br />
(Ivi, p. 275). Per Clemente l'Uno è senza parti e perciò senza inizio, me<strong>di</strong>o e fine: è illimitato<br />
senza figure. Filone trascrive <strong>nel</strong>la teologia negativa platonica la <strong>di</strong>sposizione giudaica <strong>di</strong> non<br />
pronunziare il nome <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>; dunque, osserviamo, il secondo comandamento proibisce in<br />
primo luogo il concetto razionale <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> contenuto <strong>nel</strong> "nome proprio" più che l'irriverenza <strong>di</strong><br />
pronunciarne il nome "invano" e la raffigurazione artistica. Massimo <strong>di</strong> Tiro: <strong>Dio</strong> non si può<br />
conoscere né <strong>di</strong>re a voce ma per segni; attribuiamo a <strong>Dio</strong> i nomi <strong>di</strong> ciò che è bello. Giustino:<br />
non c'è nome che si può dare al Padre; <strong>Dio</strong>, Padre, Creatore, Signore, Padrone sono<br />
invocazioni non nomi. Origene: i nomi possono guidare l'u<strong>di</strong>tore e far capire <strong>Dio</strong> <strong>nel</strong>l'ambito<br />
del possibile. I nomi degli ebrei non si riferiscono al creato, ma alle scienze <strong>di</strong>vine misteriose<br />
riguardanti il Creatore (Ivi, p. 266). Ogni espressione presa separatamente non può mostrare le<br />
proprietà <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>; la debolezza del linguaggio è una constatazione generale rilevata da<br />
Aristotele e dagli stoici. Clemente pensa che le parole siano intrinsecamente deboli. Bisogna<br />
riunirle con tratti formali e <strong>di</strong> legami vicendevoli. Ma anche la loro somma è inadeguata,<br />
perché in <strong>Dio</strong> non vi sono parti totalizzabili. Per Origene è questione <strong>di</strong> lessico, per Clemente<br />
<strong>di</strong> sintassi. Si tratta <strong>di</strong> una riflessione sul linguaggio e non solo <strong>di</strong> rapporti fra nomi e<br />
attribuzioni (Ivi, p. 267).<br />
Per Aristotele «fare»-ποιέιν è tipico degli animali senza ragione, mentre l'«agire»-πράττεω<br />
è tipico degli uomini; l'ingiustizia è volontaria e non una necessità ed infatti i popoli<br />
puniscono i colpevoli. Per Clemente «la fede è senza dubbio un assenso volontario<br />
dell'anima, ma è anche produttrice <strong>di</strong> opere buone ed è la base <strong>di</strong> un'attività conforme a<br />
giustizia... Ogni perversità dell'anima è legata all'incapacità <strong>di</strong> governarsi, <strong>di</strong> modo che<br />
agitandosi per passione si agisce così per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> padronanza <strong>di</strong> sé e per perversità.<br />
Bisogna dunque per essere salvati, aver appreso da Cristo la verità, anche quando si è<br />
perseguito la sapienza <strong>nel</strong>la filosofia greca; perché è oggi che è stata mostrata appieno la<br />
chiarezza, ciò che le generazioni passate non possedevano» (Str V, 13,86,2-3).<br />
Clemente nega all'ingiustizia lo statuto dell'«agire» per opporsi alla dottrina <strong>di</strong> Aristotele<br />
che fa dell'ingiustizia un'azione deliberata. È fautore dell'ignoranza o carenza <strong>di</strong> fede<br />
all'origine del male e non della volontarietà, cioè uno fa il male perché è fuorviato da una<br />
finalità erronea, come sosteneva Platone, fino al punto che se si desse il caso <strong>di</strong> uno che fa il<br />
male positivamente, <strong>di</strong>mostrerebbe <strong>di</strong> essere "buono", cioè informato, <strong>di</strong>sponendo <strong>delle</strong><br />
<strong>di</strong>sposizioni "conoscitive" tali da impe<strong>di</strong>rgli o almeno <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>are al male correggendosi: «Il<br />
lasciarsi vincere non è altro che ignoranza, il vincersi non è altro che sapienza» (Protagora<br />
358c). Clemente vede <strong>nel</strong>la fede-conoscenza l'usbergo da ogni male. Insomma «fides sine<br />
operibus mortua est» (Gc 2,20).<br />
La dottrina della Provvidenza, già presente in Platone <strong>nel</strong>la bontà del demiurgo, ebbe un<br />
ruolo molto importante <strong>nel</strong>la polemica del platonico Attico, contemporaneo <strong>di</strong> Marco Aurelio,<br />
contro i peripatetici. Per Clemente la Provvidenza è il fondamento della speranza e della<br />
condotta morale (Ivi, p. 276). Sullo Spirito Santo ha dato brevi in<strong>di</strong>cazioni, questione che non