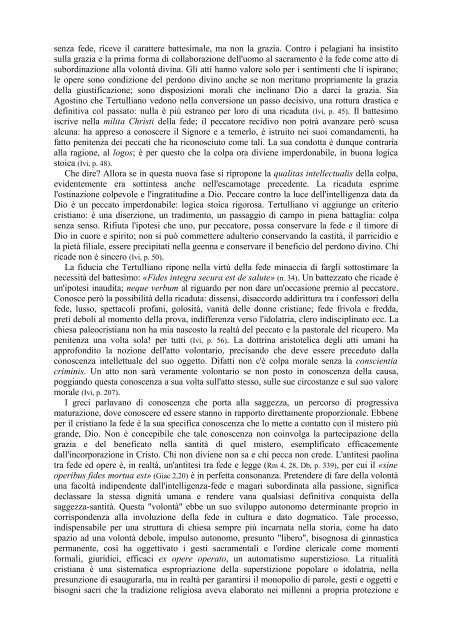L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
senza fede, riceve il carattere battesimale, ma non la grazia. Contro i pelagiani ha insistito<br />
sulla grazia e la prima forma <strong>di</strong> collaborazione dell'uomo al sacramento è la fede come atto <strong>di</strong><br />
subor<strong>di</strong>nazione alla volontà <strong>di</strong>vina. Gli atti hanno valore solo per i sentimenti che li ispirano;<br />
le opere sono con<strong>di</strong>zione del perdono <strong>di</strong>vino anche se non meritano propriamente la grazia<br />
della giustificazione; sono <strong>di</strong>sposizioni morali che inclinano <strong>Dio</strong> a darci la grazia. Sia<br />
Agostino che Tertulliano vedono <strong>nel</strong>la conversione un passo decisivo, una rottura drastica e<br />
definitiva col passato: nulla è più estraneo per loro <strong>di</strong> una ricaduta (Ivi, p. 45). Il battesimo<br />
iscrive <strong>nel</strong>la milita Christi della fede; il peccatore reci<strong>di</strong>vo non potrà avanzare però scusa<br />
alcuna: ha appreso a conoscere il Signore e a temerlo, è istruito nei suoi comandamenti, ha<br />
fatto penitenza dei peccati che ha riconosciuto come tali. La sua condotta è dunque contraria<br />
alla ragione, al logos; è per questo che la colpa ora <strong>di</strong>viene imperdonabile, in buona logica<br />
stoica (Ivi, p. 48).<br />
Che <strong>di</strong>re? Allora se in questa nuova fase si ripropone la qualitas intellectualis della colpa,<br />
evidentemente era sottintesa anche <strong>nel</strong>l'escamotage precedente. La ricaduta esprime<br />
l'ostinazione colpevole e l'ingratitu<strong>di</strong>ne a <strong>Dio</strong>. Peccare contro la luce dell'intelligenza data da<br />
<strong>Dio</strong> è un peccato imperdonabile: logica stoica rigorosa. Tertulliano vi aggiunge un criterio<br />
cristiano: è una <strong>di</strong>serzione, un tra<strong>di</strong>mento, un passaggio <strong>di</strong> campo in piena battaglia: colpa<br />
senza senso. Rifiuta l'ipotesi che uno, pur peccatore, possa conservare la fede e il timore <strong>di</strong><br />
<strong>Dio</strong> in cuore e spirito; non si può commettere adulterio conservando la castità, il parrici<strong>di</strong>o e<br />
la pietà filiale, essere precipitati <strong>nel</strong>la geenna e conservare il beneficio del perdono <strong>di</strong>vino. Chi<br />
ricade non è sincero (Ivi, p. 50).<br />
La fiducia che Tertulliano ripone <strong>nel</strong>la virtù della fede minaccia <strong>di</strong> fargli sottostimare la<br />
necessità del battesimo: «Fides integra secura est de salute» (n. 34). Un battezzato che ricade è<br />
un'ipotesi inau<strong>di</strong>ta; neque verbum al riguardo per non dare un'occasione premio al peccatore.<br />
Conosce però la possibilità della ricaduta: <strong>di</strong>ssensi, <strong>di</strong>saccordo ad<strong>di</strong>rittura tra i confessori della<br />
fede, lusso, spettacoli profani, golosità, vanità <strong>delle</strong> donne cristiane; fede frivola e fredda,<br />
preti deboli al momento della prova, in<strong>di</strong>fferenza verso l'idolatria, clero in<strong>di</strong>sciplinato ecc. La<br />
chiesa paleocristiana non ha mia nascosto la realtà del peccato e la pastorale del ricupero. Ma<br />
penitenza una volta sola! per tutti (Ivi, p. 56). La dottrina aristotelica degli atti umani ha<br />
approfon<strong>di</strong>to la nozione dell'atto volontario, precisando che deve essere preceduto dalla<br />
conoscenza intellettuale del suo oggetto. Difatti non c'è colpa morale senza la conscientia<br />
criminis. Un atto non sarà veramente volontario se non posto in conoscenza della causa,<br />
poggiando questa conoscenza a sua volta sull'atto stesso, sulle sue circostanze e sul suo valore<br />
morale (Ivi, p. 207).<br />
I greci parlavano <strong>di</strong> conoscenza che porta alla saggezza, un percorso <strong>di</strong> progressiva<br />
maturazione, dove conoscere ed essere stanno in rapporto <strong>di</strong>rettamente proporzionale. Ebbene<br />
per il cristiano la fede è la sua specifica conoscenza che lo mette a contatto con il mistero più<br />
grande, <strong>Dio</strong>. Non è concepibile che tale conoscenza non coinvolga la partecipazione della<br />
grazia e del beneficato <strong>nel</strong>la santità <strong>di</strong> quel mistero, esemplificato efficacemente<br />
dall'incorporazione in Cristo. Chi non <strong>di</strong>viene non sa e chi pecca non crede. L'antitesi paolina<br />
tra fede ed opere è, in realtà, un'antitesi tra fede e legge (Rm 4, 28, Db, p. 339), per cui il «sine<br />
operibus fides mortua est» (Giac 2,20) è in perfetta consonanza. Pretendere <strong>di</strong> fare della volontà<br />
una facoltà in<strong>di</strong>pendente dall'intelligenza-fede e magari subor<strong>di</strong>nata alla passione, significa<br />
declassare la stessa <strong>di</strong>gnità umana e rendere vana qualsiasi definitiva conquista della<br />
saggezza-santità. Questa "volontà" ebbe un suo sviluppo autonomo determinante proprio in<br />
corrispondenza alla involuzione della fede in cultura e dato dogmatico. Tale processo,<br />
in<strong>di</strong>spensabile per una struttura <strong>di</strong> chiesa sempre più incarnata <strong>nel</strong>la storia, come ha dato<br />
spazio ad una volontà debole, impulso autonomo, presunto "libero", bisognosa <strong>di</strong> ginnastica<br />
permanente, così ha oggettivato i gesti sacramentali e l'or<strong>di</strong>ne clericale come momenti<br />
formali, giuri<strong>di</strong>ci, efficaci ex opere operato, un automatismo superstizioso. La ritualità<br />
cristiana è una sistematica espropriazione della superstizione popolare o idolatria, <strong>nel</strong>la<br />
presunzione <strong>di</strong> esaugurarla, ma in realtà per garantirsi il monopolio <strong>di</strong> parole, gesti e oggetti e<br />
bisogni sacri che la tra<strong>di</strong>zione religiosa aveva elaborato nei millenni a propria protezione e