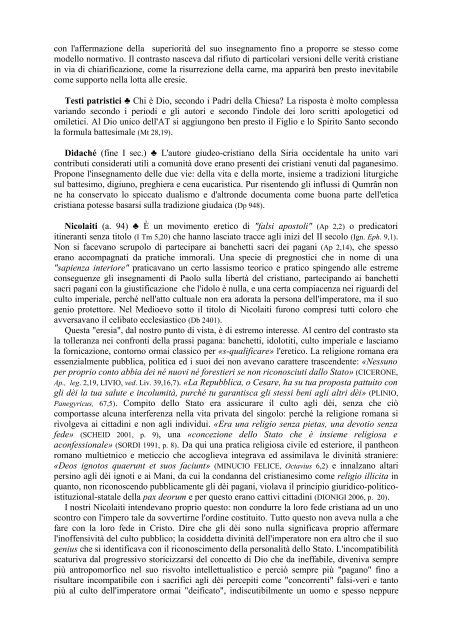L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
con l'affermazione della superiorità del suo insegnamento fino a proporre se stesso come<br />
modello normativo. Il contrasto nasceva dal rifiuto <strong>di</strong> particolari versioni <strong>delle</strong> verità cristiane<br />
in via <strong>di</strong> chiarificazione, come la risurrezione della carne, ma apparirà ben presto inevitabile<br />
come supporto <strong>nel</strong>la lotta alle eresie.<br />
Testi patristici ♣ Chi è <strong>Dio</strong>, secondo i Padri della Chiesa? La risposta è molto complessa<br />
variando secondo i perio<strong>di</strong> e gli autori e secondo l'indole dei loro scritti apologetici od<br />
omiletici. Al <strong>Dio</strong> unico dell'AT si aggiungono ben presto il Figlio e lo Spirito Santo secondo<br />
la formula battesimale (Mt 28,19).<br />
Didaché (fine I sec.) ♣ L'autore giudeo-cristiano della Siria occidentale ha unito vari<br />
contributi considerati utili a comunità dove erano presenti dei cristiani venuti dal paganesimo.<br />
Propone l'insegnamento <strong>delle</strong> due vie: della vita e della morte, insieme a tra<strong>di</strong>zioni liturgiche<br />
sul battesimo, <strong>di</strong>giuno, preghiera e cena eucaristica. Pur risentendo gli influssi <strong>di</strong> Qumrân non<br />
ne ha conservato lo spiccato dualismo e d'altronde documenta come buona parte dell'etica<br />
cristiana potesse basarsi sulla tra<strong>di</strong>zione giudaica (Dp 948).<br />
Nicolaiti (a. 94) ♣ È un movimento eretico <strong>di</strong> "falsi apostoli" (Ap 2,2) o pre<strong>di</strong>catori<br />
itineranti senza titolo (I Tm 5,20) che hanno lasciato tracce agli inizi del II secolo (Ign. Eph. 9,1).<br />
Non si facevano scrupolo <strong>di</strong> partecipare ai banchetti sacri dei pagani (Ap 2,14), che spesso<br />
erano accompagnati da pratiche immorali. Una specie <strong>di</strong> pregnostici che in nome <strong>di</strong> una<br />
"sapienza interiore" praticavano un certo lassismo teorico e pratico spingendo alle estreme<br />
conseguenze gli insegnamenti <strong>di</strong> Paolo sulla libertà del cristiano, partecipando ai banchetti<br />
sacri pagani con la giustificazione che l'idolo è nulla, e una certa compiacenza nei riguar<strong>di</strong> del<br />
culto imperiale, perché <strong>nel</strong>l'atto cultuale non era adorata la persona dell'imperatore, ma il suo<br />
genio protettore. Nel Me<strong>di</strong>oevo sotto il titolo <strong>di</strong> Nicolaiti furono compresi tutti coloro che<br />
avversavano il celibato ecclesiastico (Db 2401).<br />
Questa "eresia", dal nostro punto <strong>di</strong> vista, è <strong>di</strong> estremo interesse. Al centro del contrasto sta<br />
la tolleranza nei confronti della prassi pagana: banchetti, idolotiti, culto imperiale e lasciamo<br />
la fornicazione, contorno ormai classico per «s-qualificare» l'eretico. La religione romana era<br />
essenzialmente pubblica, politica ed i suoi dei non avevano carattere trascendente: «Nessuno<br />
per proprio conto abbia dei né nuovi né forestieri se non riconosciuti dallo Stato» (CICERONE,<br />
Ap., leg. 2,19, LIVIO, ved. Liv. 39,16,7). «La Repubblica, o Cesare, ha su tua proposta pattuito con<br />
gli dèi la tua salute e incolumità, purché tu garantisca gli stessi beni agli altri dèi» (PLINIO,<br />
Panegyricus, 67,5). Compito dello Stato era assicurare il culto agli dèi, senza che ciò<br />
comportasse alcuna interferenza <strong>nel</strong>la vita privata del singolo: perché la religione romana si<br />
rivolgeva ai citta<strong>di</strong>ni e non agli in<strong>di</strong>vidui. «Era una religio senza pietas, una devotio senza<br />
fede» (SCHEID 2001, p. 9), una «concezione dello Stato che è insieme religiosa e<br />
aconfessionale» (SORDI 1991, p. 8). Da qui una pratica religiosa civile ed esteriore, il pantheon<br />
romano multietnico e meticcio che accoglieva integrava ed assimilava le <strong>di</strong>vinità straniere:<br />
«Deos ignotos quaerunt et suos faciunt» (MINUCIO FELICE, Octavius 6,2) e innalzano altari<br />
persino agli dèi ignoti e ai Mani, da cui la condanna del cristianesimo come religio illicita in<br />
quanto, non riconoscendo pubblicamente gli dèi pagani, violava il principio giuri<strong>di</strong>co-politicoistituzional-statale<br />
della pax deorum e per questo erano cattivi citta<strong>di</strong>ni (DIONIGI 2006, p. 20).<br />
I nostri Nicolaiti intendevano proprio questo: non condurre la loro fede cristiana ad un uno<br />
scontro con l'impero tale da sovvertirne l'or<strong>di</strong>ne costituito. Tutto questo non aveva nulla a che<br />
fare con la loro fede in Cristo. Dire che gli dèi sono nulla significava proprio affermare<br />
l'inoffensività del culto pubblico; la cosiddetta <strong>di</strong>vinità dell'imperatore non era altro che il suo<br />
genius che si identificava con il riconoscimento della personalità dello Stato. L'incompatibilità<br />
scaturiva dal progressivo storicizzarsi del concetto <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> che da ineffabile, <strong>di</strong>veniva sempre<br />
più antropomorfico <strong>nel</strong> suo risvolto intellettualistico e perciò sempre più "pagano" fino a<br />
risultare incompatibile con i sacrifici agli dèi percepiti come "concorrenti" falsi-veri e tanto<br />
più al culto dell'imperatore ormai "deificato", in<strong>di</strong>scutibilmente un uomo e spesso neppure