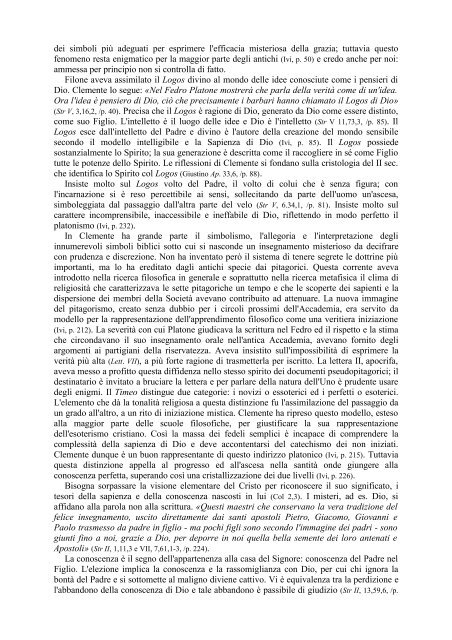L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
L'idea di Dio nel Cristianesimo delle origini - Dott. Faustino Nazzi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dei simboli più adeguati per esprimere l'efficacia misteriosa della grazia; tuttavia questo<br />
fenomeno resta enigmatico per la maggior parte degli antichi (Ivi, p. 50) e credo anche per noi:<br />
ammessa per principio non si controlla <strong>di</strong> fatto.<br />
Filone aveva assimilato il Logos <strong>di</strong>vino al mondo <strong>delle</strong> idee conosciute come i pensieri <strong>di</strong><br />
<strong>Dio</strong>. Clemente lo segue: «Nel Fedro Platone mostrerà che parla della verità come <strong>di</strong> un'idea.<br />
Ora l'idea è pensiero <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>, ciò che precisamente i barbari hanno chiamato il Logos <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>»<br />
(Str V, 3,16,2, /p. 40). Precisa che il Logos è ragione <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>, generato da <strong>Dio</strong> come essere <strong>di</strong>stinto,<br />
come suo Figlio. L'intelletto è il luogo <strong>delle</strong> idee e <strong>Dio</strong> è l'intelletto (Str V 11,73,3, /p. 85). Il<br />
Logos esce dall'intelletto del Padre e <strong>di</strong>vino è l'autore della creazione del mondo sensibile<br />
secondo il modello intelligibile e la Sapienza <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> (Ivi, p. 85). Il Logos possiede<br />
sostanzialmente lo Spirito; la sua generazione è descritta come il raccogliere in sé come Figlio<br />
tutte le potenze dello Spirito. Le riflessioni <strong>di</strong> Clemente si fondano sulla cristologia del II sec.<br />
che identifica lo Spirito col Logos (Giustino Ap. 33,6, /p. 88).<br />
Insiste molto sul Logos volto del Padre, il volto <strong>di</strong> colui che è senza figura; con<br />
l'incarnazione si è reso percettibile ai sensi, sollecitando da parte dell'uomo un'ascesa,<br />
simboleggiata dal passaggio dall'altra parte del velo (Str V, 6.34,1, /p. 81). Insiste molto sul<br />
carattere incomprensibile, inaccessibile e ineffabile <strong>di</strong> <strong>Dio</strong>, riflettendo in modo perfetto il<br />
platonismo (Ivi, p. 232).<br />
In Clemente ha grande parte il simbolismo, l'allegoria e l'interpretazione degli<br />
innumerevoli simboli biblici sotto cui si nasconde un insegnamento misterioso da decifrare<br />
con prudenza e <strong>di</strong>screzione. Non ha inventato però il sistema <strong>di</strong> tenere segrete le dottrine più<br />
importanti, ma lo ha ere<strong>di</strong>tato dagli antichi specie dai pitagorici. Questa corrente aveva<br />
introdotto <strong>nel</strong>la ricerca filosofica in generale e soprattutto <strong>nel</strong>la ricerca metafisica il clima <strong>di</strong><br />
religiosità che caratterizzava le sette pitagoriche un tempo e che le scoperte dei sapienti e la<br />
<strong>di</strong>spersione dei membri della Società avevano contribuito ad attenuare. La nuova immagine<br />
del pitagorismo, creato senza dubbio per i circoli prossimi dell'Accademia, era servito da<br />
modello per la rappresentazione dell'appren<strong>di</strong>mento filosofico come una veritiera iniziazione<br />
(Ivi, p. 212). La severità con cui Platone giu<strong>di</strong>cava la scrittura <strong>nel</strong> Fedro ed il rispetto e la stima<br />
che circondavano il suo insegnamento orale <strong>nel</strong>l'antica Accademia, avevano fornito degli<br />
argomenti ai partigiani della riservatezza. Aveva insistito sull'impossibilità <strong>di</strong> esprimere la<br />
verità più alta (Lett. VII), a più forte ragione <strong>di</strong> trasmetterla per iscritto. La lettera II, apocrifa,<br />
aveva messo a profitto questa <strong>di</strong>ffidenza <strong>nel</strong>lo stesso spirito dei documenti pseudopitagorici; il<br />
destinatario è invitato a bruciare la lettera e per parlare della natura dell'Uno è prudente usare<br />
degli enigmi. Il Timeo <strong>di</strong>stingue due categorie: i novizi o essoterici ed i perfetti o esoterici.<br />
L'elemento che dà la tonalità religiosa a questa <strong>di</strong>stinzione fu l'assimilazione del passaggio da<br />
un grado all'altro, a un rito <strong>di</strong> iniziazione mistica. Clemente ha ripreso questo modello, esteso<br />
alla maggior parte <strong>delle</strong> scuole filosofiche, per giustificare la sua rappresentazione<br />
dell'esoterismo cristiano. Così la massa dei fedeli semplici è incapace <strong>di</strong> comprendere la<br />
complessità della sapienza <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> e deve accontentarsi del catechismo dei non iniziati.<br />
Clemente dunque è un buon rappresentante <strong>di</strong> questo in<strong>di</strong>rizzo platonico (Ivi, p. 215). Tuttavia<br />
questa <strong>di</strong>stinzione appella al progresso ed all'ascesa <strong>nel</strong>la santità onde giungere alla<br />
conoscenza perfetta, superando così una cristallizzazione dei due livelli (Ivi, p. 226).<br />
Bisogna sorpassare la visione elementare del Cristo per riconoscere il suo significato, i<br />
tesori della sapienza e della conoscenza nascosti in lui (Col 2,3). I misteri, ad es. <strong>Dio</strong>, si<br />
affidano alla parola non alla scrittura. «Questi maestri che conservano la vera tra<strong>di</strong>zione del<br />
felice insegnamento, uscito <strong>di</strong>rettamente dai santi apostoli Pietro, Giacomo, Giovanni e<br />
Paolo trasmesso da padre in figlio - ma pochi figli sono secondo l'immagine dei padri - sono<br />
giunti fino a noi, grazie a <strong>Dio</strong>, per deporre in noi quella bella semente dei loro antenati e<br />
Apostoli» (Str II, 1,11,3 e VII, 7,61,1-3, /p. 224).<br />
La conoscenza è il segno dell'appartenenza alla casa del Signore: conoscenza del Padre <strong>nel</strong><br />
Figlio. L'elezione implica la conoscenza e la rassomiglianza con <strong>Dio</strong>, per cui chi ignora la<br />
bontà del Padre e si sottomette al maligno <strong>di</strong>viene cattivo. Vi è equivalenza tra la per<strong>di</strong>zione e<br />
l'abbandono della conoscenza <strong>di</strong> <strong>Dio</strong> e tale abbandono è passibile <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio (Str II, 13,59,6, /p.