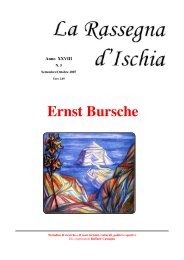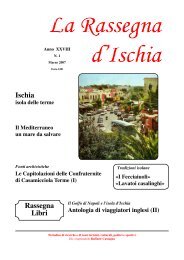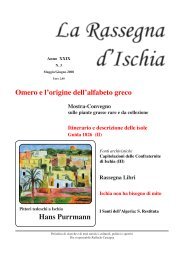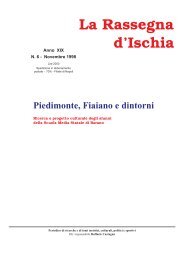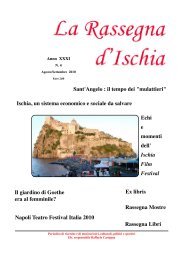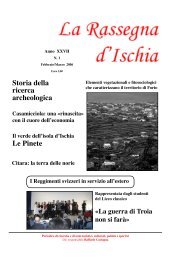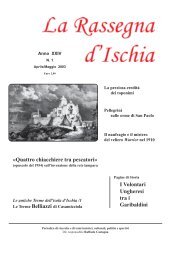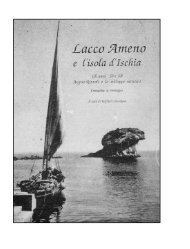Numero 5 Agosto / Settembre 2011 - La Rassegna d'Ischia
Numero 5 Agosto / Settembre 2011 - La Rassegna d'Ischia
Numero 5 Agosto / Settembre 2011 - La Rassegna d'Ischia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
percepite nel tremolio del mare, alla luce del sole o al<br />
chiarore della luna, resero la sua produzione di vastità<br />
compiuta e di valore assoluto. Il dialetto usato in quanto<br />
ad espressione ha rappresentato per lui la forma spontanea<br />
e necessaria per mettere alla luce la “verginità” del<br />
suo sentire, per giungere infine alla sua vera, toccante<br />
Poesia.<br />
Auden<br />
Quando la poesia si fa luce, quando dovunque si posi<br />
lo sguardo del poeta riesce a cogliere la realtà sfuggevole,<br />
quando l’intera vita entra in un cerchio poetico<br />
e diviene parola cantabile, siamo alla presenza di un<br />
dono che qualcuno possiede, avendolo ricevuto dalla<br />
natura e che a sua volta si trasferisce agli altri. Universo<br />
poetico: unico universo possibile, entro il quale soltanto<br />
lui sa orientarsi e muoversi. Le austere navate di una<br />
chiesa, l’assolo di un violino, un suono che accompagna<br />
un canto bizantino, la morte che aspetta vestita di<br />
bianco, il cencioso che striscia chiedendo la carità – nasconde<br />
la fede e attende che la lama affondi nel magma<br />
dell’ignaro passante… Si piange e si grida in questo<br />
spettacolo: non si dica gente che era innocente, ogni<br />
uomo che nasce è segnato colpevole dell’esser nato.<br />
Un viaggio nello stretto, attraverso una memoria dei<br />
luoghi vissuti, delle persone incontrate, della natura<br />
e delle cose scoperte scorrendo l’esistenza, momento<br />
per momento. Lungo questo interminabile percorso si<br />
vengono raffigurando alcuni temi fondamentali, che<br />
condensano la riflessione del poeta e la irraggiano in<br />
molteplici direzioni. Il poeta si stupisce del miracolo<br />
della vita, celebrando l’ascolto di ciò che la natura stessa<br />
sussurra. In questo giardino tutto si rinnova e ciò che<br />
ancora rinasce lo è in un ciclo di vita inesauribile in<br />
cui ogni essere è coinvolto, e il tempo, grande unità di<br />
misura di questa poesia, si dispiega con stagioni che<br />
alternandosi, pure ne segnano la continuità.<br />
<strong>La</strong> poesia tra le due guerre<br />
Un’età segnata dalla catastrofe di due guerre mondiali<br />
a vent’anni l’una dall’altra; e nel frattempo altri<br />
sconvolgimenti, come la nascita dell’URSS a dittatura<br />
comunista, la sconfitta della democrazia prima in Italia<br />
con l’avvento del Fascismo, poi in Germania con il Nazismo<br />
e in Spagna dopo una sanguinosa guerra civile.<br />
Poterono di più i primi anni della prima guerra mondiale<br />
che leggi e istituzioni, nel senso che uomini provenienti<br />
da tutte le regioni della penisola si trovarono a<br />
combattere fianco a fianco nelle avversità più crude e<br />
crudeli, per infine riuscire a “farsi italiani”.<br />
Nel periodo tra le due guerre la poesia italiana completa<br />
il distacco dall’ottocento per un bisogno di raccoglimento,<br />
di essenzialità che poi si manifesterà nella<br />
tendenza più importante dell’ermetismo. Tale definizio-<br />
ne fu coniata dal critico Francesco Flora, che condannava<br />
l’oscurità e la poca decifrabilità di tale poesia. E<br />
invece i poeti ermetici perseguono l’idea di una poesia<br />
pura e libera, nel senso purificata dalla metrica, retorica<br />
e celebrativa. Il tema fondante di questa poesia affonda<br />
nel senso di solitudine dell’uomo, senza più miti e<br />
certezze. Ricordiamo Quasimodo, Ungaretti e Montale.<br />
Questi autori spesso non fanno cenno alla guerra ma al<br />
vuoto che essa lascia, con tono triste e rassegnato.<br />
In particolare per Montale (Ossi di seppia è del 1925)<br />
si denota il disagio esistenziale, il malessere profondo<br />
legato al “male di vivere”; non vi è un’accettazione<br />
rassegnata di questa condizione di crisi e non rinunzia<br />
all’idea che la vita deve in qualche modo avere un significato.<br />
<strong>La</strong> sua poesia è una ricerca mai interrotta di quel<br />
significato, sottesa da una speranza che a volte dispera.<br />
Ma la poesia di quegli anni non si esaurisce nell’ermetismo,<br />
alcuni furono estranei a quel movimento, come<br />
Umberto Saba. Per il poeta triestino il dolore è necessario<br />
all’esistenza, è un male individuale e allo stesso<br />
tempo universale. Fiorisce anche la poesia dialettale: ricordiamo<br />
Trilussa, Virgilio Giotti, Biagio Marin, Delio<br />
Tessa, Ignazio Buttitta, tutti autori che usano il dialetto<br />
come mezzo di espressione per rendere più vera e toccante<br />
la verità di un ambiente.<br />
Il periodo tra le due guerre rappresenta un lungo e<br />
tormentato momento di attesa, come quando la calma<br />
interviene dopo che ogni speranza è svanita. È come se<br />
l’umanità si fosse divisa tra quelli che credono all’onnipotenza<br />
dell’uomo (ritenendo che tutto sia possibile<br />
purché si sappia organizzare a tale scopo le masse) e<br />
quelli per cui l’impotenza è diventata l’esperienza più<br />
importante della loro vita. Tanto è il pessimismo in questo<br />
amaro sfogo della filosofa Hannah Arendt, tratto dal<br />
suo saggio “Le origini del Totalitarismo”:«I lager sono<br />
i laboratori dove si sperimenta la trasformazione della<br />
natura umana. Finora la convinzione che tutto sia possibile<br />
sembra aver provato soltanto che tutto può essere<br />
distrutto. Ma nel loro sforzo di tradurla in pratica, i<br />
regimi totalitari hanno scoperto, senza saperlo, che ci<br />
sono crimini che gli uomini non possono né punire né<br />
perdonare. Quando l’impossibile è stato reso possibile,<br />
è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile,<br />
che non poteva essere compreso e spiegato coi<br />
malvagi motivi dell’interesse egoistico, dell’avidità,<br />
dell’invidia, del risentimento; e che quindi la collera<br />
non poteva vendicare, la carità sopportare, l’amicizia<br />
perdonare, la legge punire».<br />
Giuseppe Castiglione<br />
<strong>La</strong> <strong>Rassegna</strong> d’Ischia n. 5/<strong>2011</strong> 35