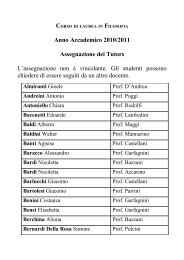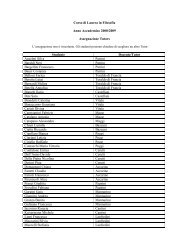LE RAGIONI DELLA FILOSOFIA Volume II LA RIVOLUZIONE ...
LE RAGIONI DELLA FILOSOFIA Volume II LA RIVOLUZIONE ...
LE RAGIONI DELLA FILOSOFIA Volume II LA RIVOLUZIONE ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21<br />
nell’ambiente degli artigiani e dei meccanici, solitamente disprezzati dalla<br />
scienza ufficiale, ma non esita ad agire egli stesso da artigiano, ricostruendo<br />
quello strumento per poi usarlo con metodo e spirito scientifico ai fini della<br />
conoscenza della natura, è l’emblema del “nuovo uomo di scienza”. Come<br />
ricorda Rossi,<br />
nella cultura tradizionale era presente, nei confronti delle arti<br />
meccaniche e del lavoro manuale, tutta una serie di pregiudizi. Tali<br />
pregiudizi trovavano precisa espressione anche nella diffidenza per<br />
l’uso di strumenti concepiti come aiuti per i sensi. L’atteggiamento<br />
assunto da Galilei nei confronti del cannocchiale segna da questo punto<br />
di vista una svolta di importanza decisiva. […] Il cannocchiale non è per<br />
Galilei né uno strumento curioso costruito per il diletto degli uomini di<br />
corte, né un oggetto la cui utilità si esaurisca nell’uso immediato che<br />
possono farne i navigatori o i generali nelle battaglie. Egli impiega il<br />
cannocchiale come strumento scientifico, lo volge verso il cielo con<br />
spirito metodico […] (P. Rossi, in La rivoluzione scientifica da Copernico<br />
a Newton, cit., p. 66).<br />
Che cosa “vede” dunque Galileo con questo strumento che usa per<br />
osservare con sistematicità il cielo, per fare “centinaia e migliaia di<br />
esperienze in mille e mille oggetti, e vicini e lontani, e grandi e piccoli, e<br />
lucidi e oscuri”? Il vedere attraverso il cannocchiale è un nuovo modo di<br />
vedere, che permette innanzitutto di scoprire aspetti diversi di cose già viste.<br />
Come nel caso della Luna, la cui superficie vista da più vicino appare non<br />
più “liscia, uniforme e di sfericità esattissima, come di essa Luna e degli<br />
altri corpi celesti una numerosa schiera di filosofi ha ritenuto”, ma simile a<br />
quella terrestre, con irregolarità dello stesso genere (contro la distinzione<br />
della tradizione aristotelica tra mondo celeste e mondo sublunare); e come<br />
nel caso della Via Lattea e delle nebulose, che Galileo scopre essere, invece<br />
che semplici “nubi biancheggianti” di cui non si conosceva l’essenza, degli<br />
ammassi di miriadi di stelle:<br />
Bellissima cosa e oltremodo a vedersi attraente è il poter<br />
rimirare il corpo lunare, da noi remoto quasi sessanta semidiametri<br />
terrestri, così da vicino, come se distasse di due soltanto di dette misure;<br />
[…] e quindi con la certezza che è data dell’esperienza sensibile, si possa<br />
apprendere non essere affatto la Luna rivestita di superficie liscia e<br />
levigata, ma scabra e ineguale, e allo stesso modo della faccia della<br />
Terra, presentarsi ricoperta in ogni parte di grandi prominenze, di<br />
profonde valli e di anfratti.<br />
Di più, l’aver rimosse le controversie riguardo alla Galassia o<br />
Via Lattea, con l’aver manifestato al senso, oltre che all’intelletto,<br />
l’essenza sua, non è da ritenersi, mi pare, cosa di poco conto; come<br />
anche il mostrare direttamente essere la sostanza di quelle Stelle, che fin<br />
qui gli Astronomi hanno chiamato Nebulose, di gran lunga diversa da<br />
quel che fu creduto finora, sarà cosa molto bella e interessante (G.<br />
Galilei, Sidereus Nuncius, in P. Rossi, La rivoluzione scientifica, cit., p.<br />
73).<br />
21