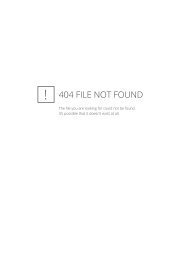Macchetti, Teofilo Title: Curiosità Musicali nelle quali si tratta della ...
Macchetti, Teofilo Title: Curiosità Musicali nelle quali si tratta della ...
Macchetti, Teofilo Title: Curiosità Musicali nelle quali si tratta della ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
questo; esercitò altri fino all’ ultimo <strong>della</strong> sua Vita; compose, aggiustò, ridusse, introduesse<br />
due scole sopra questo in Roma; e da esso <strong>si</strong> dice, perciò uenuto il Canto Gregoriano. San<br />
Leone II. aggiustò ancor’ esso gl’ Inni, et i [-f.40r-] salmi. E chi brama altro circa al primo<br />
principio di questo nella Santa [[salmi add. supra lin.] legga gl’ Annali Baroniani all’ anno 60.<br />
<strong>si</strong> che ne trouerà.<br />
[2. add. in marg.] Io non cerco al presente, se all’ hora <strong>si</strong> seruissero di sole linee per<br />
aggiungerui sopra le note per le uoci, ò pur [oppur ante corr.] anco delli spazij; se<br />
adoprauano punti, ò pure [oppure ante corr.] circoletti, ò altro; se alle linee per dimostrar con<br />
altro segno le <strong>si</strong>llabe lunghe, e breui, e qual nome dassero alle corde, secome sopra nella V.<br />
numero 4. e come nell’ XI. Numero 4. Credo bensì, che mentre li primi Antichi non haueuano<br />
altri nomi alle stesse corde, ò suoni, ò Voci, che Proslambanomenos et cetera con gl’ altri, che<br />
li seguono i nostri primi Latini, anzi primi santi [[e]] [[]] [<strong>si</strong> ualessero, e corr. supra lin.]<br />
specialmente San Gregorio (forse il primo) delle nostre lettere dell’ Alfabeto A B C con le<br />
altre; appropriando l’ A alla Proslambanomenos come primo suono, Corda, ò Voce, e così l’<br />
altre per grad seguenti: non però che intendessero con A A la mi re con B B mi, ò B fa b mi,<br />
et cetera perche questi nomi all’ hora non c’ eran, mà doueano intender con A. primo suono,<br />
con B. secondo, con C. il terzo, e con le distanze frà loro i tuono, e semituono; e così per<br />
sette delle dette prime Lettere, e che le segnassero grandi dall’ A. Proslambanomenos fino al<br />
G. Licanos meson, et arriuando alla Mese a. Ottaua acuta <strong>della</strong> Proslambanomenos<br />
incominciarono a segnarle con lettere picciole a. b. c. et cetera indouinando a caso il riscontro<br />
delli nomi, che sì dette corde, ò suoni <strong>si</strong> doueano poi dare. E ciò perche anco li primi Antichi<br />
le segnauano [-f.40v-] pure con lettere del loro Alfabeto; ma proseguendo innanzi dalla prima<br />
almeno fino alla decimaquinta anco Boezio dall’ A fino all’ O, ouero al P et cetera. Nel resto<br />
quanto alla sostanza <strong>della</strong> mu<strong>si</strong>ca non poteano hauer, cred’ io, questi nostri primi altri segni<br />
per il <strong>si</strong>stema, che li detti in Lettere; altro sestema, che forse il primo puro naturale di tuoni<br />
sesquiottaui, e Limma: altri Modi, che li primi sette con l’ aggiunta al più dell’ ottauo, quale<br />
<strong>si</strong> douesse essere, come in Boezio, ò meglio con un’ Ipermissolidio; mà con l’ equiuoco, anzi<br />
errore delli primi Vecchi; che l’ Ippodorio fosse nella Proslambanomenos A. e non un' tuono<br />
più nel graue G G: e per consequenza, che il Dorio fosse nella Licanos Hypaton D. e non nel<br />
C. e perciò tolto nel D. per primo inauuedutamente. Che in quanto poi dell’ hauerli inte<strong>si</strong> per<br />
il loro diritto; e non rouersciati, hanno dimostrato maggior auuedutezza, che gl’ altri primi,<br />
come l’ hà dimostrato in questo anco Boezio, che non gl’ hà rouersciati, ne di questo ha<br />
parlato.<br />
[3 add. in marg.] Ma con tuttociò con questa battuta, anzi con tali battute; che <strong>si</strong><br />
ricauano da Sant’ Agostino (come nella passata) e prima di esso da Aristide Quintiliano, e da<br />
Bacchio, che da tre tempi Breue, Lunga, e Irrazionale più lunga del Breue, più corto del<br />
Lungo parmi di non ricauare cosa che <strong>si</strong>a à propo<strong>si</strong>to nel tempo e battuta tanto nella nostra<br />
Mu<strong>si</strong>ca moderna; quanto nella Gregoriana perche stando<strong>si</strong> attaccati a quelle <strong>si</strong>llabe, a quei<br />
Piedi, non [-f.41r-] doueano à mio creder riuscire le Cantilene tali, che li douesse esser<br />
necessaria questa battuta. Che sebene stauano gl’ Antichi attaccati con la Mu<strong>si</strong>ca alla Poe<strong>si</strong>a,<br />
no credo, che facessero le Compo<strong>si</strong>zioni tanto Poetiche, quanto <strong>Mu<strong>si</strong>cali</strong>, che dossero di<br />
Piedi tutti di <strong>quali</strong>tà tali, che <strong>si</strong> ptessero unire as<strong>si</strong>eme sotto ad una stessa regolata battuta,<br />
come parimente sopra in Sant’ Agostino: che quantunque quelli Piedi erano in quella maniera<br />
aggiustati, il senso di quelle parole parmi, che nulla ci dimostri nel de<strong>si</strong>derato propo<strong>si</strong>to: onde<br />
accresceuano ancor es<strong>si</strong> il numero delli tempi con altre note alle Voci ed alle stesse <strong>si</strong>llabe,<br />
come uediamo di presente nelli stes<strong>si</strong> Canti Corali, e negl’ Inni, e <strong>si</strong> uede anco in quegl’





![Doni, Giovanni Battista Title: Trattato Dei Tuoni o [[Harmonie de]]](https://img.yumpu.com/45461005/1/190x245/doni-giovanni-battista-title-trattato-dei-tuoni-o-harmonie-de.jpg?quality=85)