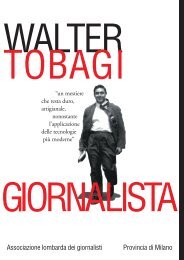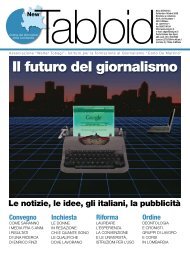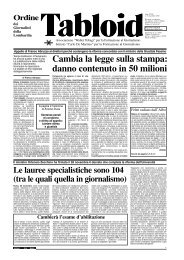Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LE FONTI GIURIDICHE DEL GIORNALISMO<br />
L’incipit è nella legge<br />
n. 406 del 9 luglio 1908:<br />
l’articolo 4<br />
cita per la prima volta<br />
i giornalisti<br />
professionisti<br />
La professione giornalistica<br />
nell’ordinamento<br />
giuridico italiano<br />
e dell’Unione europea<br />
ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />
Ricerca di Franco Abruzzo<br />
Dal 1908 (anno di nascita della Fnsi) ad oggi l’ordinamento<br />
giuridico nazionale dedicato ai giornalisti e al giornalismo si è<br />
arricchito di norme (anche comunitarie) che si possono disporre<br />
così:<br />
1) Costituzione della Repubblica (entrata in vigore il 1° gennaio<br />
1948): l’articolo 21 proclama la libertà di manifestazione<br />
del pensiero. L’articolo 33 (V comma) prevede<br />
l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.<br />
L’articolo 21 della Costituzione italiana afferma solennemente<br />
che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio<br />
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.<br />
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni<br />
o censure». L’unico limite esplicito è posto nelle manifestazioni<br />
(a stampa, di spettacolo o di qualsiasi altro genere) «contrarie<br />
al buon costume» rispetto alle quali «la legge stabilisce<br />
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».<br />
La libertà di manifestazione del pensiero - in uno sforzo<br />
interpretativo dell’articolo 21 - abbraccia oggi la libertà di informazione,<br />
di espressione, di opinione, di stampa; la libertà e il<br />
diritto di cronaca e di critica nonché il diritto <strong>dei</strong> cittadini all’informazione.<br />
Nella sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte<br />
costituzionale definisce espressamente il lato attivo della libertà<br />
di manifestazione del pensiero come «libertà di dare e<br />
divulgare notizie, opinioni, commenti» e il lato passivo come<br />
«interesse generale, anch’esso indirettamente protetto dall’articolo<br />
21, alla informazione; il quale in un regime di libera<br />
democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso<br />
alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali,<br />
anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee<br />
ed implica altresì esclusione di interventi <strong>dei</strong> pubblici poteri<br />
suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni,<br />
in forme di pressione per indirizzare la stampa verso<br />
obiettivi predeterminati a preferenza di altri”.<br />
La storia dell’Italia unita, in tema di libertà di stampa, parte<br />
con l’articolo 28 dello Statuto Albertino, emanato da Carlo<br />
Alberto il 4 marzo del 1848. La norma, dalla formulazione<br />
generale, stabilisce che “la stampa sarà libera, ma una legge<br />
ne reprime gli abusi”. Il virgolettato traduce sostanzialmente<br />
l’articolo 11 della Dichiarazione universale <strong>dei</strong> diritti<br />
dell’Uomo della Francia rivoluzionaria del 1789. È una<br />
svolta, che nasconde la debolezza legata al carattere flessibile<br />
dello Statuto. Le Camere potranno utilizzare una sorta di<br />
delega in bianco per “reprimere gli abusi” nell’esercizio della<br />
dichiarata libertà. Questa disciplina dovrà fare i conti con le<br />
leggi di pubblica sicurezza del 1859, 1865, 1889, che, con<br />
vari mezzi, limitavano incisivamente nei fatti quella libertà<br />
sancita in via di principio. Allo Statuto segue il regio decreto<br />
n° 695, meglio noto come Editto Albertino sulla<br />
Stampa. L’articolo 1 dell’Editto affermava che “La manifestazione<br />
del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia<br />
artificio meccanico, atto a riprodurre segni figurativi, è<br />
libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie,<br />
oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino<br />
le norme seguenti…”.<br />
La professione giornalistica, come quella degli avvocati e <strong>dei</strong><br />
medici, è nella Costituzione. L’Antitrust, sbagliando, ha affermato<br />
che soltanto gli avvocati e i medici sono nella<br />
Costituzione (con riferimento agli articoli 24 e 32, che parlano<br />
del diritto di difesa e del diritto alla salute). Il secondo comma<br />
dell’articolo 21 della Costituzione afferma che “la stampa<br />
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. La<br />
stampa (intesa come giornalismo) è fatta, alimentata, progettata<br />
e creata dai giornalisti professionisti. “L’esperienza dimostra<br />
- come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza<br />
n. 11/1968 - che il giornalismo, se si alimenta anche del contributo<br />
di chi ad esso non si dedica professionalmente, vive<br />
soprattutto attraverso l’opera quotidiana <strong>dei</strong> professionisti.<br />
Alla loro libertà si connette, in un unico destino, la libertà della<br />
stampa periodica, che a sua volta è condizione essenziale<br />
di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia<br />
affonda le sue radici vitali”. La Costituzione e la Corte costituzionale<br />
disegnano, quindi, una professione giornalistica come<br />
professione della libertà. Il secondo comma dell’articolo<br />
21 va incrociato con il quinto comma dell’articolo 33 della<br />
Costituzione: “È prescritto un esame di Stato ...per l’abilitazione<br />
all’esercizio professionale”. La Repubblica, quindi, con<br />
l’esame di Stato garantisce i cittadini sull’idoneità <strong>dei</strong> giornalisti<br />
“all’esercizio professionale”, legando nel contempo, in<br />
maniera inscindibile, la stampa all’attività professionale <strong>dei</strong><br />
giornalisti.<br />
2) Codice civile (RD 16 marzo 1942 n. 262): l’articolo 2229<br />
sulle professioni intellettuali demanda l’accertamento <strong>dei</strong> requisiti<br />
per l’iscrizione negli Albi, la tenuta degli Albi e il potere<br />
disciplinare alle associazioni professionali, che, con riferimento<br />
al Decreto legislativo luogotenenziale n. 382/1944, sono gli<br />
Ordini professionali.<br />
3) Legge n. 406 del 9 luglio 1908: l’articolo 4 cita per la prima<br />
volta i giornalisti professionisti italiani in quanto tali.<br />
4) Legge 31 dicembre 1925 n. 2307. L’articolo 7 prevede l’istituzione<br />
di un <strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti (mai, però, diventato<br />
operativo).<br />
5) Legge 3 aprile 1926 n. 563: detta le norme sull’organizzazione<br />
sindacale di tutte le professioni e sulla disciplina giuridica<br />
<strong>dei</strong> rapporti collettivi di lavoro. Nascono poi nel 1927 il<br />
sindacato unico fascista <strong>dei</strong> giornalisti (al posto della Fnsi) e i<br />
sindacati regionali fascisti <strong>dei</strong> giornalisti.<br />
6) Regio decreto 28 febbraio 1928 n. 384: istituisce l’Albo<br />
professionale <strong>dei</strong> giornalisti presso ogni sindacato regionale<br />
fascista <strong>dei</strong> giornalisti. Il Regio decreto n. 384/1928 (con le correzioni<br />
apportate dal Decreto n. 302/1944) è rimasto in vigore<br />
fino al giugno 1965, quando, dopo l’approvazione del<br />
Regolamento di esecuzione, è diventata operativa la legge del<br />
1963 sull’ordinamento della professione giornalistica.<br />
7) Regio decreto 21 novembre 1929 n. 2291: prevede la istituzione<br />
di una Scuola professionale per giornalisti debitamente<br />
riconosciuta sostituiva del praticantato svolto nelle redazioni.<br />
Funzionerà in Roma dal 1930 al 1933. Era frequentata (obbligatoriamente<br />
per sei mesi e per gli insegnamenti tecnicopratici)<br />
anche dagli studenti della facoltà di Scienze politiche a<br />
indirizzo giornalistico dell’Università di Perugia. I laureati potevano<br />
iscriversi nell’Albo <strong>dei</strong> giornalisti professionisti.<br />
8) Decreto Lgs. Lgt. 23 ottobre 1944 n. 302: abolita l’organizzazione<br />
corporativa, si provvide ad affidare provvisoriamente<br />
le funzioni della tenuta degli Albi <strong>dei</strong> giornalisti a una<br />
Commissione unica con sede in Roma, nominata dal ministro<br />
di Grazia e Giustizia. La Commissione aveva sub-commissioni<br />
presso ogni Associazione regionale della stampa.<br />
9) Decreto Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382: detta norme<br />
sui Consigli degli Ordini e collegi e sulle commissioni interne<br />
professionali. L’articolo 26 preannuncia un decreto sui Consigli<br />
degli Ordini e la Commissione centrale <strong>dei</strong> giornalisti.<br />
10) Legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47: fissa la figura<br />
del direttore responsabile e del proprietario <strong>dei</strong> giornali e<br />
<strong>dei</strong> periodici nonché le regole per la registrazione <strong>dei</strong> giornali<br />
e <strong>dei</strong> periodici. Rende obbligatoria la rettifica, stabilisce le pene<br />
per il reato di diffamazione e pone limiti alle pubblicazioni<br />
destinate all’infanzia o all’adolescenza e alle pubblicazioni a<br />
contenuto impressionante o raccapricciante.<br />
11) Legge 20 dicembre 1951 n. 1564: la previdenza e l’assistenza<br />
<strong>dei</strong> giornalisti professionisti è attuata dall’Istituto nazionale<br />
di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti italiani (Inpgi) “Giovanni<br />
Amendola”, già riconosciuto con Regio decreto 25 marzo 1926<br />
n. 838. L’Inpgi sostituisce a tutti gli effetti le corrispondenti forme<br />
di previdenza e di assistenza obbligatorie garantite dall’Inps.<br />
12) Dpr 16 gennaio 1961 n. 153: ha reso efficace erga omnes<br />
il Contratto nazionale di lavoro giornalistico 10 gennaio<br />
1959.<br />
13) Legge 3.2.1963 n. 69 sull’ordinamento della professione<br />
di giornalista. È la legge che organizza, come le altre professioni,<br />
la professione giornalistica con l’<strong>Ordine</strong> e l’Albo (diviso<br />
negli elenchi <strong>dei</strong> giornalisti professionisti e <strong>dei</strong> pubblicisti) secondo<br />
quanto stabilisce l’articolo 2229 del Codice civile.<br />
L’<strong>Ordine</strong> è delegato anche a organizzare l’esame di Stato<br />
(previsto dalla Costituzione) per l’accesso alla professione.<br />
All’Albo è annesso un Registro <strong>dei</strong> praticanti.” La legge<br />
69/1963 è costituzionalmente legittima (sentenze 11 e<br />
98/1968; 2/1971; 71/1991; 505/1995; 38/1997 della Corte<br />
costituzionale). L’articolo 2 fissa le regole deontologiche della<br />
professione sulle quali si fonda l’autonomia della professione<br />
stessa (art. 1 del Cnlg). L’articolo 2 riconosce che “è diritto<br />
insopprimibile <strong>dei</strong> giornalisti la libertà di informazione e di<br />
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a<br />
tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il<br />
rispetto della verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i<br />
doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. L’art. 48<br />
(Procedimento disciplinare) della stessa legge prevede che<br />
“gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano<br />
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali,<br />
o di fatti che compromettano la propria reputazione<br />
o la dignità dell’<strong>Ordine</strong>, sono sottoposti a procedimento disciplinare”.<br />
Chi viola i precetti richiamati finisce sotto procedimento<br />
disciplinare e rischia di essere sanzionato con uno <strong>dei</strong><br />
quattro provvedimenti previsti dalla legge professionale (avvertimento,<br />
censura, sospensione da 2 a 12 mesi, radiazione).<br />
14) Legge 20 ottobre 1964 n. 1039: detta una norma transitoria<br />
sulla iscrizione nell’elenco <strong>dei</strong> professionisti <strong>dei</strong> praticanti<br />
che abbiano compiuto i 18 mesi di tirocinio.<br />
15) Dpr n. 115/1965: è il Regolamento per l’esecuzione della<br />
legge 3.2.1963 n. 69 sulla professione giornalistica. È stato<br />
aggiornato con i Dpr n. 212/1972; n. 649/1976 e n. 384/1993.<br />
L’articolo 54 (II comma) del Dpr 384/1993 riconosce ai cittadini<br />
comunitari la facoltà di sostenere le prove di esame per<br />
l’abilitazione all’esercizio professionale nella propria lingua.<br />
16) Legge 10 giugno 1969 n. 308: regola l’iscrizione <strong>dei</strong> giornalisti<br />
stranieri nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della<br />
legge professionale nonché la formazione <strong>dei</strong> collegi giudicanti<br />
presso Tribunali e Corti di Appello. Tribunali e Corti<br />
d’Appello saranno integrati da un professionista e da un pubblicista<br />
nominati in numero doppio.<br />
17) Decreto del ministro di Grazia e Giustizia 2 febbraio<br />
1973: è il Regolamento per la trattazione <strong>dei</strong> ricorsi e degli<br />
affari di competenza del Consiglio nazionale<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti. Con decreto 18 luglio 2003 (pubblicato<br />
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2003) il Direttore generale<br />
della Giustizia civile del ministero della Giustizia ha approvato<br />
il nuovo Regolamento per la trattazione <strong>dei</strong> ricorsi<br />
e degli affari di competenza del Consiglio nazionale<br />
dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti adottato dal Consiglio stesso in<br />
due diverse sessioni, a Verona e a Roma. Il nuovo testo contiene<br />
molte innovazioni.<br />
18) Dpr 29.9.1973 n. 605: l’articolo 6 impone che il numero di<br />
codice fiscale sia indicato nelle domande di iscrizione negli<br />
elenchi degli Albi e <strong>dei</strong> Registri professionali.<br />
19) Legge 10 giugno 1978 n. 292: regola l’esazione <strong>dei</strong> contributi<br />
per il funzionamento <strong>dei</strong> Consigli degli Ordini secondo<br />
le norme per la riscossione delle imposte dirette.<br />
20) Dpr 11 luglio 1980 n. 382: in base all’articolo 11, i nominativi<br />
<strong>dei</strong> professori universitari ordinari che hanno optato per<br />
il tempo pieno (regime incompatibile con lo svolgimento di<br />
qualsiasi attività professionale) vengono comunicati, a cura<br />
del rettore, all’<strong>Ordine</strong> professionale al cui Albo i professori risultino<br />
iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.<br />
21) Legge 25 febbraio 1987 n. 67: l’articolo 26 stabilisce che<br />
l’Inpgi assicura la previdenza obbligatoria anche ai giornalisti<br />
praticanti. L’articolo 76 della legge n. 388/2000 la estende ai<br />
pubblicisti e ribadisce che l’Istituto è sostitutivo dell’Inps.<br />
22) Nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore il<br />
24 ottobre 1989. L’articolo 200 riconosce il segreto professionale<br />
soltanto ai giornalisti professionisti. L’articolo 115 configura<br />
i Consigli degli Ordini come giudici disciplinari <strong>dei</strong> giornalisti<br />
che violano l’obbligo di non pubblicare le generalità e le<br />
fotografie <strong>dei</strong> minori (obbligo che è il punto 6 dell’articolo 114).<br />
23) Legge 29 dicembre 1990 n. 428 (legge comunitaria<br />
1990). L’articolo 9 stabilisce che i cittadini degli Stati membri<br />
della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai<br />
fini della iscrizione nel Registro <strong>dei</strong> praticanti e nell’elenco <strong>dei</strong><br />
pubblicisti dell’Albo.<br />
24) La natura professionale dell’attività giornalistica trova<br />
conforto nell’art. 2 del Dlgs 27 gennaio 1992 n. 115<br />
(Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema<br />
generale di riconoscimento <strong>dei</strong> diplomi di istruzione che<br />
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di<br />
tre anni).<br />
L’articolo 2 della direttiva 89/48/CEE ha fissato il principio per<br />
cui l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di<br />
un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni<br />
o di durata equivalente a tempo parziale, in una università<br />
o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello<br />
stesso livello di formazione.<br />
La sentenza della quarta sezione della Corte di giustizia europea<br />
del 10 maggio 2001 - (nella causa C-285/00 contro la<br />
Repubblica francese, che non aveva adottato la normativa europea<br />
per il riconoscimento della professione di psicologo) -<br />
ha stabilito che “la direttiva 89/48/CEE va applicata alle professioni<br />
regolamentate, cioè a quelle per le quali l’accesso o<br />
l’esercizio sono subordinati, direttamente o indirettamente,<br />
mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,<br />
al possesso di un diploma universitario della durata<br />
minima di tre anni”. “La natura professionale dell’attività giornalistica<br />
trova conforto dal combinato dispositivo dell’art. 1,<br />
comma 3, e dell’art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115<br />
(Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema<br />
generale di riconoscimento <strong>dei</strong> diplomi di istruzione che<br />
sanzionano formazioni professionali di una durata minima di<br />
tre anni) e nel decreto MURST del 28 novembre 2000. La prima<br />
fonte ha fissato il principio per cui l’esercizio delle professioni<br />
presuppone il superamento di un ciclo di studi postsegue<br />
→<br />
11