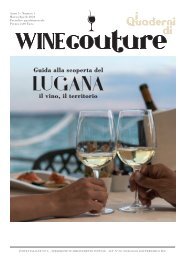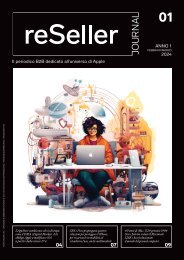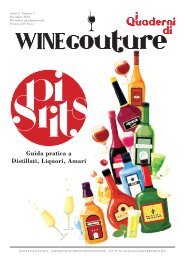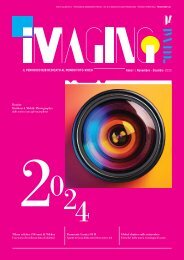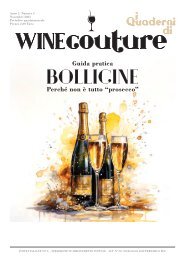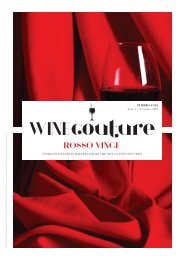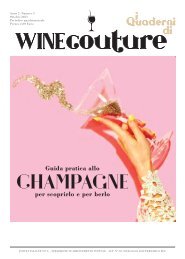WineCouture 1-2/2024
WineCouture è la testata giornalistica che offre approfondimenti e informazione di qualità sul vino e quanto gli ruota attorno. È una narrazione di terroir, aziende ed etichette. Storytelling confezionato su misura e che passa sempre dalla viva voce dei protagonisti, dalle riflessioni attorno a un calice o dalle analisi di un mercato in costante fermento. WineCouture è il racconto di un mondo che da anni ci entusiasma e di cui, con semplicità, vogliamo continuare a indagare ogni specifica e peculiare sfumatura, condividendo poi scoperte e storie con appassionati, neofiti e operatori del comparto.
WineCouture è la testata giornalistica che offre approfondimenti e informazione di qualità sul vino e quanto gli ruota attorno. È una narrazione di terroir, aziende ed etichette. Storytelling confezionato su misura e che passa sempre dalla viva voce dei protagonisti, dalle riflessioni attorno a un calice o dalle analisi di un mercato in costante fermento. WineCouture è il racconto di un mondo che da anni ci entusiasma e di cui, con semplicità, vogliamo continuare a indagare ogni specifica e peculiare sfumatura, condividendo poi scoperte e storie con appassionati, neofiti e operatori del comparto.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
17<br />
Photo: Anastasia Florea<br />
ma anche saputo valorizzare valorizzato il loro Pelaverga,<br />
facendolo conoscere a tutto il mondo oggi, per non dire dei<br />
posteri. “Tanto di cappello: bravi tutti, ma bravi davvero”,<br />
conclude D’Agata.<br />
È il vitigno, dunque, alle fondamenta di un successo in bottiglia<br />
che oggi cerca sempre più spazio nel calice dei consumatori.<br />
Con l’origine del nome Pelaverga che si legherebbe<br />
secondo alcune fonti al latino “pellis virga”, facendo riferimento<br />
a una particolare tecnica adottata per favorire la maturazione<br />
delle uve, che consisteva nella parziale pelatura<br />
dei ramoscelli della vite. Ma attenzione, come evidenziato<br />
da Ian D’Agata, di Pelaverga si conoscono in Piemonte due<br />
diversi autoctoni dalle caratteristiche genetiche e morfologiche<br />
autonome, coltivati in zone distinte: se per uno si<br />
utilizza l’aggettivo “Grosso”, per l’altro si parla di “Piccolo”,<br />
a sottolineare la differenza principale che sta nelle dimensioni<br />
dell’acino. Il primo, originario della provincia di<br />
Cuneo, fa capolino nella composizione delle Doc Colline<br />
Saluzzesi e Collina Torinese, dove è anche detto Cari. Ma<br />
il protagonista a Verduno è il Pelaverga Piccolo, che tradizione<br />
sostiene sia stato introdotto in Langa ad opera del<br />
beato Sebastiano Valfrè nel Settecento. Studi più recenti<br />
(Mannini et al. 1991) hanno tuttavia evidenziato come<br />
quest’ultimo si differenzi dall’inizialmente presunto “gemello”<br />
per caratteristiche ampelografiche, agronomiche ed<br />
enologiche proprie, tanto da farne una cultivar a sé stante,<br />
registrato anch’esso nella “Summa” delle uve tricolori nel<br />
1994, prima della nascita della Doc Verduno Pelaverga (o<br />
Verduno), avvenuta l’anno successivo.<br />
La nota speziata e il Verduno Pelaverga a tavola<br />
Quando arriva in bottiglia e nel calice, il Verduno Pelaverga<br />
è rosso fermo secco a cui la Doc non impone tempi minimi<br />
di affinamento o tipo di contenitore da utilizzare per<br />
la maturazione. Ma una sola resta la tipologia prevista dal<br />
disciplinare, dove per l’appunto la presenza di Pelaverga<br />
Piccolo deve risultare di almeno l’85%. E se per il restante<br />
15% possono contribuire altre varietà a bacca nere idonee,<br />
quasi tutti i vini oggi in commercio sono frutto di una vinificazione<br />
in purezza. Il vino ottenuto da Pelaverga Piccolo<br />
ha colore tenue di un bel rubino con toni violacei e un corredo<br />
aromatico identitario, dalla grande riconoscibilità per<br />
l’apporto speziato. E proprio qui sta il segreto di una piacevolezza<br />
che lo rende un rosso davvero unico, che nulla ha<br />
da che invidiare a produzione di Langa ben più celebrate.<br />
Ma c’è di più in questo vino al contempo spensierato ed<br />
elegante. A evidenziarlo è stato uno studio del 2021 di<br />
Maurizio Petrozziello, ricercatore del Crea di Asti: “Questo<br />
vino è caratterizzato da un colore chiaro e da un aroma speziato<br />
unico e intenso. La sua analisi ha rilevato una concentrazione<br />
significativa di Rotundone (circa 40 ng L-1), che<br />
è noto per conferire una nota di pepe distintiva e ha una<br />
soglia olfattiva molto bassa (16 ng L-1 nel vino)”. Dunque,<br />
è proprio il valore ben al di sopra della soglia di percezione<br />
di questa molecola presente nella buccia dell’acino che<br />
sarebbe il responsabile di quella caratteristica nota speziata<br />
che identifica in maniera inequivocabile i Verduno Pelaverga,<br />
che poi al palato si presentano con acidità contenuta e<br />
tannino lieve, equilibrati e snelli, di struttura medio leggera<br />
di buon tenore alcolico. Per rossi dalla spiccata vocazione<br />
gastronomica e una versatilità che li fa spaziare, a seconda<br />
dell’etichetta e dell’interpretazione della mano del produttore,<br />
dall’accompagnare in tavola merende a veri e propri<br />
piatti della tradizione piemontese. Ma il Verduno Pelaverga<br />
Doc, con la sua scapigliata intraprendenza, invita a provarlo<br />
in abbinamento con preparazioni base di pesce con pomodoro<br />
come cacciucco o calamari ripieni.<br />
Monferace: il volto da scoprire del Grignolino<br />
È una sfumatura differente di Grignolino, storico e sempre<br />
amato vino piemontese, quello che ha scelto invece<br />
di raccontare l’Associazione Monferace, nata nel 2016 e<br />
presieduta da Guido Carlo Alleva, titolare di Tenuta Santa<br />
Caterina. Ad animare il progetto, aziende del territorio:<br />
Accornero, Alemat, Angelini Paolo, Cascina Faletta, Dario<br />
Natta, Liedholm, Tenuta Santa Caterina, Tenuta Tenaglia,<br />
Sulin e Vicara. Produttori che hanno scelto con coraggio<br />
una strada differente, tratteggiando in bottiglia un profilo<br />
diverso di un vitigno che va alle origini del Piemonte del<br />
vino. Come evidenzia in prima istanza Anna Schneider<br />
del Cnr – Istituto per la protezione sostenibile delle piante<br />
di Torino, che sottolinea come le tracce circa la presenza<br />
del Grignolino nella regione non corrispondono necessariamente<br />
al suo anno di nascita. Citato, anzi, prima del<br />
Nebbiolo nel 1249 come Barbesino, studi e ricerche hanno<br />
svelato il legame di parentela tra le due uve: il Grignolino,<br />
infatti, è un nipote del Nebbiolo e vanta stretti legami con<br />
altri vitigni presenti nel Nordovest della nostra Penisola.<br />
Inconfutabilmente il Grignolino è una cultivar autoctona<br />
del Piemonte, parente di Ruchè, discendente di Freisa e Vespolina,<br />
che si è estesa in maniera più capillare nel Casalese.<br />
Lo confermano i consumi dell’800: questo vino scarico di<br />
colore ed elegantissimo veniva scelto da re, nelle corti dei<br />
duchi del Monferrato e dei Savoia. Il profilo organolettico<br />
dell’uva è stato analizzato attraverso la spettrofotometria<br />
del Dna: condotta dai ricercatori del Crea di Asti, ha evidenziato<br />
la presenza del Rotundone, la molecola scoperta<br />
15 anni fa in Syrah australiani, responsabile del sentore<br />
di pepe e già noto nei vini Pelaverga, Corvina, Vespolina,<br />
per citare alcuni. Lato colore e profumi, si parla di rubino<br />
trasparente, aranciato, di aromi floreali, di viola, lampone,<br />
ribes, ciliegia e note balsamiche ed erbacee. “L’affinamento<br />
amplia l’intensità e la complessità del vino, le scelte di<br />
vinificazione incidono moltissimo sulla loro espressività.<br />
Al palato si nota una discrepanza inferiore essendo il vino<br />
caratterizzato da una spiccata presenza di acidità e astringenza”,<br />
spiega anche in questa caso Maurizio Petrozziello.<br />
Una produzione di nicchia che punta in alto<br />
Entrando nel vivo e nei calici, quella del Monferace si<br />
ribadisce una produzione di nicchia ma che punta a raggiungere<br />
alti livelli qualitativi e di prestigio. I più attenti<br />
noteranno la presenza di Monferace sotto i cappelli “Grignolino<br />
del Monferrato Casalese” e “Grignolino d’Asti”,<br />
questo perché si tratta di vini che seguono le regole stabilite<br />
da un rigido disciplinare di produzione scritto dai soci<br />
fondatori dell’Associazione, che prevede: la produzione<br />
esclusivamente nelle migliori annate; l’impiego esclusivo<br />
dell’uva Grignolino, un affinamento di 40 mesi, calcolato<br />
dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui almeno<br />
24 in botte di legno; le uve devono provenire da vigneti<br />
piantati su terreni calcarei – limosi e calcarei – argillosi;<br />
il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a<br />
4.000 e la resa massima di uva non deve superare le 7 tonnellate<br />
per ettaro. Ma cosa racconta poi il vino in bottiglia?<br />
Che è frutto dei vigneti più storici e più vocati nei parchi<br />
vitati delle aziende, per un totale di 4,23 ettari: il 45,5%<br />
sono singole vigne e il 36,4% singole parcelle. Se il risultato<br />
vede i valori alcolometri attestarsi attorno ai 14,6%<br />
Vol., interessanti sono anche gli aspetti della potenza dei<br />
tannini e la struttura, che denotano come il potenziale<br />
evolutivo dei Monferace superi i 20 anni di età. Per una<br />
produzione totale che oggi si arresta alle 30mila bottiglie<br />
annue, vedendo inevitabilmente un posizionamento sul<br />
mercato mirato, con un prezzo medio allo scafale medio<br />
che si aggira attorno ai 40 euro in Italia, nelle regioni del<br />
nord, e all’estero, tra Estremo oriente, America, Svizzera,<br />
Danimarca, Olanda, Australia e Belgio. E nel futuro? I key<br />
factor su cui puntare per l’universo del Monferace sono<br />
tre e strettamente correlati tra loro: produzioni contenute<br />
e di qualità, il racconto di un’antica tradizione produttiva<br />
e lo stretto legame tra un’uva, il Grignolino, e il perimetro<br />
di territorio piemontese tra Asti ed Alessandria. Per un<br />
nuovo caso che conferma: “Piccolo è bello”.<br />
Photo: Sara Giorcelli<br />
GIRAMONDO