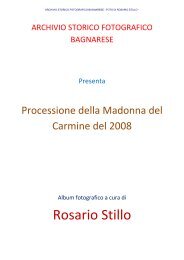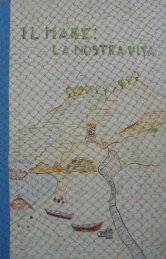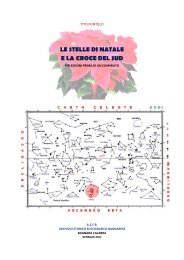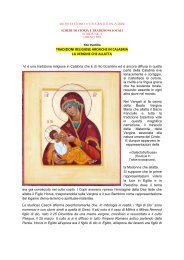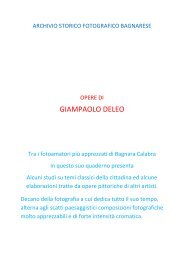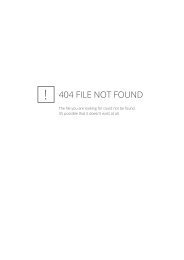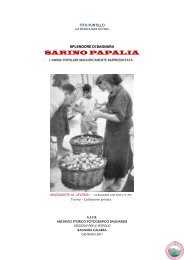Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Naturalmente la formazione dei venti e la loro direzione dipendevano da altri fattori che il<br />
nostromo, poverino, non poteva sapere, perché, allora, i marinai navigavano in conformità a<br />
tradizioni orali tramandate di padre in figlio, miste a credenze religiose. La conoscenza tecnica era<br />
appannaggio <strong><strong>del</strong>la</strong> Reale Marina o <strong><strong>del</strong>la</strong> marina mercantile che pilotavano navi a vapore di grossa<br />
stazza. Lo strumento <strong><strong>del</strong>la</strong> marina mercantile principe era sempre la bussola usata da tutto il tipo<br />
di naviglio che allora percorrevano i mari. Per i viaggi più lunghi, quindi velieri di grossa stazza, i<br />
marinai usavano anche il “teodolite” con la quale si misuravano gli angoli sia azimutali che<br />
zenitali. E’ noto che fino al 1874 i marinai calcolavano solo la latitudine, misurando l’altezza <strong>del</strong><br />
sole sull’orizzonte di giorno, o <strong><strong>del</strong>la</strong> stella polare di notte. La longitudine fu introdotta solo qualche<br />
anno dopo, utilizzando il meridiano di Greenwich (Londra) indicante 0°.<br />
Ritornando ai nostri vecchi marinai, si tramandava che la “strata di santu iapicu” normalmente<br />
avesse la direzione (rosa dei venti) da maestrale a scirocco. Quando si poneva da ponente a<br />
levante, soffiavano i venti da nord, e secondo loro, veniva la bufera; se si poneva da grecale a<br />
ostro, soffiava lo scirocco o il libeccio, che i vecchi pescatori chiamavano “u tempu chi veni du<br />
canali”.<br />
Anche la luna entrava a pieno titolo nelle credenze marinare, non perché “intenerisse i loro<br />
cuori” ma perché poteva essere segno che il tempo cambiasse, e sentenziavano: “Luna a barchetta<br />
marinari all’erta !” che secondo gli antichi indicava un natante nel mare in tempesta; il detto “luna<br />
diritta marinari in cuccetta !” indicava buon tempo. Per tutto il tempo che Francesco navigava, era<br />
un continuo chiedere, approfondire entro i limiti <strong>del</strong>le conoscenze dei nostri esperti marinai:<br />
“perché la luna, a volte, ha quella nebbiolina attorno ?”‐‐<br />
“indica che domani ci sarà vento”, ‐<br />
“nostromo perché il vento di terra è chiamato così ?”<br />
“perché viene da terra, come dice la parola stessa !”<br />
Erano risposte senza alcun fondamento tecnico o almeno ne avevano poco considerato che così<br />
ci si spostava da una parte all’altra in quegli anni.<br />
<strong>Carresi</strong> le cognizioni tecniche razionali e utili le avrebbe apprese durante il servizio militare<br />
prestato nella Regia Marina.<br />
Studiò in maniera approfondita, con scienza e coscienza, sui testi che riusciva ad acquistare a<br />
Napoli o su quelli che gli davano in prestito gli ufficiali <strong>del</strong>le navi militari. Così capì che il vento di<br />
terra, come tutti i venti, era uno scambio di calore tra il mare e la terra collegato al tasso di<br />
umidità, nuvolosità, alle differenze di pressione tra una parte e l’altra <strong>del</strong>le aree geografiche <strong>del</strong><br />
globo…; che non sempre la luna in quella posizione significava bufera o bonaccia.<br />
Ma, che la luna influenzasse i mari e gli oceani con la forza di gravità, e che il suo effetto<br />
raddoppiava quando il sole e la luna stavano lungo lo stesso asse <strong><strong>del</strong>la</strong> terra, assieme all’utilizzo<br />
<strong>del</strong> barometro o il sestante, divennero conoscenze normali per il <strong>Carresi</strong>, tanto da affrontare<br />
l’esame d’idoneità per ottenere il titolo di Padrone marittimo e superarlo brillantemente. Il<br />
patentino lo abilitava al comando dei velieri.<br />
Il <strong>Carresi</strong> era un uomo alto di colorito bruno, con due labbra carnose che gli davano un' aria di<br />
serietà, d’imponenza per i due baffoni a manubrio che gli trapassavano il labbro da una parte<br />
all’altra; occhi scuri e sopracciglia ad arco che evidenziavano due zigomi alti ma non pronunciati;<br />
una dentatura perfetta, ovale lungo, un naso regolare ed una fronte ampia e spaziosa: un<br />
bell’uomo. Aveva un' eleganza naturale, uno stile inconfondibile, vestiva con cura ma sobriamente.<br />
Rispettava tutti e tutti ricambiavano. Francesco da qualche tempo corteggiava una ragazza di<br />
nome Felicia, figlia di commercianti di tessuti <strong>del</strong> posto soprannominati “i calarchi” per via <strong>del</strong><br />
cognome <strong><strong>del</strong>la</strong> madre, appunto Calarco . Era una ragazza esile d’altezza media, capelli neri e<br />
ondulati; attraeva più per la simpatia che suscitava quando parlava, che per la bellezza dei<br />
8