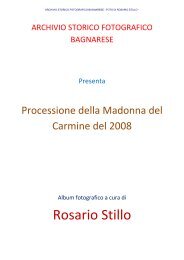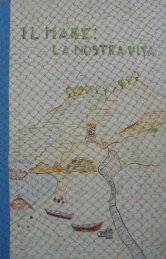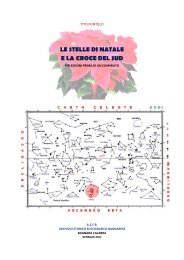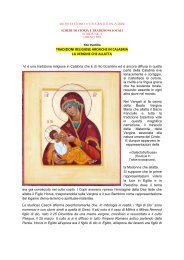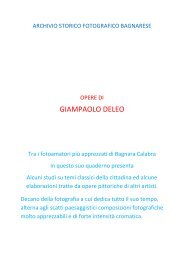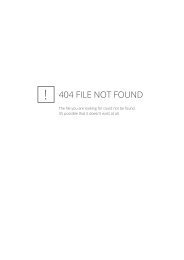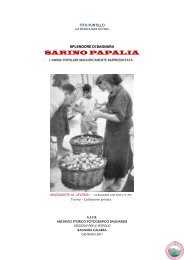Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
Storia della famiglia del capitano Carresi Di Franco Caratozzolo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Donna Felicia era considerata “strana” dalla gente, ma non superba , specie tra i pescatori,<br />
considerati, nella scala sociale, lo strato più basso. Dato che il figlioletto a Carmela, si sedeva,<br />
inforcava gli occhiali e leggeva, non prima di aver rilevato che la lettera fosse di suo figlio Saro.<br />
“<strong>Di</strong>ce che sta bene dove l’hanno mandato a fare il militare, e che, forse, con la nave, partirà verso<br />
la Libia … saluti e baci Saro.” La lettera, ovviamente, era scritta da un'altra persona, in quanto<br />
Saro, come i suoi parenti, era analfabeta. Poi, prima che Filomena “occhi di gatta” parlasse, Felicita<br />
prendeva l’inchiostro e la penna, mentre Filomena tirava dal tascone <strong>del</strong> “faddale”, (grembiule)<br />
una busta e un foglio per la risposta. Filomena dettava e Felicia scriveva:<br />
“Caro Saro, speriamo che stai bene, noi pure stiamo bene e anche se non vogliamo dobbiamo<br />
stare bene per forza. L’annata <strong>del</strong>le alici non è andata tanto bene; perché alici non ce n’erano<br />
manco di passaggio.<br />
“Il papà con il pappù e i tuoi sette fratelli stanno riparando la barca e la rete, ti raccomando mettiti<br />
la maglia di lana per non prendere freddo, perché mi hanno detto che lì il freddo lo ammaccate<br />
con le mani. Saluti e baci da (seguiva elenco di tutti i fratelli e sorelle) oltre che dalla mamma e dal<br />
padre la nanna e il pappù.”<br />
Il foglio infilato dentro la busta, con la lingua umettava il bordo <strong><strong>del</strong>la</strong> stessa, poi Filomena,<br />
dimenando l’ampia saia, usciva. Lungo la giornata, spesso, si avvicinava tanta gente, la maggior<br />
parte <strong>del</strong>le volte sempre bagnarote, che accusavano qualche malessere. Il medico era troppo<br />
lontano. Così, ci si rivolgeva a persone di grande esperienza: Donna Felicia,come a Bagnara, era<br />
una di queste. Conosceva le erbe medicinali. Prima che la chimica prendesse piede, ci si curava,<br />
una volta, con ciò che offriva la natura. Ma la bontà di un erba non era proporzionale ad alcuna<br />
certezza. Molto spesso, la valenza di questa la si doveva al caso; se qualcuno, per esempio,<br />
soffrendo di un certo malore, avesse assaggiato un certo tipo di foglia, e spariva il malore si aveva<br />
la prova provata che quella foglia era buona. Da qui l’uso di quell’erba e la trasmissione orale agli<br />
altri. In alcune parti <strong>del</strong> meridione, l’uso <strong>del</strong>le erbe era accompagnato da atti o parole che<br />
sapevano di magia. Per esempio, chi aveva avuto la disavventura di toccare le ortiche, il fastidioso<br />
bruciore era eliminato (sic!) strofinandosi con foglie di sambuco e gridando: “Nesci ardica e trasi<br />
sambucu !”<br />
Donna Felicia sapeva, invece, che il taglio che procurava emorragia era bloccato con i dischetti<br />
presi all’interno <strong><strong>del</strong>la</strong> canna verde; con la bocca infiammata ti consigliava di masticare le foglie di<br />
basilico; per il “nervoso” la camomilla; il cavolo per le ulcere varicose, mentre l’aglio per le punture<br />
d’insetti; la lattuga per le infiammazioni <strong><strong>del</strong>la</strong> pelle; il limone per la digestione lenta; le noci contro<br />
la stitichezza. Tutte queste conoscenze Felicia le metteva a disposizione degli altri.<br />
Nelle lunghe sere d’inverno, quando il cielo annuvolato e nero prometteva pioggia, si preparava<br />
il braciere per riscaldare la stanza. Lo si lasciava fuori dopo aver messo sotto legna secca e in<br />
mezzo il carbone, <strong><strong>del</strong>la</strong> carta che si accendeva con un fiammifero. Se c’era il vento, ci pensava lui a<br />
mantenere la fiamma e infocare la legna e carbone altrimenti il ventaglio a listelle era più che<br />
buono per lo stesso fine. Le sorelle si mettevano a giocare con le scintille, che si sollevavano dal<br />
braciere per il vento e sparivano in alto. Le sorelle si lasciavano avvolgere da esse fino a quando la<br />
madre non le richiamava:<br />
“Attente agli occhi … poi ricordatevi che le scintille sono le animelle dei bambini morti che girano<br />
nell’aria !”<br />
Così rientravano tutte, impaurite.<br />
C’era un orario particolare <strong><strong>del</strong>la</strong> sera, che era caratterizzato dal passaggio, su quella via, di varia<br />
umanità. Come se si fossero dati appuntamento. Alla marina non vi abitava solo gente di mare, vi<br />
erano anche contadini. Venivano dalle campagne, bonificate, in parte, <strong><strong>del</strong>la</strong> Ciambra. Così, da una<br />
parte arrivavano, in fila, i contadini con tutta la <strong>famiglia</strong>: in testa il padre, poi a seguire la madre e i<br />
figli. Sempre identico, sempre uguale quel passaggio; il padre aveva la roncola o l’accetta, la madre<br />
26