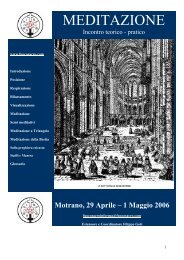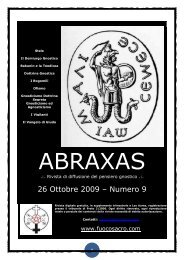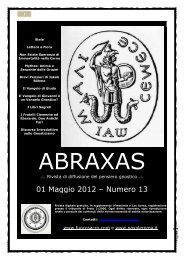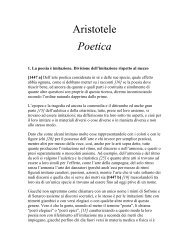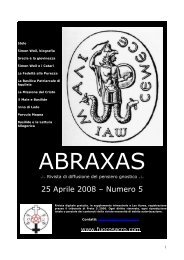Lex Aurea Libera Rivista Digitale Di Formazione ... - Fuoco Sacro
Lex Aurea Libera Rivista Digitale Di Formazione ... - Fuoco Sacro
Lex Aurea Libera Rivista Digitale Di Formazione ... - Fuoco Sacro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La Mauerische Trauermusik di Mozart fra simbologia massonica e<br />
tensioni romantiche<br />
Alessandro Nardin<br />
Se è vero che la dedizione di Mozart nei confronti della massoneria era stata<br />
tutt’altro che marginale, anzi, sostenuta con convinzione, è purtroppo altrettanto<br />
vero che la produzione musicale creata per la Fratellanza non possa definirsi<br />
artisticamente all’altezza della passione riversata dal musicista nella partecipazione<br />
ai lavori muratori.<br />
Fra le diverse pagine realizzate, tuttavia, è possibile individuarne una che a buon<br />
diritto può ritagliarsi un posto fra i capolavori mozartiani: la Mauerische<br />
Trauermusik K 477, sublime creazione che Mozart inserì nel proprio catalogo nel mese di luglio del<br />
1785, “per la morte dei fratelli Mecklenburg ed Estherazy”, sebbene non vi sia assoluta certezza su<br />
modi e finalità della composizione 1 .<br />
In 69 battute il “fratello” Mozart condensa una delle più profonde riflessioni sulla morte che la<br />
storia della musica abbia consegnato all’umanità, senza attendere la Messa da Requiem, senza<br />
confrontarsi con un testo liturgico, sublimando il passaggio dalla vita alla morte, nonché un<br />
alchemico ritorno dalla morte in vita, in una precoce idea di “musica assoluta”, per dirla con<br />
Dalhaus, in cui lacerazioni tragiche e rasserenamenti improvvisi, spiritualità e fervore mistico<br />
convivono in un raro esempio di pre-romanticismo musicale, sospeso fra arte e misticismo.<br />
Una pagina che incanta al primo ascolto, enigmatica ed inquietante fin dal primo apparire dei suoni,<br />
una prometeica creazione dal nulla, un sinistro bagliore nelle tenebre, la terza minore degli oboi che<br />
scivola sulla sensibile, marcato nel suo divenire da una premonitrice doppia forcella in crescendodiminuendo.<br />
Il colore solenne dei fiati, il perenne trasmutare dei suoni, la rinuncia alla tirannia del melodismo<br />
galante o del patetismo affettivo: in questo perpetuum creativo si riconosce la precisa volontà del<br />
superamento i limiti; ed è proprio questa semplice affermazione che è in grado di esprimere<br />
l’impressione di un intero ascolto, e quindi di guidare l’ascoltatore, come un iniziato, attraverso i<br />
sentieri nascosti che le note tracciano di volta in volta.<br />
Un superamento, un’appropriazione di spazi indebiti, è la stessa scelta di celebrare la morte al di<br />
fuori di una liturgia religiosa, sfuggendo al rigido vincolo dettato dai testi sacri canonici (il Requiem<br />
cattolico, i corali protestanti); l’occupazione laica di una dimensione religiosa attraverso una liturgia<br />
di Stato è una invenzione della Rivoluzione Francese, la quale ha sostituito alla celebrazione in<br />
chiesa la grande celebrazione en plein air accompagnata dalle bande civiche e decorata dagli aerei<br />
suoni delle marce funebri, prima inesistenti.<br />
Non certo una marcia, non una processione bandistica di massa, la Musica Funebre Massonica è<br />
quindi un’indagine strumentale priva di riferimenti testuali (se non indiretti, come vedremo), così<br />
come di autorità confessionali, terreno di ricerca musicale ed interiore per il compositore, il quale<br />
comincia la sua opera di ri-creazione plasmando a proprio piacimento le rigide ripetizioni del<br />
principio formale scelto, quella semplice forma tripartita o ternaria, nella quale una sezione iniziale<br />
(A) si ripete pressoché identica al termine di una sezione centrale (B) costituita da materiale<br />
musicale diverso.<br />
L’apertura è affidata ai fiati, strumenti massonici per eccellenza, la cui importanza simbolica non<br />
viene tradotta in musica soltanto tramite il cospicuo numero impiegato (due oboi, due corni, un<br />
1 G. Knepler, Wolfgang Amadé Mozart – Nuovi percorsi (Milano, 1995), p. 189<br />
33