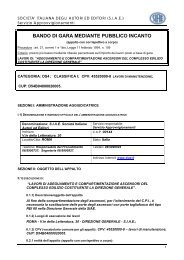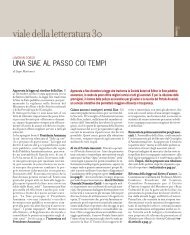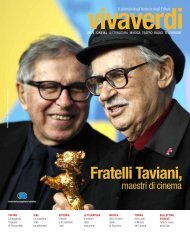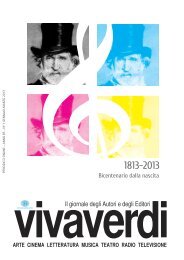EDITORI MUSICALI,UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO - Siae
EDITORI MUSICALI,UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO - Siae
EDITORI MUSICALI,UNA PASSIONE LUNGA UN SECOLO - Siae
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VIVAVERDI<br />
38<br />
anniversari<br />
Festival: accanto alle opere di Sellars quali<br />
Peony Pavilion (1998), che parte da un testo del<br />
poeta cinese Tang Xianzu (XVI sec.), e The Story<br />
of a Soldier (1999), che traduce in epoca<br />
moderna, attraverso i latinos (gli immigrati<br />
messicani in America), il senso di esclusione<br />
vissuto da Stravinskij, ci sono il Woyzeck (2002)<br />
di Büchner, che Wilson ha costruito insieme<br />
alla musica di Tom Waits, espressione visiva,<br />
rarefatta e non retorica del sentimento, e<br />
Voyage au bout de la nuit (1999) della Socìetas<br />
Raffaello Sanzio, trascrizione in forma di dolorosa<br />
partitura vocale del celebre dramma di<br />
Céline. Ma queste sono solo alcune delle opere<br />
che hanno raccontato, con testi di tradizione,<br />
una storia tutta contemporanea, con un linguaggio<br />
che non ha concesso molto alle abitudini<br />
dello spettatore; e se scorriamo velocemente<br />
i cartelloni, saltano fuori i nomi del belga Jan<br />
Fabre (1987, 2001), che riunisce in sé i ruoli di<br />
regista, drammaturgo, coreografo e scenografo<br />
dando vita a un teatro personalissimo e provocatorio,<br />
in cui ogni materia e funzione del corpo<br />
si fanno linguaggio di scena; il gruppo catalano<br />
de La Fura dels Baus, nato alla fine degli anni<br />
Settanta come compagnia di strada e approdato<br />
poi ai più importanti palcoscenici internazionali,<br />
conservando sempre quella particolare<br />
vocazione alla scomoda denuncia oltre che al<br />
dialogo non convenzionale con lo spettatore;<br />
Giorgio Barberio Corsetti, presente nel cartellone<br />
del festival fin dalla prima edizione del<br />
1986 ed ospitato nel 2003 in un singolare esperimento<br />
drammaturgico in collaborazione con<br />
Giovanni Lindo Ferretti, ex leader dei CCCP;<br />
William Kentridge, che mescola animazione e<br />
spettacolo dal vivo, denunciando senza retorica<br />
la dura condizione di vita nel Sudafrica dell’apartheid;<br />
Alessandro Baricco o Stefano Benni,<br />
entrambi chiamati a mettersi in scena attraverso<br />
letture che chiedono alla parola di farsi spazio<br />
e spettacolo; Francesca Lattuada con il suo<br />
circo che racconta storie più che offrire solo<br />
numeri di acrobazia, o Bartabas, che attorno al<br />
cavallo ha costruito un altro modello di vita;<br />
Frank Castorf, infine, il cui sguardo crudelmente<br />
fisso su un mondo omologato denuncia<br />
la nevrosi quale condizione dominante ed abituale<br />
nella vita quotidiana.<br />
Il palcoscenico, zona franca, si è trasformato<br />
così nel luogo ideale per un attraversamento<br />
delle frontiere – nel senso linguistico ed artistico,<br />
geografico e sociale –, dove gli artisti mesco-<br />
lando in modo libero e denso di significato ogni<br />
forma e linguaggio, hanno cercato l’espressione<br />
ed il modo adatto a dare voce alle tensioni del<br />
mondo contemporaneo, alle sue contraddizioni,<br />
alla sua molteplicità di messaggi e di strumenti<br />
di comunicazione.<br />
Non a caso, infatti, alcune delle opere ospitate,<br />
soprattutto per la danza e per la musica, hanno<br />
presentato un uso strumentale o critico della<br />
tecnologia: tecnologia come mezzo per indagare<br />
e sperimentare le molteplici possibilità del<br />
suono (da Berio a Nono a Xenakis) oppure quale<br />
elemento che modifica il rapporto dell’uomo<br />
con il corpo e con lo spazio, agendo sulla percezione<br />
stessa – veicolo primo dell’esperienza.<br />
Alla danza soprattutto, ontologicamente, si<br />
mostra affidato in questo ultimo ventennio del<br />
ventesimo secolo il racconto del corpo – ovvero<br />
della vita in prima persona. E così le coreografie<br />
dicono di un corpo sempre in movimento<br />
oppure immobilizzato, apparentemente libero<br />
e pronto alle più estreme esperienze eppure<br />
spesso insensibile, insoddisfatto, incapace di<br />
avvicinare un altro corpo, di reagire al circostante;<br />
il corpo come zona di confine fra dentro<br />
e fuori, fra l’interiorità ed il mondo esterno,<br />
non più negato: esso è l’uomo stesso, nella sua<br />
totalità. Da Susanne Linke a Karin Saportà; dalla<br />
divertita danza senza “stile” di Jean Claude<br />
Gallotta a quella innovativa e colorata della<br />
Compagnie Montalvo-Hervieu; da Michael<br />
Clark e i DV8 a Jirí Kylián (cha ha abbattuto il<br />
tabù di una danza consacrata alla giovane età,<br />
creando una straordinaria compagnia di ultraquarantenni)<br />
e Angelin Preljocaj fino al White<br />
Oak Dance Project, compagnia di giovani danzatori<br />
guidata dalla grande esperienza di<br />
Mikhail Baryshnikov, e ai giovani – ma non<br />
troppo – gruppi italiani (Enzo Cosimi, Lucia<br />
Latour, Virgilio Sieni, Paola Rampone,<br />
Kinkaleri, Sosta Palmizi) per giungere poi a<br />
nomi che sembrerebbero abitare ormai soltanto<br />
i manuali quali Trisha Brown, Carolyn<br />
Carlson, Alain Platel, Merce Cunningham,<br />
William Forsythe, Maurice Bejart e Bill T. Jones.<br />
Il corpo recuperato dalla danza moderna, s’è<br />
detto, ma anche quello che dalla tradizione ha<br />
recuperato la propria ragione, i propri ritmi ed<br />
un immaginario ancestrale come è il caso del<br />
flamenco (1990, 1991, 1992, 1995, 1997 – con le<br />
compagnie di Blanca Del Rey, Cristina Hoyos,<br />
Joaquin Ruiz), o del patrimonio culturale asiatico,<br />
con il Balletto dell’Accademia Reale Khmer<br />
(1997) o con le interpretazioni del Ramayana da<br />
parte di compagnie indiane, tailandesi e balinesi<br />
– e qui lo spettacolo è anche rito.<br />
Scorrendo il programma, emerge tuttavia con<br />
evidenza come sia la musica a esser sempre il<br />
vero fulcro del festival, in una gamma di possibilità<br />
che comprende il repertorio classico contemporaneo<br />
come le avanguardie elettroniche,<br />
passando per le tradizioni popolari.<br />
Nato come festival di musica contemporanea –<br />
ha ospitato Bussotti (1986, 1988), Xenakis<br />
(1988, 1994), Maderna (1992), e poi Boulez<br />
(1987, 1988, 1991), Berio (1991, 1995), Heiner<br />
Goebbels (2000) e Michael Nyman (2001) –,<br />
negli anni RomaEuropa ha ampliato la propria<br />
programmazione fiino ad includere, accanto<br />
alle raffinate composizioni contemporanee,<br />
punto fermo per tutti i venti anni, le musiche<br />
del Novecento in molte delle sue declinazioni,<br />
compreso lo sterminato panorama dell’ultima<br />
musica elettronica: dal progetto intermusicale<br />
che ha affiancato Manu Dibango all’Orchestra<br />
Nazionale di Lille (nel 1989), all’apertura alle<br />
musiche del mondo con i primi concerti italiani<br />
di Cheb Khaled (1990), Angelique Kidjo<br />
(1990), Cesaria Evora (1992), Taraf de Haidjuk<br />
(1993), fino agli incontri singolari quali quello,<br />
rivoluzionario, tra Robert Wilson e Philip Glass<br />
(Monsters of Grace 2.1), quello, più meditato ed<br />
evocativo, tra Bill T. Jones e Max Roach, il più<br />
grande batterista vivente (Another History of<br />
Collage), o anche quello, tutto barocco, fra<br />
François Raffinot e Michael Nyman (Garden<br />
Party, 1990).<br />
E così, con il passare degli anni, RomaEuropa<br />
Festival una sua identità l’ha costruita, e crescendo,<br />
talvolta in modo discontinuo, ha sviluppato<br />
un percorso artistico che ha fatto della<br />
capitale un palcoscenico della modernità, sia<br />
essa quella accattivante, colorata e divertita, che<br />
quella più difficile della denuncia e della sperimentazione,<br />
rinnovando ogni anno la sfida<br />
piuttosto difficile presentata da un mondo<br />
dominato sempre più da una globalizzazione<br />
sorda ed egoista. Ma molto poco cosmopolita.