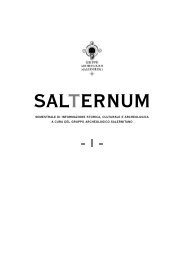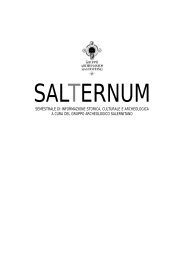Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Note<br />
1 Si veda una discussione recente <strong>del</strong>la problematica<br />
nei contributi presentati in occasione<br />
<strong>del</strong>la Conferenza Internazionale organizzata<br />
all’Istituto <strong>Archeologico</strong> Germanico nel<br />
giugno 2006 in onore di Dietrich Mertens i<br />
cui Atti sono in corso di stampa in un volume<br />
dei Palilia a cura di R. N. EUDECKER – M.<br />
MENZEL.<br />
2 L’esplorazione è stata intrapresa nel<br />
Settembre 1976, grazie ad un cospicuo finanziamento<br />
<strong>del</strong>la Cassa per il Mezzogiorno.<br />
Colgo l’occasione per rinnovare la mia gratitudine<br />
a B. d’Agostino, allora Soprintendente<br />
Archeologo, che ha voluto affidarmi la direzione<br />
<strong>del</strong>lo scavo. A W. Johannowsky devo<br />
molti consigli sulle fasi iniziali <strong>del</strong>la esplorazione<br />
ed il sostegno alla domanda di<br />
Concessione di Scavo presentata nel 1982,<br />
successivamente al mio trasferimento nei<br />
ruoli <strong>del</strong>la University of Alberta<br />
(Edmonton, Canada). G. Tocco ha quindi<br />
sostenuto in numerose occasioni il progetto<br />
canadese. Last but not least, la mia profonda<br />
gratitudine va a M. L. Nava, attuale<br />
Soprintendente, che ha voluto coinvolgermi<br />
in recenti iniziative sulla musealizzazione<br />
<strong>del</strong> sito.<br />
3 Alla fine degli anni ’70, quando fu intrapresa<br />
l’esplorazione <strong>del</strong> sito di Roccagloriosa, si<br />
discuteva ancora (in mancanza di specifici<br />
dati archeologici), se tali siti fortificati di<br />
altura fossero mere cinte di difesa a controllo<br />
di un territorio caratterizzato da occupazione<br />
sparsa o se potesse trattarsi di fortificazioni<br />
funzionali ad un abitato agglomerato:<br />
la problematica è stata analizzata in<br />
GUALTIERI 1987.<br />
4 Si considerino ad esempio i risultati conseguiti<br />
sull’ampio pianoro di 6-7 ettari denominato<br />
Area DB e le carte di distribuzione<br />
dei materiali rinvenuti in superficie presentate<br />
in Roccagloriosa II 2001, pp. 16-20<br />
5 Secondo un mo<strong>del</strong>lo di sviluppo <strong>del</strong>ineato<br />
da A. La Regina per gli abitati di area sabellica<br />
(LA REGINA 1991).<br />
6 Fondamentale, in un momento iniziale<br />
<strong>del</strong>la ricerca, è stato il Convegno di<br />
Acquasparta su ‘L’emergenza <strong>del</strong> politico nel<br />
mondo osco-lucano’ i cui Atti sono stati in parte<br />
pubblicati in Italici. Si veda ora Roccagloriosa I<br />
1990; Roccagloriosa II 2001.<br />
7 Il sito costiero identificabile con la Pyxous<br />
Micitea cui fa riferimento Strabone 6.1.3.<br />
8 In questo senso si esprime N. Purcell in un<br />
articolo di sintesi sull’Italia meridionale nel<br />
SALTERNUM<br />
IV secolo a. C. Sia pure basandosi su una<br />
documentazione ancora preliminare,<br />
Purcell sottolinea il carattere emblematico<br />
<strong>del</strong> ‘caso’ Roccagloriosa: «..the formation<br />
of nucleated settlements like Roccagloriosa<br />
in Western Lucania, in their early stages<br />
seem to respond to purely local and shortterm<br />
needs, until the arrival of a major fortified<br />
enceinte, which seems to hint that the<br />
whole process of nucleation might better<br />
be seen against the background of awareness<br />
of an urban ideal and the political<br />
institutions associated with it. In fact, a historical<br />
process can be seen at work which<br />
enables us to make sense of the whole of<br />
South Italy in the late fourth and early third<br />
centuries…», (PURCELL 1994, pp. 395-396).<br />
9<br />
GUALTIERI 2000, passim.<br />
10<br />
FRACCHIA - GUALTIERI 2004.<br />
11 Italici 1990, pp. 161-197.<br />
12 Si consideri il testo di defixio su laminetta<br />
plumbea dal complesso A , molto probabilmente<br />
associata all’attività rituale che vi si<br />
svolgeva. Il testo, pubblicato da P.<br />
Poccetti, include una serie di gentilizi italici<br />
(quali eris, eganatis e probabilmente pollies)<br />
e antroponimi (quali gavis e mamerex),<br />
(POCCETTI 1990, pp. 141-150); si vedano<br />
anche le osservazioni al riguardo in<br />
CAMPANILE 1993, pp. 369-371.<br />
13 Roccagloriosa II 2001, pp. 97-116.<br />
14 Si vedano a tal riguardo le fondamentali<br />
osservazioni di TORELLI, in A. MOMIGLIANO<br />
e A. SCHIAVONE (eds.) Storia di Roma, vol. 1,<br />
Torino 1988, pp. 53-74 (in particolare , pp.<br />
72-73), sulle trasformazioni sociali di IV<br />
secolo, in una più ampia prospettiva che<br />
abbraccia le società locali <strong>del</strong>la penisola italiana.<br />
Con più specifico riferimento al territorio<br />
lucano, M. Torelli qualifica tale documentazione<br />
quale manifestazione, a livello<br />
archeologico, di una vera e propria ‘liberazione<br />
di servi’ proiettandola nel più vasto<br />
ambito <strong>del</strong>le trasformazioni socio-economiche<br />
<strong>del</strong>le società italiche di IV-III secolo:<br />
«A ben vedere, il fenomeno che investe la<br />
Grande Lucania poco prima <strong>del</strong>la metà <strong>del</strong><br />
IV secolo a.C. è il prodotto <strong>del</strong>le stesse<br />
spinte sociali ed economiche che con un<br />
‘effetto domino’ dall'Etruria fino alla Sicilia,<br />
passando attraverso la società di Roma<br />
tardo-repubblicana, hanno condotto al<br />
definitivo superamento <strong>del</strong>le società indigene<br />
arcaiche e all'allargamento dei corpi civici<br />
compressi dalle chiusure oligarchiche».<br />
- 26 -<br />
(TORELLI 1992, XIV-XV) Sulla nozione di<br />
'corpo civico' in relazione alle comunità italiche<br />
si considerino anche i commenti, più<br />
generali, di LOMBARDO (1999, p. 180).<br />
15 Si veda BOKONYI, COSTANTINI e FITT, pp.<br />
323-332; Fourth Century B. C., cap. 7.<br />
16 E’ stata rinvenuta nel settore ovest <strong>del</strong><br />
Pianoro Centrale in prossimità <strong>del</strong>la monumentale<br />
porta di accesso all’interno <strong>del</strong>la fortificazione<br />
(Roccagloriosa II 2001, pp. 186-187).<br />
17 Sanniti 2000, pp. 224-228.<br />
18 Una prima messa a punto <strong>del</strong> contesto storico-archeologico<br />
in cui si colloca questo<br />
importantissimo documento epigrafico,<br />
contesto che, come sopra specificato, era<br />
stato oggetto di sistematiche ed estensive<br />
indagini intese a definire il livello di organizzazione<br />
insediativa <strong>del</strong> sito lucano, hanno<br />
indotto a collocare la stesura <strong>del</strong> testo nei<br />
decenni iniziali <strong>del</strong> III secolo a. C.<br />
(GUALTIERI 2000, pp. 247-253). Non è da<br />
trascurare il fatto che, pur in assenza di una<br />
più precisa datazione <strong>del</strong> contesto archeologico<br />
di rinvenimento (in giacitura secondaria),<br />
la giacitura <strong>del</strong> manufatto ad uno strato di<br />
dilavamento in prossimità <strong>del</strong>la porta centrale<br />
(supra, n.15) fornisce di per sé un evidente terminus<br />
ante quem <strong>del</strong>la fine <strong>del</strong> III secolo a. C.<br />
per la sua datazione. Opportunamente, H.<br />
Galsterer, nei suoi commenti conclusivi ad<br />
una Conferenza su “La maturazione politica dei<br />
popoli italici” (tenuta all’Università di Napoli<br />
“Federico II” nel Febbraio 2000), ha senza<br />
esitazione sottolineato la profonda diversità<br />
di contesto culturale e cronologico tra i due<br />
documenti. Gli Atti <strong>del</strong>la citata conferenza<br />
sono purtroppo ancora in cds.<br />
19<br />
POCCETTI 2001, p. 268.<br />
20 Da ultima, DEL TUTTO 2006, pp. 527-536.<br />
21 Su tale aspetto si veda l’ampia discussione<br />
di LETTA 1994.<br />
22 Roccagloriosa II 2001, pp. 13-18 .<br />
23 Illustrate in Roccagloriosa II 2001, figg. 7-8.<br />
24 Sanniti 2000, pp. 33-35.<br />
25 Si consideri, a tal proposito, la collocazione<br />
di un edificio generalmente interpretato<br />
quale probabile sede <strong>del</strong>la vereia nella Pompei<br />
sannitica (Sanniti 2000, pp. 107-109).<br />
26 Mi è gradito ringraziare H. Fracchia ed E.<br />
Lanza per uno scambio di vedute sulla cronologia<br />
<strong>del</strong>la più recente documentazione<br />
ceramica pertinente all’edificio in questione.<br />
La problematica è stata discussa in una Tesi<br />
di Dottorato difesa dalla Dott.ssa E. Lanza<br />
all’Università di Padova nel giugno 2006.