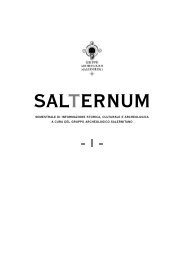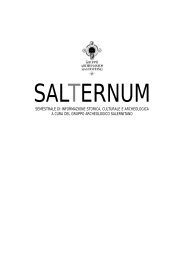Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fig. 3 - Pianta <strong>del</strong>l’Iseo di<br />
Pompei (da Divus Vespasianus).<br />
puteolane. E’ probabilmente questa l’interpraetatio graeca<br />
che riscosse maggior successo nei Campi Flegrei, se<br />
è vero che il culto venne importato dai mercanti e che<br />
fu praticato soprattutto da loro.<br />
Inoltre, la collocazione topografica <strong>del</strong> tempio non<br />
sembra conciliarsi con il testo <strong>del</strong>la lex, che parla di<br />
un’area nei pressi <strong>del</strong> mare e non in collina, dove invece<br />
si trova la aedes raffigurata sulla fiaschetta, raggiungibile<br />
con una scalinata e, appunto, un’ascensio.<br />
Topograficamente, i templi di Iside e di Serapide<br />
sono spesso ospitati nello stesso complesso monumentale<br />
o in santuari vicini (caso esemplare è l’Iseo-<br />
Serapeo <strong>del</strong> Campo Marzio a Roma); è pertanto ipotizzabile<br />
che il termine Isium designi sulla fiaschetta<br />
puteolana un templum dedicato ad entrambe le divinità,<br />
abbreviato per mancanza di spazio; considerando<br />
infatti la datazione tarda <strong>del</strong>la fiaschetta (fine III-inizi<br />
IV sec. d. C.) non desta meraviglia che si sia indicato il<br />
tempio con il solo nome <strong>del</strong>la dea, in quanto il culto<br />
di Iside in Italia diventerà molto presto preminente su<br />
quello <strong>del</strong> fratello-sposo. Non è un caso che a Pompei<br />
si sia deciso di edificare, in pieno II sec. a. C., un tempio<br />
ad Iside e non a Serapide, il quale continuerà ad<br />
avere un certo seguito soprattutto fra gli stranieri e i<br />
mercanti 42 , occupando però un ruolo sempre più marginale<br />
rispetto alla sposa ‘dai mille nomi’.<br />
Una <strong>del</strong>le attestazioni più importanti <strong>del</strong> culto isiaco<br />
a Pozzuoli è una statua interpretata da Fausto Zevi<br />
come ‘Iside Pelagia’ o ’Iside alla Vela’, che raffigura la<br />
dea nell’atto di utilizzare il proprio mantello alla stregua<br />
di una vela, di cui era considerata inventrice 43 .<br />
Pompei<br />
Anche a Pompei i culti egizi sono attestati precocemente<br />
ed è probabile che l’Iseo pompeiano, unico edificio<br />
<strong>del</strong> genere ben conservato in Italia, sia di poco<br />
posteriore al Serapeo puteolano. La prima attestazione<br />
dei culti nilotici a Pompei è un’iscrizione graffita all’in-<br />
SALTERNUM<br />
- 34 -<br />
terno di una sco<strong>del</strong>la a vernice nera, rinvenuta nel<br />
corso degli scavi eseguiti nell’area fuori Porta Nola 44 .<br />
L’iscrizione recita «Fila<strong>del</strong>fo ha dedicato agli Dèi<br />
Eueilatoi»; il termine Eueilatos è diffuso soprattutto in<br />
area egizia ed egeo-insulare, e sembra essere legato alle<br />
divinità nilotiche; anche il nome <strong>del</strong> dedicante è tipico<br />
<strong>del</strong>l’onomastica greco-egizia. Secondo l’opinione di S.<br />
De Caro, quindi, la parola Eueilatoi si riferisce alle le<br />
divinità egizie le quali, stando alla cronologia <strong>del</strong>la sco<strong>del</strong>la,<br />
sarebbero presenti in città già dal II sec. a. C., età<br />
compatibile con il loro ‘sbarco’ a Puteoli.<br />
Il santuario di Iside. Le fasi costruttive<br />
Nella sua fase attuale il santuario pompeiano 45 , che<br />
sorge nell’insula VIII, 7, occupata da molti rilevanti<br />
complessi monumentali quali il Foro Triangolare, i<br />
due Teatri e il c.d. tempio di Giove Meilichio (probabilmente<br />
da attribuire ad Esculapio 46 ) è frutto <strong>del</strong>la<br />
ricostruzione successiva al terremoto <strong>del</strong> 62 a. C.,<br />
intervento voluto dal liberto Numerio Popidio<br />
Ampliato a nome <strong>del</strong> figlio di sei anni, Numerio<br />
Popidio Celsino, che si guadagnò in questo modo un<br />
posto fra i decurioni 47 .<br />
Queste informazioni sono desumibili dall’epigrafe<br />
posta all’ingresso <strong>del</strong> peribolo <strong>del</strong> tempio (il quale<br />
misura 20,76 x 23,56 m) che racchiude tutte le strutture:<br />
il peristilio, la cella, un edificio ipetro (senza copertura)<br />
denominato purgatorium o megaron e tre altari - isolandole<br />
urbanisticamente dagli edifici circostanti.<br />
Ricostruire le fasi <strong>del</strong> santuario è operazione complessa<br />
ed articolata, e spesso gli studiosi hanno opposto<br />
opinioni divergenti circa la datazione di ciascuna fase.<br />
La fase ‘Sannitica’: II sec. a. C.<br />
La maggior parte degli esperti colloca la prima fase<br />
costruttiva all’età sannitica, in un periodo compreso<br />
fra il 200 e l’80 a. C. 48 o fra il 105 e l’80 49 ; la critica<br />
moderna tende generalmente a privilegiare la cronologia<br />
più alta.<br />
La pavimentazione originaria era in tufo, come<br />
dimostrano alcune lastre ad essa relative e alcuni elementi<br />
collegabili al sistema di scolo <strong>del</strong>le acque (canalette)<br />
riutilizzati nella ricostruzione post 62; inoltre le<br />
tracce di un colonnato precedente a quello attuale<br />
sono ancora visibili sullo stilobate in blocchi di tufo<br />
<strong>del</strong> peristilio 50 . Niente altro è rimasto <strong>del</strong>l’originaria<br />
decorazione <strong>del</strong> santuario nè <strong>del</strong>le sue strutture edilizie,<br />
fatta eccezione per tre capitelli di colonna, uno