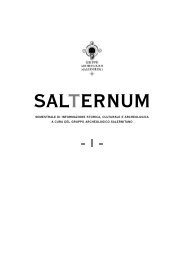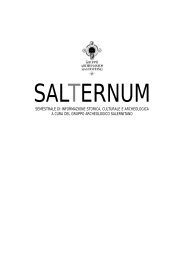Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
orientali in Campania, ritengo sia opportuno introdurre<br />
alcuni concetti di carattere prettamente storico-religioso<br />
utili a orientare la ricerca sui fenomeni cultuali di<br />
cui si tratta in questa sede. Le forme di culto antiche,<br />
studiate con grande acume critico da Ugo Bianchi 4 , ai<br />
cui lavori si fa riferimento in questa parte <strong>del</strong>la trattazione,<br />
possono essere divise in diverse categorie.<br />
Si intende per ‘culti soterici’ quel tipo di sistemi<br />
religiosi che fanno <strong>del</strong>la promessa <strong>del</strong>la salvezza un<br />
punto chiave nel proselitismo e nella pratica liturgica;<br />
la salvezza offerta può avere carattere ‘intramondano’<br />
– che si palesa in un miglioramento <strong>del</strong>le condizioni<br />
di vita <strong>del</strong> fe<strong>del</strong>e – oppure ‘extramondano’, basato<br />
sulla prospettiva di una vita migliore dopo la morte.<br />
Inoltre, le attese escatologiche possono essere colletive<br />
– e riguardare pertanto tutta la comunità dei<br />
fe<strong>del</strong>i - o solo individuali. Nel Cristianesimo, ad<br />
esempio, la speranza soterica individuale si accompagna<br />
all’attesa, di carattere universale, per la fine <strong>del</strong><br />
mondo e per la resurrezione dei morti. Spesso i culti<br />
soterici sono venati da forte misticismo, ovvero da<br />
un’intensa compenetrazione fra i piani <strong>del</strong> divino, <strong>del</strong><br />
cosmico e <strong>del</strong>l’umano; contrariamente a quanto<br />
avviene per le religioni ‘olimpiche’ – che potremmo<br />
chiamare anche ‘omeriche’ - in cui si percepisce la<br />
distanza fra il tempo dorato ed eterno degli dèi e<br />
quello duro e finito degli uomini, tipica <strong>del</strong>le religioni<br />
mistiche è la forte vicinanza <strong>del</strong>l’uomo al dio e,<br />
soprattutto, <strong>del</strong> dio all’uomo.<br />
La componente misterica, comune ad alcune religioni<br />
‘orientali’ (Iside, Mitra, forse Cibele) ed ‘occidentali’<br />
(Eleusi, Andania, Samotracia) può essere considerata<br />
come l’evoluzione di una concezione semplicemente<br />
‘mistica’ <strong>del</strong>la fede, basata sull’identificazione<br />
<strong>del</strong> fe<strong>del</strong>e con la divinità venerata sulla base di alcune<br />
esperienze comuni, in genere dolorose.<br />
La divinità ‘mistica’, mediante una vicenda personale<br />
di dolore e passione, vive la stesse sofferenze <strong>del</strong>l’essere<br />
umano e finisce quasi con l’identificarvisi. Il<br />
dolore patito da Demetra per il distacco dalla figlia,<br />
l’angoscia <strong>del</strong>la ricerca, la gioia <strong>del</strong> temporaneo ritorno<br />
sono sentimenti in tutto e per tutto umani.<br />
Le religioni di mistero offrivano al fe<strong>del</strong>e la possibilità,<br />
tramite un particolare rito o una serie di riti,<br />
di diventare ‘mysta’, traduzione latina <strong>del</strong> greco<br />
‘mystès’ che noi rendiamo in italiano con il termine<br />
‘iniziato’. I mystài avevano privilegi peculiari; chi aveva<br />
un legame speciale con una determinata divinità gode-<br />
SALTERNUM<br />
- 30 -<br />
va <strong>del</strong>la sua protezione e, per così dire, di una prossimità<br />
preclusa ai non iniziati; è il caso, ad esempio, <strong>del</strong>l’iniziazione<br />
ai culti isiaci. Secondo la celebre testimonianza<br />
di Apuleio è Iside stessa che, comparendo in<br />
sogno ai suoi fe<strong>del</strong>i, sceglie chi debba essere introdotto<br />
ai suoi misteri; il mysta ha la possibilità esclusiva di<br />
vivere in prima persona, attraverso una complicata<br />
serie di rituali, la vicenda <strong>del</strong> dio venerato e di provare<br />
dunque il dolore, l’angoscia, la speranza e infine la<br />
gioia per la risoluzione <strong>del</strong>la vicenda. L’aver rivissuto<br />
ritualmente le sofferenze di Iside rende l’iniziato<br />
degno di accedere al naòs <strong>del</strong> santuario e di essere<br />
venerato nel giorno finale <strong>del</strong>le celebrazioni come se<br />
fosse egli stesso un dio 5 : il fe<strong>del</strong>e, attraverso questa<br />
forma di pathei mathos, accede a un più alto livello di<br />
conoscenza e consapevolezza. Il rito ha pertanto una<br />
centralità fondamentale; in alcuni casi i culti misterici<br />
sono inamovibilmente legati a un determinato luogo,<br />
e non è possibile praticarli altrove 6 ; in altri casi invece<br />
è possibile che essi vengano celebrati ovunque, purché<br />
sempre all’interno di santuari o di strutture sacre adeguate<br />
7 .<br />
Ruolo centrale nella pratica dei misteri riveste però<br />
anche la dottrina; libri sono presenti nella ritualità<br />
misterica sin da tempi molto antichi. In alcuni tipi di<br />
culto però la conoscenza <strong>del</strong>la dottrina diventa importante<br />
quanto il rito stesso, se non addirittura preminente;<br />
non basta che l’iniziando, per entrare nel novero<br />
dei mystae, dimostri particolare devozione alla divinità<br />
(e sia anche in possesso dei necessari mezzi economici,<br />
come avviene per Apuleio) rivelandosi degno<br />
di ricoprire il ruolo cui aspira, ma è necessario che egli<br />
acquisisca determinate conoscenze che lo elevino a<br />
una nuova ‘sophia’. E’ l’anima stessa <strong>del</strong>l’iniziato a vivere,<br />
così, una vicenda di ascesa e purificazione verso la<br />
salvezza. Tali culti sono definiti ‘misteriosofici’ in<br />
quanto l’iniziazione non si risolve nella semplice ritualità<br />
ma in un graduale e complesso apprendimento da<br />
parte <strong>del</strong> mysta, elemento attivo nel processo di iniziazione<br />
mediante lo studio e la pratica <strong>del</strong>le idee <strong>del</strong>la<br />
setta. Il Mitraismo è probabilmente l’esempio più calzante<br />
di questo tipo di religiosità 8 .<br />
Iside e divinità egizie in Italia<br />
Intensi contatti fra l’Italia e l’Egitto faraonico vi<br />
furono già fra il IX ed il VI sec. a. C. Prova materiale<br />
di questi rapporti, che furono soprattutto di natura<br />
commerciale, sono i c.d. Aegyptiaca 9 , rinvenuti in mol