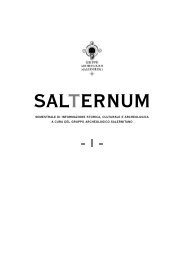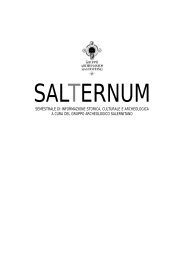Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Fig. 13 - Statua di Teti (?), rinvenuta<br />
a Lanuvio, poi entrata nella collezione<br />
Albani. Marmo bianco (h m 2,11).<br />
Parigi Museo <strong>del</strong> Louvre (Ma 2344).<br />
Fig. 14 - Statua di Teti (?), Museo <strong>del</strong> Louvre: dettaglio <strong>del</strong> piede sulla barca.<br />
Posillipo e Pozzuoli. Bisogna infatti tener presente che<br />
anche una sua identificazione quale Teti o Nereide è<br />
abbastanza incerta: la nave su cui la donna poggia i<br />
piedi non fa parte infatti <strong>del</strong>l’iconografia <strong>del</strong>le figlie di<br />
Nereo. Nonostante il più comune tipo iconografico<br />
ritragga la dea nell’atto di creare una vela usando il proprio<br />
mantello, tenuto fermo con il piede, qualora si trattasse<br />
di una statua di Iside Pelagia l’opera <strong>del</strong> Louvre<br />
potrebbe costituire invece una variante iconografia in<br />
cui la dea, spogliatasi <strong>del</strong>la veste, è rappresentata sul<br />
punto di utilizzarla quale vela. La statua, rinvenuta a<br />
Lanuvio nel 1764 ed entrata a far parte <strong>del</strong>la collezione<br />
Albani, è stata restaurata in modo radicale da<br />
Bartolomeo Cavaceppi il quale, partendo dai resti <strong>del</strong>la<br />
nave posti sotto il piede sinistro, ne ha ricostruito tutta<br />
la prua. Anche la testa è frutto <strong>del</strong>l’inventiva <strong>del</strong> restauratore,<br />
che ha tratto spunto dall’immagine <strong>del</strong>la<br />
Giunone Ludovisi. L’opera faceva parte di un gruppo<br />
di dieci sculture che decoravano il portico semicircolare<br />
di Villa Albani ed è stata portata a Parigi a seguito <strong>del</strong><br />
Trattato di Tolentino, nel 1797 92 .<br />
SALTERNUM<br />
- 42 -<br />
Città campane con attestazioni minori<br />
Cuma<br />
Anche a Cuma sono stati recentemente rinvenuti i<br />
resti di un Iseo: si tratta di un tempio la cui prima fase<br />
costruttiva risale al I sec. a. C., edificato a Sud-Ovest<br />
<strong>del</strong>l’Acropoli. Del santuario sono rimasti solo il podio,<br />
tracce <strong>del</strong> portico e di un bassin ornato di marmi policromi,<br />
con un sistema di adduzione e scolo <strong>del</strong>le<br />
acque 93 . Tale scoperta può essere collegata al rinvenimento,<br />
avvenuto nel 1836, di una statua raffigurante<br />
Anubis o un sacerdote con la maschera <strong>del</strong> dio sciacallo<br />
94 . Si tratta di un’opera inquadrabile nella temperie<br />
culturale isiaca puteolana: il dio, infatti, lungi dall’essere<br />
rappresentato come ‘l’abbaiante Anubis’, è vestito<br />
con un chitone lungo fino al ginocchio e una clamide<br />
che, agganciata alla spalla destra, scende con ampi<br />
panneggi fino alla tibia. Si notano le tracce <strong>del</strong> caduceo<br />
che il dio, assimilato da lungo tempo con Hermes,<br />
recava nella mano sinistra. L’atteggiamento è statico e<br />
‘civile’: è forte il contrasto fra le testa canina e l’impostazione<br />
pacata <strong>del</strong> corpo, che trasmette una gravità<br />
degna di un dio olimpico.<br />
Capua<br />
Attraverso la via Campana, i culti isiaci hanno raggiunto<br />
anche Capua; l’antica città etrusca ha restituito<br />
importanti attestazioni materiali collegabili alla<br />
religione egizia, quali ad esempio la celebre epigrafe<br />
in cui Iside è definita «una quae es omnia», <strong>del</strong> tardo III<br />
sec. d. C 95 . Interessanti sono anche i busti di Iside e<br />
Zeus-Ammon che decoravano alcune chiavi di volta<br />
<strong>del</strong>l’anfiteatro campano 96 . I mercatores capuani, stando<br />
alle attestazioni epigrafiche, frequentavano l’isola di<br />
Delo contemporaneamente ai puteolani; è pertanto<br />
ipotizzabile, sebbene manchino attestazioni materiali<br />
a dimostrarlo, che il culto <strong>del</strong>le divinità egizie fosse<br />
praticato fin da tempi abbastanza antichi (II-I sec. a.<br />
C. ?) Il fatto stesso che la testa di Ammon fosse collocata<br />
a decorare uno degli edifici più importanti, come<br />
era avvenuto anche per gli dèi più antichi <strong>del</strong>la città<br />
quali Volturnus, Diana Tifatina, Demetra, permette di<br />
pensare che le divinità egizie fossero entrate a pieno<br />
titolo nel pantheon cittadino 97 .<br />
Carinola<br />
Dal territorio <strong>del</strong>la cittadina campana (nei pressi di<br />
Piedimonte Matese) proviene un’epigrafe di notevole