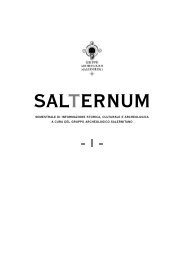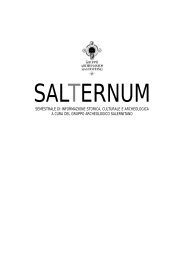Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
Download del file - Gruppo Archeologico Salernitano
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Note<br />
NOTE<br />
1 MALAISE 1972 b : tutta l’opera riguarda la diffusione<br />
dei culti isiaci in Italia. Per questo<br />
aspetto in particolare cfr. pp. 264-332.<br />
2 Non è possibile approfondire in questa<br />
sede un tema complesso e articolato come i<br />
rapporti fra Cristianesimo e Religioni orientali;<br />
basti ricordare la condanna di autori<br />
quali Firmico Materno (L’errore <strong>del</strong>le religioni<br />
profane) quale esplicativo <strong>del</strong> clima culturale<br />
<strong>del</strong>l’epoca.<br />
3 CUMONT 1929.<br />
4 BIANCHI 1979, pp. 3-60.<br />
5 Apuleio, Metamorfosi, lib. XI.<br />
6 Eleusi ne è l’esempio più tipico essendo il<br />
demo attico strettamente connesso all’aition<br />
dei Misteri Eleusini, allorquando Demetra si<br />
trasforma in vecchia abdicando alle sue funzioni<br />
divine per protesta contro l’iniquità di<br />
Zeus, venendo accolta dal re di Eleusi Celeo,<br />
figlio <strong>del</strong>l’eponimo fondatore <strong>del</strong>la città, cui<br />
la dèa insegna le regole <strong>del</strong> suo culto dopo<br />
aver svelato la sua vera identità e prima di<br />
ascendere nuovamente all’Olimpo; anche i<br />
culti di Samotracia e Andania ad esempio<br />
erano celebrato sempre nello stesso luogo.<br />
7 E’ il caso dei misteri isiaci: essi potevano<br />
essere celebrati in qualsiasi santuario ma i<br />
mystae potevano accedere ai privilegi legati<br />
al loro status esclusivamente nel santuario in<br />
cui erano stati iniziati. Pertanto era possibile<br />
che l’iniziazione venisse ripetuta più volte in<br />
templi diversi (Apuleio, Metamorfosi, XI).<br />
8 BIANCHI 1979, pp. 8-9; movimenti quali<br />
Orfismo, Pitagorismo, Gnosticismo appartengono<br />
a questa categoria. Fra i culti orientali<br />
il Mitraismo presenta di certo i più spiccati<br />
caratteri misteriosofici.<br />
9 Per Aegyptiaca si intendono piccoli manufatti<br />
di origine egizia quali ushabti (amuleti a<br />
forma di sarcofago), scarabei o imitazioni di<br />
questi rinvenuti in contesti italici, ed usati<br />
non per fini cultuali o religiosi ma anche<br />
estetici od ornamentali.<br />
10 DE SALVIA 2006.<br />
11 SFAMENI GASPARRO 1973, pp. 58-60.<br />
12 Ead., ibidem, p. 55.<br />
13 Ead., ibidem, pp. 31-32.<br />
14 Gli scavi di p.za Nicola Amore a Napoli<br />
hanno parzialmente confermato l’esistenza<br />
di rapporti commerciali fra le due zone: in<br />
una sala da banchetto è stata infatti rinvenuta<br />
una coppa a vernice nera su cui è dipinta<br />
un’acclamazione di Agatocle Sotèr (DE<br />
CARO 2006, p. 15).<br />
SALTERNUM<br />
15 MALAISE 1972b, pp. 275-282; DUNAND<br />
1973, vol. II, pp.83-115; TURCAN 1989, pp.<br />
82-85; sui templi isiaci a Delo cfr. BRUNEAU<br />
- DUCAT 1983, pp. 219-221; BRUNEAU -<br />
DUCAT 2005, pp. 58-60; 277-279.<br />
16 MALAISE 1972 b , pp. 282-311.<br />
17 Id., ibidem, pp. 259, 330-332.<br />
18 Id., ibidem, p. 306.<br />
19<br />
MALAISE 1972b, pp. 268-269; HATZFELD<br />
1909, pp. 31-36; HATZFELD 1912, pp. 5-218.<br />
20 b<br />
MALAISE 1972 , p. 274.<br />
21 Appiano, Guerre Mitridatiche, 28; cfr. anche<br />
MALAISE 1972b , pp. 265, 270-275; DUNAND<br />
1973, vol. II, pp. 98-99.<br />
22 Festo, grammatico <strong>del</strong> II sec. d. C., riassume<br />
un passo di Verrio Flacco, erudito di età<br />
augustea: «MINOREM DELUM Puteolos esse<br />
dixerunt, quod Delos aliquando maximum emporium<br />
fuerit totoius orbis terrarum; cui successit<br />
postea Puteolanum, quod municipiul Graecum<br />
antea ∆ικαιαρχ α vocitatum est. Unde Lucilius:<br />
“Inde Dicaearcheum populos, Delumque minorem».<br />
Verrio Flacco spiega in questo modo un<br />
passo di Lucilio databile fra il 119 a. C. e il<br />
102 a. C. ca., contenuto nel libro III <strong>del</strong>le<br />
Satire (Fr. 123 Marx), in cui la città flegrea,<br />
indicata con l’antico nome greco, è chiamata<br />
appunto Delum Minor cioè Delo minore o<br />
anche, secondo l’interpretazione di Zevi,<br />
‘seconda’ Delo, perché fiorita insieme a<br />
questa e sopravvissuta, commercialmente, al<br />
tracollo economico <strong>del</strong>l’isola di Apollo<br />
(ZEVI 2006, p. 74).<br />
23<br />
ZEVI 2006, pp. 74-75.<br />
24 Questa parte è da considerarsi completamento<br />
di VERGINEO 2007, articolo tratto<br />
dalla Tesi di Laurea discussa dallo scrivente<br />
nel 2006, avente per oggetto lo studio <strong>del</strong><br />
culto di Iside a Benevento (Relatore:<br />
prof.ssa C. Lambert; Correlatore: prof.ssa<br />
E. Mugione).<br />
25 Sui contatti fra Egitto e Campania nell’età<br />
pre-romana cfr. DE SALVIA 2006, pp. 21-55.<br />
26 CIL X, 1793; cfr. anche TRAN TAM TINH<br />
1972, pp. 3-6; 58-62; Tav. XXVII-XXVIII;<br />
Egittomania 2006, p. 77, Tav. II.1.<br />
27 In base agli indizi contenuti nella lex, il<br />
Wiegand ha ricostruito la posizione <strong>del</strong>l’edificio<br />
sacro rispetto al mare; cfr. anche DUBOIS<br />
1907, p. 196; tale ricostruzione è contestata in<br />
TRAN TAM TINH 1972, pp. 3-6).<br />
28 Si pensi alle nozze, celebrate secondo la tradizione<br />
faraonica, che unirono Tolomeo II<br />
Fila<strong>del</strong>fo e la sorella Arsinoe II, secondo un’usanza<br />
che sarà poi ripresa da molti dei Lagidi.<br />
- 44 -<br />
29<br />
TURCAN 1989, pp. 76-77.<br />
30 Plutarco, De Iside et Osiride, 28; Tacito,<br />
Storie, IV, 83; TRAN TAM TINH 1964, p. 66.<br />
31 Fig. 1.<br />
32 b<br />
MALAISE 1972 , pp. 182; 191-198.<br />
33 b<br />
MALAISE 1972 , p. 197.<br />
34 Fig. 1.<br />
35<br />
ZEVI 2006, p. 75, appoggia la ricostruzione<br />
di WIEGAND 1894, che qui si propone,<br />
contrapposta a quella di TRAN TAM TINH<br />
1964 in cui la strada separa non l’aedes dall’area<br />
ma tutto il templum dal mare.<br />
36 Fig. 2.<br />
37 Vitruvio, I, 7, 1.<br />
38 Le posizioni di diversi studiosi che appoggiano<br />
questa teoria sono riassunte in TRAN<br />
TAM TINH 1972, pp. 6-11.<br />
39 L’dentificazione di Helios con Serapide<br />
avviene sotto il regno di Domiziano, durante<br />
il quale Heliosarapis appare per la prima<br />
volta sulle monete alessandrine (92 d. C.); in<br />
età adrianea fa la sua comparsa il tipo di<br />
Serapide con Kalathos e testa radiata (cfr.<br />
TRAN TAM TINH 1972, pp. 18-19).<br />
40 Inv. 8945 (DEONNA 1924, n. 71).<br />
41<br />
RACHON 1912, n. 29.<br />
42 b<br />
MALAISE 1972 , pp. 159-216 raccoglie le<br />
seguenti statistiche, basate sul totale <strong>del</strong>le<br />
iscrizioni a lui note: i fe<strong>del</strong>i ad Iside sono per<br />
il 70% ca. Latini e per il restante 30% ca. di<br />
provenienza greco-orientale; gli adoratori di<br />
Serapide sono invece il 36% ca. latini e per<br />
64% ca. orientali).<br />
43 Iside Pelagia o Pharia da Pharos, isola presso<br />
Alessandria, era la dea <strong>del</strong>la navigazione e<br />
protettrice dei marinai. La sua iconografia<br />
completa è nota solo da un rilievo proveniente<br />
da Delo, in cui è mostrata in piedi<br />
sulla prora di una nave nell’atto di gonfiare<br />
il mantello per utilizzarlo alla stregua di vela<br />
(BRUNEAU 1974, p. 342, fig. 4), da alcune<br />
monete di periodi diversi, da alcune lucerne<br />
(per un elenco completo <strong>del</strong>le raffigurazioni<br />
– accertate o presunte - di Iside Pelagia, cfr.<br />
BRUNEAU 1974). Non abbiamo statue o altri<br />
rilievi - interpretati come epiclesi <strong>del</strong>la dea -<br />
in cui siano presenti la figura femminile e la<br />
nave: a Budapest è conservata una statua,<br />
proveniente da Posillipo (vedi infra, Iside a<br />
Napoli e fig. 12), simile a quella di Pozzuoli<br />
seppur di qualità molto più elevata; si data<br />
all’età augustea (cfr. SZILAGYI 1969;<br />
Egittomania 2006, p. 73). Stefania Adamo<br />
Muscettola ha recentemente identificato una<br />
statua di Ostia come Isis-Pelagia, fornendone