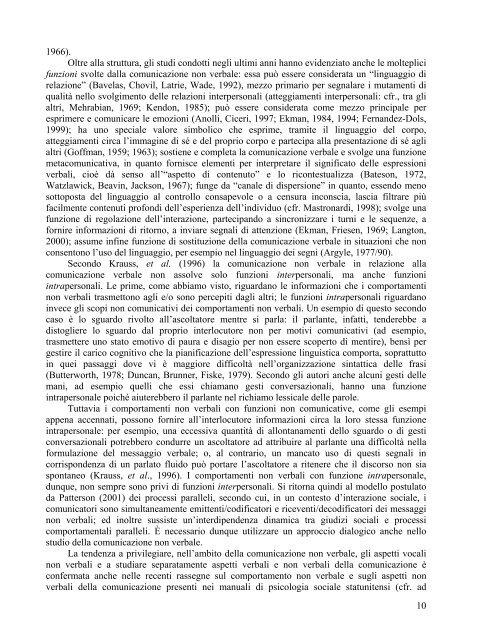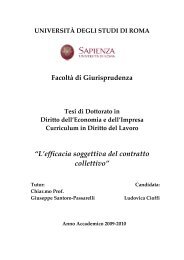Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1966).<br />
Oltre alla struttura, gli stu<strong>di</strong> condotti negli ultimi anni hanno evidenziato anche le molteplici<br />
funzioni svolte dalla comunicazione non verbale: essa può essere considerata un “linguaggio <strong>di</strong><br />
relazione” (Bavelas, Chovil, Latrie, Wade, 1992), mezzo primario per segnalare i mutamenti <strong>di</strong><br />
qualità nello svolgimento delle relazioni interpersonali (atteggiamenti interpersonali: cfr., tra gli<br />
altri, Mehrabian, 1969; Kendon, 1985); può essere considerata come mezzo principale per<br />
esprimere e comunicare le emozioni (Anolli, Ciceri, 1997; Ekman, 1984, 1994; Fernandez-Dols,<br />
1999); ha uno speciale valore simbolico che esprime, tramite il linguaggio del corpo,<br />
atteggiamenti circa l’immagine <strong>di</strong> sé e del proprio corpo e partecipa alla presentazione <strong>di</strong> sé agli<br />
altri (Goffman, 1959; 1963); sostiene e completa la comunicazione verbale e svolge una funzione<br />
metacomunicativa, in quanto fornisce elementi per interpretare il significato delle espressioni<br />
verbali, cioè dà senso all’“aspetto <strong>di</strong> contenuto” e lo ricontestualizza (Bateson, 1972,<br />
Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967); funge da “canale <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione” in quanto, essendo meno<br />
sottoposta del linguaggio al controllo consapevole o a censura inconscia, lascia filtrare più<br />
facilmente contenuti profon<strong>di</strong> dell’esperienza dell’in<strong>di</strong>viduo (cfr. Mastronar<strong>di</strong>, 1998); svolge una<br />
funzione <strong>di</strong> regolazione dell’interazione, partecipando a sincronizzare i turni e le sequenze, a<br />
fornire informazioni <strong>di</strong> ritorno, a inviare segnali <strong>di</strong> attenzione (Ekman, Friesen, 1969; Langton,<br />
2000); assume infine funzione <strong>di</strong> sostituzione della comunicazione verbale in situazioni che non<br />
consentono l’uso del linguaggio, per esempio nel linguaggio dei segni (Argyle, 1977/90).<br />
Secondo Krauss, et al. (1996) la comunicazione non verbale in relazione alla<br />
comunicazione verbale non assolve solo funzioni interpersonali, ma anche funzioni<br />
intrapersonali. Le prime, come abbiamo visto, riguardano le informazioni che i comportamenti<br />
non verbali trasmettono agli e/o sono percepiti dagli altri; le funzioni intrapersonali riguardano<br />
invece gli scopi non comunicativi dei comportamenti non verbali. Un esempio <strong>di</strong> questo secondo<br />
caso è lo sguardo rivolto all’ascoltatore mentre si parla: il parlante, infatti, tenderebbe a<br />
<strong>di</strong>stogliere lo sguardo dal proprio interlocutore non per motivi comunicativi (ad esempio,<br />
trasmettere uno stato emotivo <strong>di</strong> paura e <strong>di</strong>sagio per non essere scoperto <strong>di</strong> mentire), bensì per<br />
gestire il carico cognitivo che la pianificazione dell’espressione linguistica comporta, soprattutto<br />
in quei passaggi dove vi è maggiore <strong>di</strong>fficoltà nell’organizzazione sintattica delle frasi<br />
(Butterworth, 1978; Duncan, Brunner, Fiske, 1979). Secondo gli autori anche alcuni gesti delle<br />
mani, ad esempio quelli che essi chiamano gesti conversazionali, hanno una funzione<br />
intrapersonale poiché aiuterebbero il parlante nel richiamo lessicale delle parole.<br />
Tuttavia i comportamenti non verbali con funzioni non comunicative, come gli esempi<br />
appena accennati, possono fornire all’interlocutore informazioni circa la loro stessa funzione<br />
intrapersonale: per esempio, una eccessiva quantità <strong>di</strong> allontanamenti dello sguardo o <strong>di</strong> gesti<br />
conversazionali potrebbero condurre un ascoltatore ad attribuire al parlante una <strong>di</strong>fficoltà nella<br />
formulazione del messaggio verbale; o, al contrario, un mancato uso <strong>di</strong> questi segnali in<br />
corrispondenza <strong>di</strong> un parlato fluido può portare l’ascoltatore a ritenere che il <strong>di</strong>scorso non sia<br />
spontaneo (Krauss, et al., 1996). I comportamenti non verbali con funzione intrapersonale,<br />
dunque, non sempre sono privi <strong>di</strong> funzioni interpersonali. Si ritorna quin<strong>di</strong> al modello postulato<br />
da Patterson (2001) dei processi paralleli, secondo cui, in un contesto d’interazione sociale, i<br />
comunicatori sono simultaneamente emittenti/co<strong>di</strong>ficatori e riceventi/deco<strong>di</strong>ficatori dei messaggi<br />
non verbali; ed inoltre sussiste un’inter<strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong>namica tra giu<strong>di</strong>zi sociali e processi<br />
comportamentali paralleli. È necessario dunque utilizzare un approccio <strong>di</strong>alogico anche nello<br />
stu<strong>di</strong>o della comunicazione non verbale.<br />
La tendenza a privilegiare, nell’ambito della comunicazione non verbale, gli aspetti vocali<br />
non verbali e a stu<strong>di</strong>are separatamente aspetti verbali e non verbali della comunicazione è<br />
confermata anche nelle recenti rassegne sul comportamento non verbale e sugli aspetti non<br />
verbali della comunicazione presenti nei manuali <strong>di</strong> psicologia sociale statunitensi (cfr. ad<br />
10