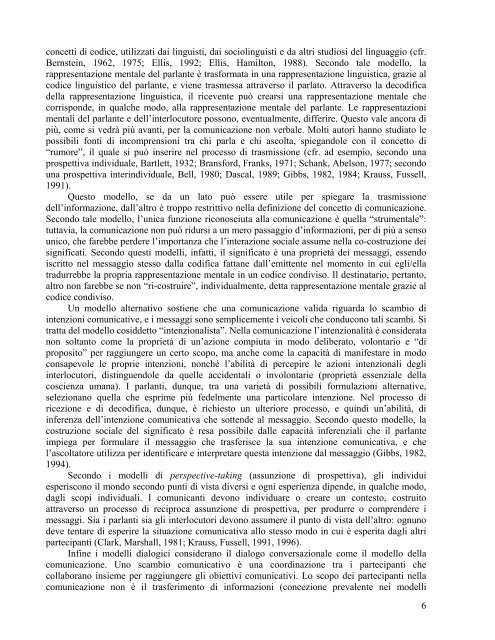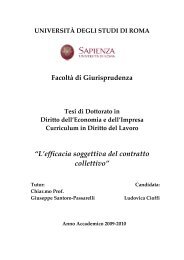Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
concetti <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce, utilizzati dai linguisti, dai sociolinguisti e da altri stu<strong>di</strong>osi del linguaggio (cfr.<br />
Bernstein, 1962, 1975; Ellis, 1992; Ellis, Hamilton, 1988). Secondo tale modello, la<br />
rappresentazione mentale del parlante è trasformata in una rappresentazione linguistica, grazie al<br />
co<strong>di</strong>ce linguistico del parlante, e viene trasmessa attraverso il parlato. Attraverso la deco<strong>di</strong>fica<br />
della rappresentazione linguistica, il ricevente può crearsi una rappresentazione mentale che<br />
corrisponde, in qualche modo, alla rappresentazione mentale del parlante. Le rappresentazioni<br />
mentali del parlante e dell’interlocutore possono, eventualmente, <strong>di</strong>fferire. Questo vale ancora <strong>di</strong><br />
più, come si vedrà più avanti, per la comunicazione non verbale. Molti autori hanno stu<strong>di</strong>ato le<br />
possibili fonti <strong>di</strong> incomprensioni tra chi parla e chi ascolta, spiegandole con il concetto <strong>di</strong><br />
“rumore”, il quale si può inserire nel processo <strong>di</strong> trasmissione (cfr. ad esempio, secondo una<br />
prospettiva in<strong>di</strong>viduale, Bartlett, 1932; Bransford, Franks, 1971; Schank, Abelson, 1977; secondo<br />
una prospettiva interin<strong>di</strong>viduale, Bell, 1980; Dascal, 1989; Gibbs, 1982, 1984; Krauss, Fussell,<br />
1991).<br />
Questo modello, se da un lato può essere utile per spiegare la trasmissione<br />
dell’informazione, dall’altro è troppo restrittivo nella definizione del concetto <strong>di</strong> comunicazione.<br />
Secondo tale modello, l’unica funzione riconosciuta alla comunicazione è quella “strumentale”:<br />
tuttavia, la comunicazione non può ridursi a un mero passaggio d’informazioni, per <strong>di</strong> più a senso<br />
unico, che farebbe perdere l’importanza che l’interazione sociale assume nella co-costruzione dei<br />
significati. Secondo questi modelli, infatti, il significato è una proprietà dei messaggi, essendo<br />
iscritto nel messaggio stesso dalla co<strong>di</strong>fica fattane dall’emittente nel momento in cui egli/ella<br />
tradurrebbe la propria rappresentazione mentale in un co<strong>di</strong>ce con<strong>di</strong>viso. Il destinatario, pertanto,<br />
altro non farebbe se non “ri-costruire”, in<strong>di</strong>vidualmente, detta rappresentazione mentale grazie al<br />
co<strong>di</strong>ce con<strong>di</strong>viso.<br />
Un modello alternativo sostiene che una comunicazione valida riguarda lo scambio <strong>di</strong><br />
intenzioni comunicative, e i messaggi sono semplicemente i veicoli che conducono tali scambi. Si<br />
tratta del modello cosiddetto “intenzionalista”. Nella comunicazione l’intenzionalità è considerata<br />
non soltanto come la proprietà <strong>di</strong> un’azione compiuta in modo deliberato, volontario e “<strong>di</strong><br />
proposito” per raggiungere un certo scopo, ma anche come la capacità <strong>di</strong> manifestare in modo<br />
consapevole le proprie intenzioni, nonché l’abilità <strong>di</strong> percepire le azioni intenzionali <strong>degli</strong><br />
interlocutori, <strong>di</strong>stinguendole da quelle accidentali o involontarie (proprietà essenziale della<br />
coscienza umana). I parlanti, dunque, tra una varietà <strong>di</strong> possibili formulazioni alternative,<br />
selezionano quella che esprime più fedelmente una particolare intenzione. Nel processo <strong>di</strong><br />
ricezione e <strong>di</strong> deco<strong>di</strong>fica, dunque, è richiesto un ulteriore processo, e quin<strong>di</strong> un’abilità, <strong>di</strong><br />
inferenza dell’intenzione comunicativa che sottende al messaggio. Secondo questo modello, la<br />
costruzione sociale del significato è resa possibile dalle capacità inferenziali che il parlante<br />
impiega per formulare il messaggio che trasferisce la sua intenzione comunicativa, e che<br />
l’ascoltatore utilizza per identificare e interpretare questa intenzione dal messaggio (Gibbs, 1982,<br />
1994).<br />
Secondo i modelli <strong>di</strong> perspective-taking (assunzione <strong>di</strong> prospettiva), gli in<strong>di</strong>vidui<br />
esperiscono il mondo secondo punti <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>versi e ogni esperienza <strong>di</strong>pende, in qualche modo,<br />
dagli scopi in<strong>di</strong>viduali. I comunicanti devono in<strong>di</strong>viduare o creare un contesto, costruito<br />
attraverso un processo <strong>di</strong> reciproca assunzione <strong>di</strong> prospettiva, per produrre o comprendere i<br />
messaggi. Sia i parlanti sia gli interlocutori devono assumere il punto <strong>di</strong> vista dell’altro: ognuno<br />
deve tentare <strong>di</strong> esperire la situazione comunicativa allo stesso modo in cui è esperita dagli altri<br />
partecipanti (Clark, Marshall, 1981; Krauss, Fussell, 1991, 1996).<br />
Infine i modelli <strong>di</strong>alogici considerano il <strong>di</strong>alogo conversazionale come il modello della<br />
comunicazione. Uno scambio comunicativo è una coor<strong>di</strong>nazione tra i partecipanti che<br />
collaborano insieme per raggiungere gli obiettivi comunicativi. Lo scopo dei partecipanti nella<br />
comunicazione non è il trasferimento <strong>di</strong> informazioni (concezione prevalente nei modelli<br />
6