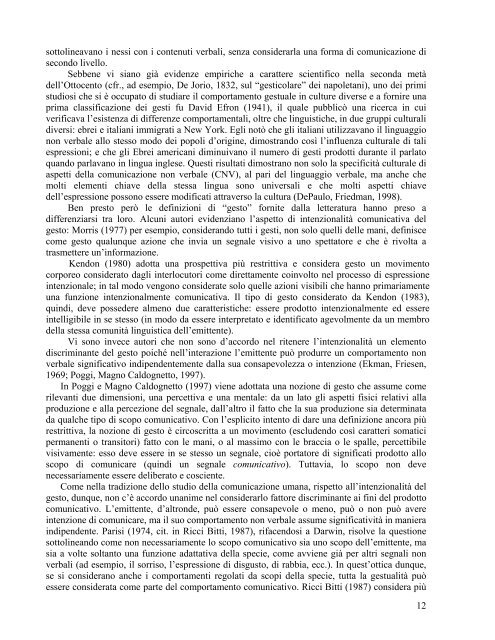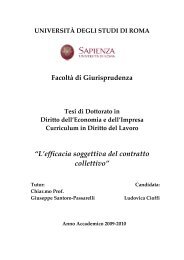Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Padis
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
sottolineavano i nessi con i contenuti verbali, senza considerarla una forma <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong><br />
secondo livello.<br />
Sebbene vi siano già evidenze empiriche a carattere scientifico nella seconda metà<br />
dell’Ottocento (cfr., ad esempio, De Jorio, 1832, sul “gesticolare” dei napoletani), uno dei primi<br />
stu<strong>di</strong>osi che si è occupato <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are il comportamento gestuale in culture <strong>di</strong>verse e a fornire una<br />
prima classificazione dei gesti fu David Efron (1941), il quale pubblicò una ricerca in cui<br />
verificava l’esistenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze comportamentali, oltre che linguistiche, in due gruppi culturali<br />
<strong>di</strong>versi: ebrei e italiani immigrati a New York. Egli notò che gli italiani utilizzavano il linguaggio<br />
non verbale allo stesso modo dei popoli d’origine, <strong>di</strong>mostrando così l’influenza culturale <strong>di</strong> tali<br />
espressioni; e che gli Ebrei americani <strong>di</strong>minuivano il numero <strong>di</strong> gesti prodotti durante il parlato<br />
quando parlavano in lingua inglese. Questi risultati <strong>di</strong>mostrano non solo la specificità culturale <strong>di</strong><br />
aspetti della comunicazione non verbale (CNV), al pari del linguaggio verbale, ma anche che<br />
molti elementi chiave della stessa lingua sono universali e che molti aspetti chiave<br />
dell’espressione possono essere mo<strong>di</strong>ficati attraverso la cultura (DePaulo, Friedman, 1998).<br />
Ben presto però le definizioni <strong>di</strong> “gesto” fornite dalla letteratura hanno preso a<br />
<strong>di</strong>fferenziarsi tra loro. Alcuni autori evidenziano l’aspetto <strong>di</strong> intenzionalità comunicativa del<br />
gesto: Morris (1977) per esempio, considerando tutti i gesti, non solo quelli delle mani, definisce<br />
come gesto qualunque azione che invia un segnale visivo a uno spettatore e che è rivolta a<br />
trasmettere un’informazione.<br />
Kendon (1980) adotta una prospettiva più restrittiva e considera gesto un movimento<br />
corporeo considerato dagli interlocutori come <strong>di</strong>rettamente coinvolto nel processo <strong>di</strong> espressione<br />
intenzionale; in tal modo vengono considerate solo quelle azioni visibili che hanno primariamente<br />
una funzione intenzionalmente comunicativa. Il tipo <strong>di</strong> gesto considerato da Kendon (1983),<br />
quin<strong>di</strong>, deve possedere almeno due caratteristiche: essere prodotto intenzionalmente ed essere<br />
intelligibile in se stesso (in modo da essere interpretato e identificato agevolmente da un membro<br />
della stessa comunità linguistica dell’emittente).<br />
Vi sono invece autori che non sono d’accordo nel ritenere l’intenzionalità un elemento<br />
<strong>di</strong>scriminante del gesto poiché nell’interazione l’emittente può produrre un comportamento non<br />
verbale significativo in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua consapevolezza o intenzione (Ekman, Friesen,<br />
1969; Poggi, Magno Caldognetto, 1997).<br />
In Poggi e Magno Caldognetto (1997) viene adottata una nozione <strong>di</strong> gesto che assume come<br />
rilevanti due <strong>di</strong>mensioni, una percettiva e una mentale: da un lato gli aspetti fisici relativi alla<br />
produzione e alla percezione del segnale, dall’altro il fatto che la sua produzione sia determinata<br />
da qualche tipo <strong>di</strong> scopo comunicativo. Con l’esplicito intento <strong>di</strong> dare una definizione ancora più<br />
restrittiva, la nozione <strong>di</strong> gesto è circoscritta a un movimento (escludendo così caratteri somatici<br />
permanenti o transitori) fatto con le mani, o al massimo con le braccia o le spalle, percettibile<br />
visivamente: esso deve essere in se stesso un segnale, cioè portatore <strong>di</strong> significati prodotto allo<br />
scopo <strong>di</strong> comunicare (quin<strong>di</strong> un segnale comunicativo). Tuttavia, lo scopo non deve<br />
necessariamente essere deliberato e cosciente.<br />
Come nella tra<strong>di</strong>zione dello stu<strong>di</strong>o della comunicazione umana, rispetto all’intenzionalità del<br />
gesto, dunque, non c’è accordo unanime nel considerarlo fattore <strong>di</strong>scriminante ai fini del prodotto<br />
comunicativo. L’emittente, d’altronde, può essere consapevole o meno, può o non può avere<br />
intenzione <strong>di</strong> comunicare, ma il suo comportamento non verbale assume significatività in maniera<br />
in<strong>di</strong>pendente. Parisi (1974, cit. in Ricci Bitti, 1987), rifacendosi a Darwin, risolve la questione<br />
sottolineando come non necessariamente lo scopo comunicativo sia uno scopo dell’emittente, ma<br />
sia a volte soltanto una funzione adattativa della specie, come avviene già per altri segnali non<br />
verbali (ad esempio, il sorriso, l’espressione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sgusto, <strong>di</strong> rabbia, ecc.). In quest’ottica dunque,<br />
se si considerano anche i comportamenti regolati da scopi della specie, tutta la gestualità può<br />
essere considerata come parte del comportamento comunicativo. Ricci Bitti (1987) considera più<br />
12